La nostra storia
La nostra storia
Nel 1919 nasce la Federazione Industriale Lombarda, espressione di lungimiranza e determinazione, che ha guidato l'industria della Grande Milano e il suo tessuto sociale verso trasformazioni continue. Ai cambiamenti Assolombarda ha saputo adattarsi, mettendo al centro solidità, sviluppo e collaborazione. Il restauro del Palazzo progettato da Gio Ponti e l'apertura del primo asilo nido del sistema Confindustria sono le ultime manifestazioni di un impegno costante. La storia si trasforma in un racconto polifonico che celebra l'incontro tra tradizione e innovazione, impresa e comunità.
↓Scorri per approfondire↓
I valori e gli interessi «per il trionfo del lavoro e dell’industria»
Lunedì, 10 febbraio, 19191. La notizia era in terza colonna a pagina 3 tra il lancio di una nuova sottoscrizione popolare per gli ex combattenti e un breve articolo sul sussidio destinato ai profughi veneti: come scriveva il «Corriere della Sera», «nel Salone della Società del Giardino [...] si sono riuniti ieri [9 febbraio] nel pomeriggio numerosi industriali di Milano e Lombardia per costituire la Federazione Industriale Lombarda».
A presiedere l’incontro il commendatore Giovanni Silvestri che nel suo discorso inaugurale aveva detto: «Gli industriali si sono riuniti per salire un gradino della scala che porta al giusto riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri per il trionfo del lavoro e dell’industria italiana». Il noto industriale, proprietario delle Officine meccaniche Miani e Silvestri e tra i fondatori dell’Associazione degli industriali meccanici, aveva poi sottolineato come «c’era voluta la guerra» per insegnare agli industriali la necessità di un unico indirizzo organizzativo sempre più indispensabile nelle questioni sindacali e nei rapporti con il governo, con le autorità locali e in campo internazionale. L’incontro asilo Società del Giardino era stato preceduto da una riunione, tenutasi il 12 gennaio in quella che diventerà la sede provvisoria della Federazione in via Tommaso Grossi n. 2.
Alla presenza di alcuni tra i maggiori industriali milanesi, tra cui Giovanni Battista Pirelli, Giorgio Enrico Falck, Raimondo Targetti e lo stesso Silvestri, era stato deciso che la nuova associazione avrebbe dovuto tutelare «gli interessi di indole generale delle varie categorie di industriali [...] senza invadere il campo d’azione delle associazioni nazionali e dei consorzi sindacali locali» e soprattutto che sarebbe presto entrata a far parte della Confederazione generale dell’industria italiana. Alla presidenza della Federazione Industriale Lombarda veniva chiamato Carlo Vanzetti, fondatore della Fonderia milanese di acciaio, coadiuvato dai quattro Vicepresidenti – Antonio Stefano Benni, Giacinto Motta, Carlo Tarlarini e Raimondo Targetti – che rappresentavano i settori di punta dell’economia lombarda, dall’elettrico al meccanico passando per il tessile.
La Federazione Industriale Lombarda costituita, in «Corriere della Sera», 10 febbraio 1919, p. 3; cfr. anche La nuova Federazione Industriale Lombarda, in «Corriere della Sera», 9 febbraio 1919, p. 3.
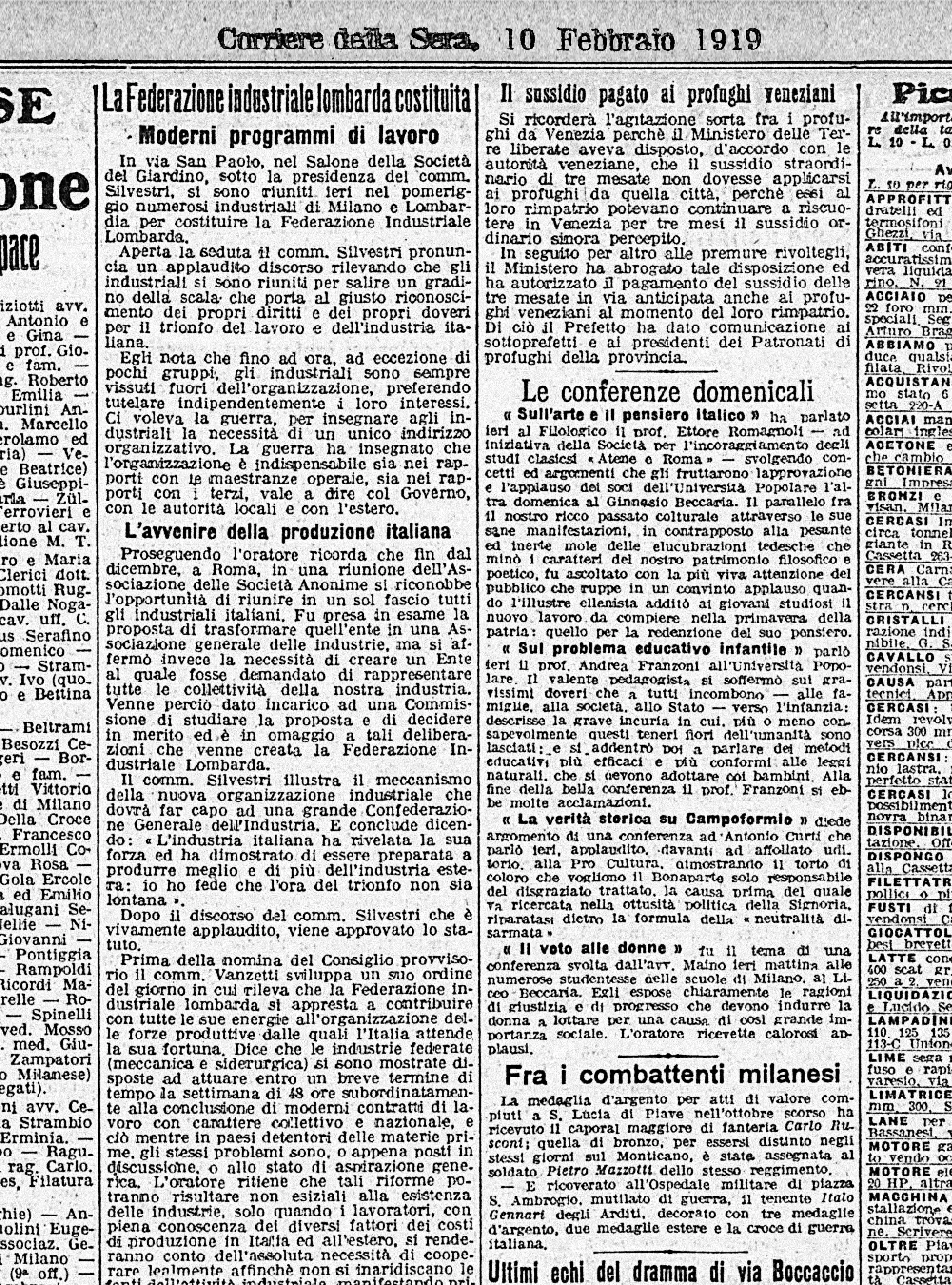
Il Traforo del Gottardo e l’Esposizione universale sono i simboli della crescita
La Federazione nasceva a pochi mesi dalla fine del primo conflitto mondiale in un clima che dal punto di vista economico e sociale si profilava incerto e difficile. Milano era una città in rapida e constante trasformazione e il “peso” dell’industria si era fatto via via più importante. Secondo il Censimento industriale del 1911, poco meno del 10% degli operai italiani lavorava negli stabilimenti dell’area milanese.
Il decollo industriale era iniziato sul finire dell’Ottocento e nel 1903 Milano aveva già superato il mezzo milione di abitanti: ben 200 mila in più rispetto a vent’anni prima. Il capoluogo lombardo esercitava un forte richiamo non solo per gli abitanti della provincia milanese ma anche per coloro che provenivano da altre province del Regno, in particolare dalle zone depresse della Lombardia e del Veneto. Molti confluivano in fabbrica: nel 1910 l’industria assorbiva il 34% dei lavoratori milanesi e gli stabilimenti nascevano in diversi punti della città. A sud, le imprese – come per esempio le Officine meccaniche Riva e la Richard Ginori – si raggruppavano intorno alla stazione di Porta Genova lungo il Naviglio grande. Poco lontano si sviluppava il polo di Porta Romana con la Tecnomasio italiano Brown Boveri e la meccanica OM. Quasi dalla parte opposta, in zona Sempione, attorno al grande asse viario che conduceva ai laghi, ai valichi e alle gallerie alpine – si pensi al San Gottardo (1883) e al Traforo del Sempione inaugurato nel 1905 e festeggiato a Milano, l’anno seguente, con l’Esposizione internazionale – si insediava l’industria automobilistica con l’Isotta Fraschini, il primo nucleo dell’Alfa e l’Edoardo Bianchi. A nord, infine, sarebbero apparsi due distinti nuclei di concentrazione industriale: lungo la linea del San Gottardo si sviluppava Sesto San Giovanni con la Pirelli, la Falck, la Breda e la Magneti Marelli, mentre nei quartieri della Bovisa e di Dergano aprivano diverse aziende chimiche e farmaceutiche, tra cui la Carlo Erba, la Lepetit e un’officina della Montecatini.

Corso del Littorio, oggi corso Matteotti, Milano, 1926-1934. Civico Archivio Fotografico, Comune di Milano.
Milano si avviava a diventare la capitale economica del Paese grazie anche alla presenza di una parte considerevole delle imprese italiane che, in quella fase di rapido sviluppo tecnologico e produttivo, animavano il processo di crescita, aiutate in questo da potenti fattori di localizzazione. A cominciare dalla capillare ed efficiente rete di trasporti, dagli storici collegamenti internazionali e da quel tessuto variegato di piccole e medie imprese che si andavano ad affiancare alle grandi. Milano era anche il centro di un articolato sistema finanziario in grado di attirare gli investitori internazionali.
Non a caso, nell’ottobre del 1894, era nata la Banca Commerciale Italiana con capitali esclusivamente stranieri, in primo luogo tedeschi, poi austriaci e svizzeri. Primo esempio di banca universale operante a breve, medio e lungo termine, la COMIT sarà, insieme al Credito Italiano, decisiva nello sviluppo industriale in Italia. Milano era anche la sede di prestigiose istituzioni culturali portatrici e produttrici di avanzate competenze tecnico-scientifiche. Due fra tutte: il Politecnico creato nel 1863 e l’Università Commerciale Luigi Bocconi fondata nel 1903, nell’odierno largo Treves, dall’imprenditore milanese Ferdinando Bocconi in memoria del figlio primogenito morto2.
Cfr. Germano Maifreda, Lavoro e fabbrica nella Milano del XX secolo, in Germano Maifreda, Geoffrey Pizzorni, Ferruccio Ricciardi, Lavoro e società nella Milano del Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 23-26, 38-45, 104-109, e Geoffrey Pizzorni, Un Novecento milanese. Aspetti quantitativi di un secolo di vita economica e sociale, ivi, pp. 249 ss.
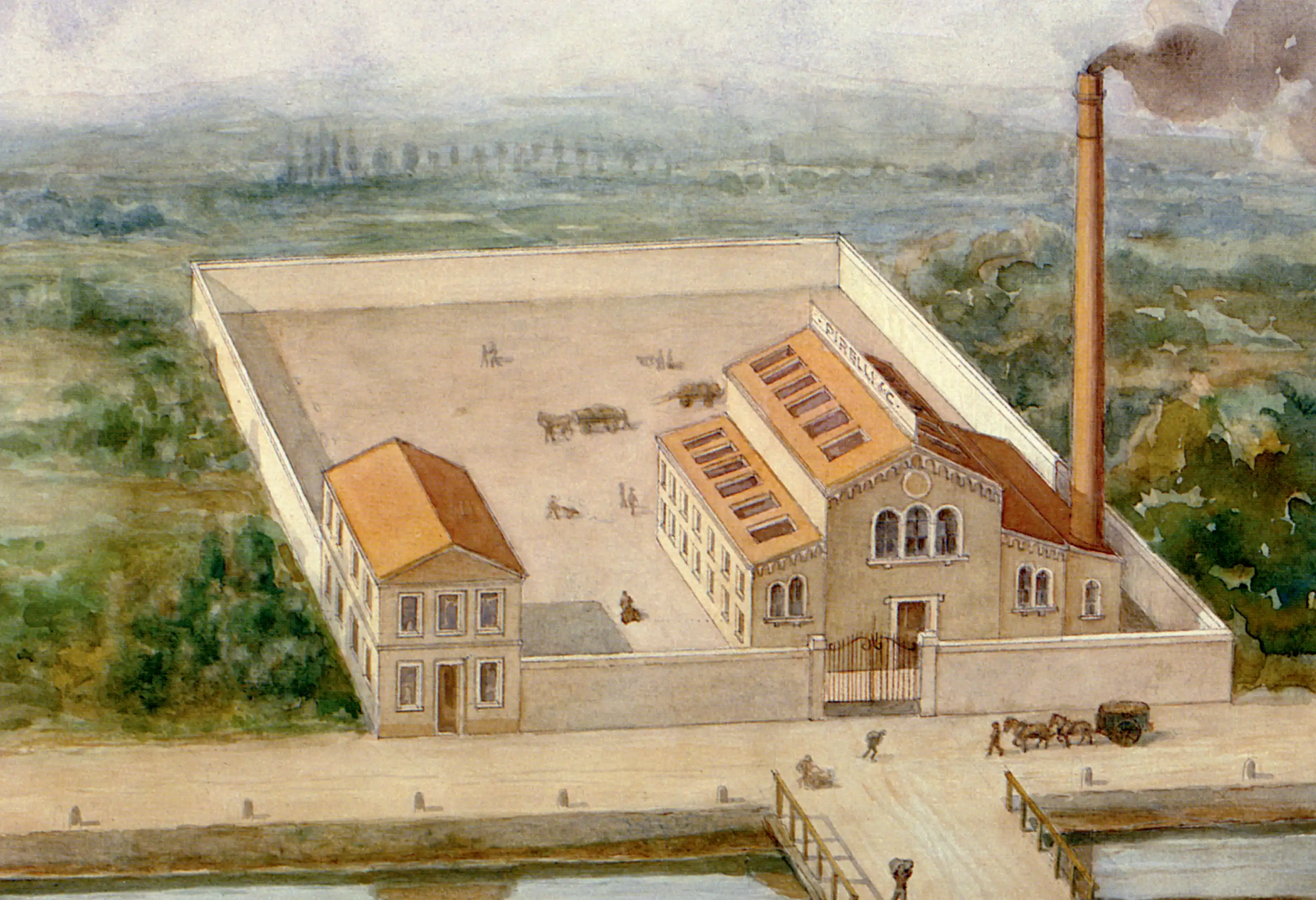
Il primo stabilimento Pirelli a Milano nel 1873, replica di Salvatore Corvaja del 1922. Fondazione Pirelli.
L’industria si riconverte all’economia di pace: al centro meccanica e tessile
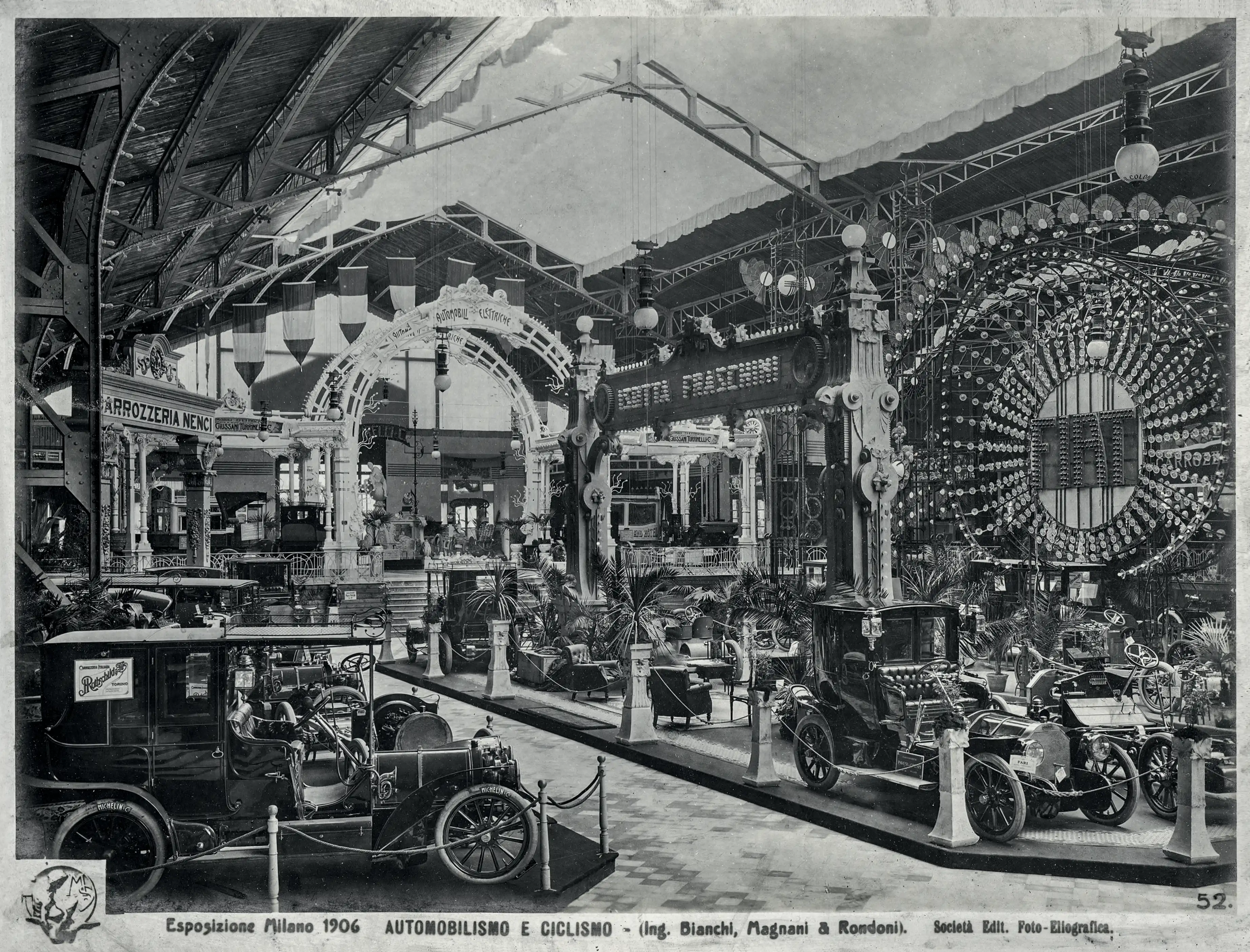
Sala interna del padiglione dell’automobilismo e ciclismo all’Esposizione di Milano del 1906. Archivio Fondazione Fiera Milano.
Al momento della costituzione del Consorzio, il capoluogo lombardo ospitava già diverse organizzazioni di categoria, tra cui l’Associazione serica italiana, fondata nel 1877, e l’Associazione cotoniera italiana, nata nel 1893. A queste, nel periodo precedente allo scoppio della Prima guerra mondiale, si aggiunsero le associazioni dei produttori italiani di saponi (1902), dei fabbricanti di birra (1907) e, all’inizio del 1914, l’Associazione nazionale fra gli industriali meccanici e affini (ANIMA), destinata a diventare una delle maggiori organizzazioni imprenditoriali nazionali3.
La riconversione da un’economia di guerra a una di pace si accompagnava a una maggiore penetrazione e al consolidamento del sistema di rappresentanza. L’acuirsi dello scontro con i lavoratori e le loro organizzazioni e le generali difficoltà economiche contribuirono tra l’altro a proiettare Milano al vertice dell’associazionismo imprenditoriale italiano. Era un’epoca che si caratterizzava per un notevole spirito associativo e la città ambrosiana ne diventò il simbolo. Soltanto tra la fine del 1918 e il 1923, infatti, venivano costituite una quarantina circa di organizzazioni industriali insieme a diversi consorzi d’imprese impegnate a superare le ristrettezze connesse agli approvvigionamenti di materie prime.
Cfr. Geoffrey Pizzorni, Associazionismo imprenditoriale milanese tra i due dopoguerra (1919-1950). Primi risultati di ricerca, Brescia, C.L.U.B., 2004, pp. 5 ss., e Leo Vidotto, L’organizzazione industriale lombarda nell’ultimo cinquantennio, Milano, Grafiche Stucchi, 1959.
Gli imprenditori milanesi sono motore della crescita di Confindustria
Valerio Castronovo, Cento anni di imprese. Storia di Confindustria (1910-2010), Roma- Bari, Laterza, 2010, pp. 65 ss.

Visita del Re Vittorio Emanuele III alla Fiera Campionaria di Milano 1922. Archivio Fondazione Fiera Milano.
Alla fine del 1918, appariva chiaro che la Confederazione andava rinnovata. Il nuovo corso si concretizzava con il trasferimento della sede nella capitale, seguito dal rapido ampliamento della struttura centrale ospitata nei nuovi uffici di piazza Venezia. Lo scopo prioritario della rinnovata Confederazione era la tutela della produzione e degli interessi nazionali di una categoria economica, quella degli industriali, che, secondo il Presidente Dante Ferraris, aveva avuto il merito di «aver condotto il Paese alla vittoria». Alla nuova Confindustria aderivano 50 associazioni, territoriali e di categoria, in rappresentanza di 6.000 aziende industriali, tre volte tante rispetto al 1910. I settori meccanico e metallurgico erano i più rappresentati, seguiti da quelli tessile, dei trasporti e dai comparti chimico ed elettrico.
Il legame tra la Confederazione e il mondo industriale lombardo si confermava molto stretto, a cominciare dai sei rappresentanti entrati a far parte della giunta, due in più dei genovesi e tre in più dei torinesi. Del resto, la Lombardia annoverava 10 associazioni territoriali e 17 di categoria su un totale nazionale di 83 sodalizi aderenti alla Confederazione. L’imprenditoria milanese, infine, avrebbe espresso, in questo primo periodo, diversi Presidenti, a partire da Giovanni Battista Pirelli, Giovanni Silvestri, Ettore Conti e Raimondo Targetti, tra il 1922 e il 1923.
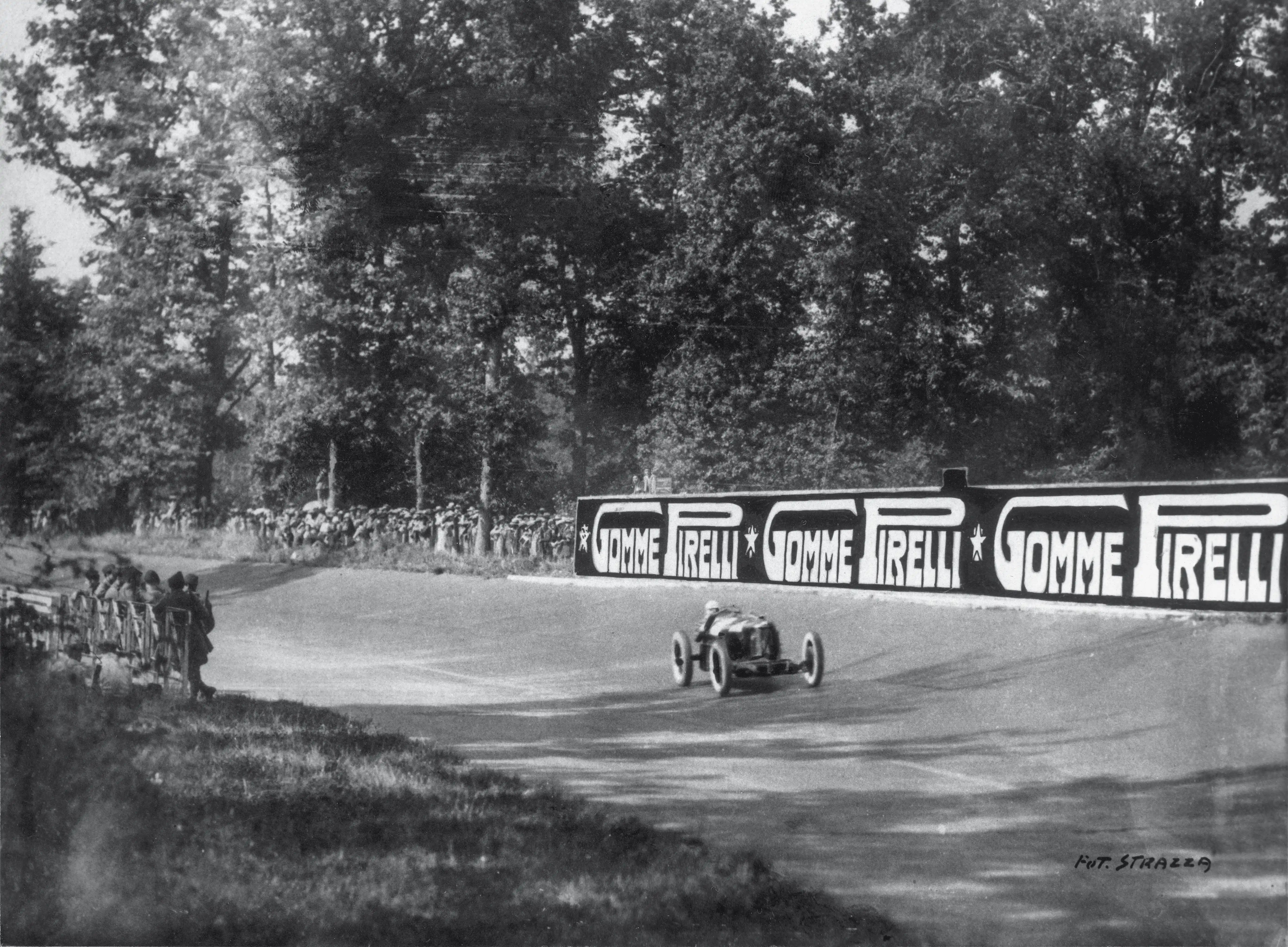
Il pilota Gastone Brilli Peri all’Autodromo di Monza, 1925. Fondazione Pirelli.
Gli anni difficili per fare fronte alle crescenti proteste sindacali e alle pesanti tariffe doganali
Cfr. Dante Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa dall’archivio Assolombarda, Milano, Edizioni Industria Lombarda, 1988, pp. 37 ss.; Presentazione, in «L’Industria Lombarda», 1° febbraio 1922, p. 1; Relazione sull’opera compiuta dalla Federazione Industriale Lombarda nell’anno 1921, in «L’Industria Lombarda», 1° maggio 1922, p. 1.

Giornate di sciopero generale con tram occupati, Milano, 1922. Civico Archivio Fotografico, Comune di Milano.
Dal punto di vista economico e politico, i primi anni Venti non potevano di certo essere considerati un periodo facile. A incidere erano la mancata ripresa del mercato interno, un sistema fiscale distorto e il peso crescente della manodopera improduttiva che costringeva molte imprese a sopportare forti perdite. Nell’aprile del 1922, la Federazione votava un ordine del giorno con cui si chiedevano interventi concreti e si faceva presente al governo presieduto dal liberale Luigi Facta «che la classe industriale non può e non intende continuare ad assistere passivamente alla demolizione delle proprie aziende».
Un editoriale del 1° novembre 1922, a pochi giorni dalla Marcia su Roma, usciva con un titolo emblematico: In attesa della vita nuova. Al suo interno, si commentava l’ascesa al potere di Benito Mussolini attraverso «una rivoluzione senza rivolta, che si va convertendo in una fiduciosa aspettativa, nell’impressione di una possibilità di vita pubblica nuova e feconda». Sul banco degli imputati saliva lo Stato perennemente debole e in perpetua condizione di crisi e i partiti politici che pagavano il fatto di essere stati «strumenti delle agglomerazioni sindacali lanciate alla conquista dello Stato». Completavano il quadro l’immane disavanzo del bilancio statale, la “vittoria mutilata” – come l’aveva definita il Vate d’Italia Gabriele d’Annunzio – la mortificazione nazionale e il tragico senso della sterilità del sacrificio compiuto.
Gli industriali milanesi e il primo Fascismo: cauto appoggio e autonomia
L’editoriale pubblicato sul quindicinale della Federazione Industriale Lombarda non si discostava da quanto scriveva nello stesso periodo la Confederazione: Mussolini aveva dato prova di senso di responsabilità e di volontà tali da meritare il consenso per la formazione del nuovo governo. Come riporta Patrizio Bianchi, il «cinico calcolo politico» che aveva portato gli industriali ad aderire al Fascismo avrebbe affrontato la prima verifica politica con le elezioni amministrative all’inizio del 19236. Furono nove gli industriali che si candidarono per entrare a Palazzo Marino e tutti vennero eletti nel Consiglio comunale.
Nel febbraio di quell’anno, la stessa Federazione veniva chiamata a rinnovare i propri organi direttivi. Alla presidenza veniva chiamato Raimondo Targetti, coadiuvato da Antonio Stefano Benni, da poco diventato Presidente della Confederazione, da Giorgio Falck, Paolo Frigerio e Carlo Tarlarini. Il nuovo direttivo si trovava a operare in una situazione economica e sindacale molto diversa rispetto al recente passato. La vera novità era la forte crescita del sindacalismo operaio fascista che aveva portato al crollo degli scioperi e all’aumento dei salari in linea con il crescere del costo della vita.
Cfr. Patrizio Bianchi, La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità alla crisi globale, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 36-39, e D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 45 ss.
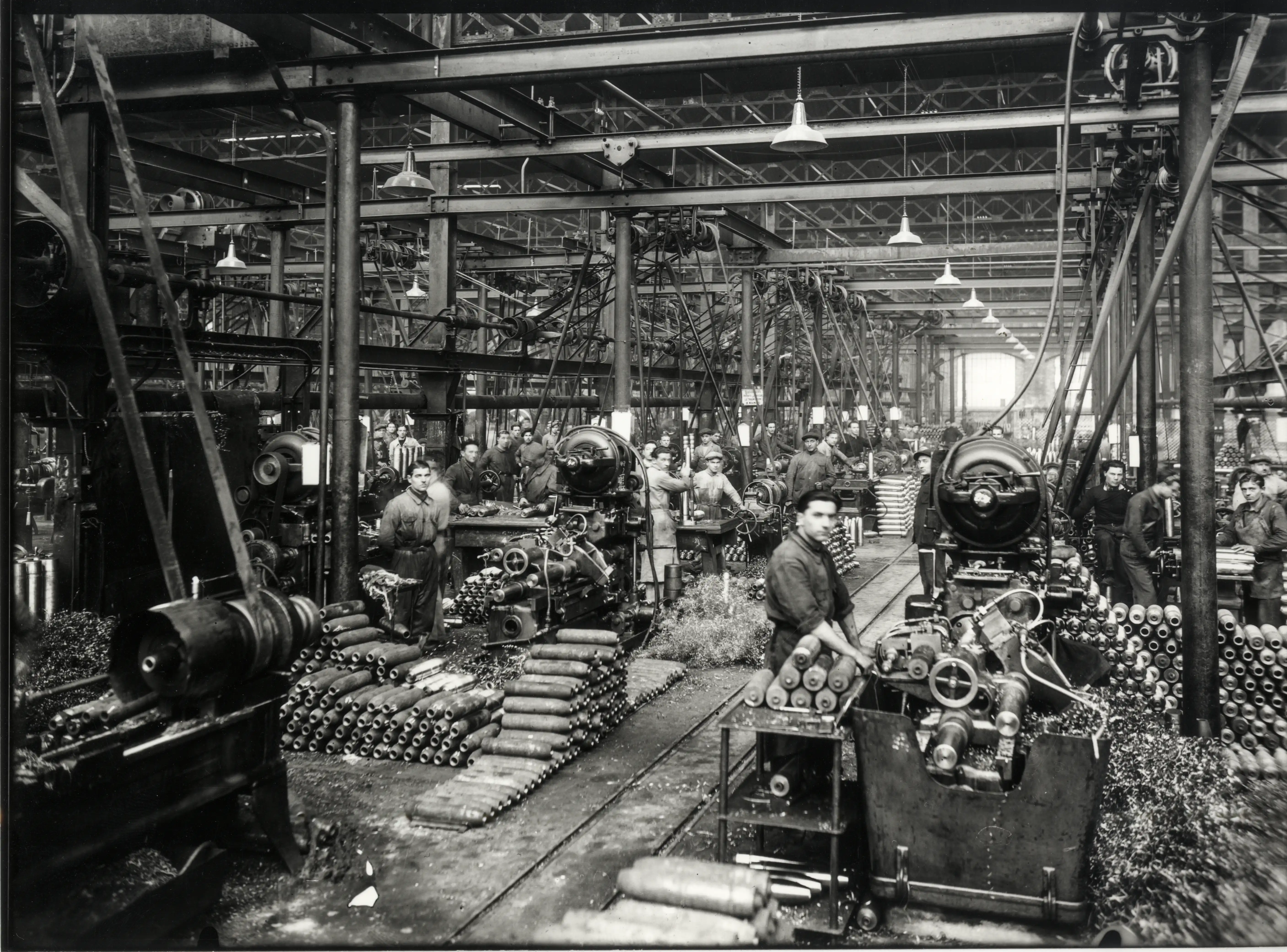
Lavorazione di proiettili di medio calibro alla Breda, Sesto San Giovanni (MI), 1920-1930. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.
Con il 1924, il sostegno degli industriali milanesi diventava meno deciso, nonostante la firma del Patto di Palazzo Chigi con cui Confederazione e sindacato fascista riconoscevano la necessità di una «collaborazione sociale» in grado di «armonizzare la propria azione con le direttive del Governo Nazionale».
L’ambiente industriale milanese era rimasto sostanzialmente diffidente e orgoglioso di mantenere una certa autonomia e la riprova era lo scarso entusiasmo dimostrato in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 1924 – definite «un dovere da compiere» – cui si erano candidati Benni e Motta che vennero eletti ma senza grandi consensi. A suscitare le critiche della Federazione era soprattutto l’entrata in vigore della giornata lavorativa di 8 ore che implicava una riorganizzazione del lavoro con costi superiori e una maggiore rigidità dei fattori produttivi. Per gli imprenditori, il governo, in cerca del più ampio consenso popolare, aveva preso misure definite «frammentarie ed anacronistiche» e avviato una politica «a strappi» che non teneva conto delle ripercussioni sul sistema economico e sociale.
Industriali e governo fascista si sarebbero trovati su posizioni discordanti anche in relazione ad altre questioni, dando talvolta vita ad accesi scontri di vedute. Tra gli argomenti più dibattuti vi era la situazione del credito e della moneta, che aveva portato, tra il 1924 e il 1925, a una Borsa che non dava segni di ripresa e all’incertezza se finanziare o meno le imprese rendendo il credito più accessibile e meno oneroso. L’aumento delle tariffe ferroviarie del 25%, motivato, per gli industriali, dall’intento di coprire le maggiori spese derivanti dagli aumenti concessi al personale ferroviario, avrebbero portato nel giugno del 1925 alla nomina a Ministro delle Finanze del veneziano Giuseppe Volpi, gradito agli ambienti industriali e finanziari, al posto di Alberto de’ Stefani, reo di una politica finanziaria troppo restrittiva.
Le “leggi fascistissime”, la fine della libertà di stampa e le nuove relazioni industriali
Il 2 ottobre 1925 veniva firmato a Roma il Patto di Palazzo Vidoni che stabiliva il riconoscimento reciproco tra la Confederazione industriale e la Confederazione delle corporazioni fasciste quali rappresentanti esclusivi di industriali e lavoratori, sancendo così l’esautoramento dei sindacati non fascisti. L’accordo rappresentava il primo passo verso una profonda trasformazione delle relazioni industriali ed entrava a pieno titolo in quell’insieme di “leggi fascistissime” con cui il Fascismo stava instaurando il regime. La soppressione della libertà sindacale era un tassello importante della nuova architettura statale al pari della supremazia del governo sul Parlamento, della limitazione della libertà di stampa e dell’inasprimento delle leggi sulla pubblica sicurezza.
Nel dicembre successivo, la Confederazione assumeva la nuova denominazione di Confederazione generale fascista dell’industria italiana non suscitando, anche questa volta, un particolare entusiasmo negli industriali raccolti nella Federazione. Anzi, proprio dalle pagine di «L’Industria Lombarda» si precisava che l’essere industriali non significava appartenere a una classe, ma assolvere un’alta funzione sociale: «Questa funzione di dirigenti noi l’abbiamo difesa e la difenderemo. Essa costituisce l’unica ragione di essere dell’industriale... non è possibile ammettere interferenze con l’autorità degli industriali quando si tratti di cardini fondamentali della loro funzione, cioè della possibilità di scegliersi i collaboratori e di attribuire le mansioni». La conclusione dell’editoriale era perentoria: «Bisogna che si comprenda anche in Italia che in materia di industria i più competenti sono coloro che dell’industria reggono le sorti e ne hanno la responsabilità».

Uomini trasportano la cassa contenente il corpo di Giacomo Matteotti ritrovato in un tunnel nei pressi di Roma, 1924. Fotografia di Albert Harlingue, collezione Roger-Viollet, Alinari.
A completare il nuovo inquadramento sindacale mancavano due passaggi importanti. Il primo, il 3 aprile 1926, fu l’approvazione della legge n. 563 sulla Disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro che sanciva legalmente il monopolio della rappresentanza ai sindacati e alle federazioni fasciste. In pratica, soltanto quelle associazioni che avessero ottenuto il “riconoscimento giuridico” avrebbero avuto personalità giuridica e con questa la rappresentanza unitaria di tutti i datori di lavoro, anche se non iscritti nelle associazioni di categoria e territoriali. Il secondo passaggio, invece, riguardava l’istituzione del Ministero delle Corporazioni avvenuta all’inizio del maggio seguente.
Il quadro normativo si sarebbe completato, nell’aprile del 1927, con il varo della Carta del lavoro che prevedeva, tra le altre cose, l’istituzione della Magistratura del lavoro come organo giurisdizionale competente a giudicare, in ultima istanza, la materia dei contratti di lavoro qualora i sindacati non fossero stati in grado di arrivare a una soluzione. Sciopero e serrata erano vietati e considerati, dal Codice penale del 1930, come reati inclusi nel novero dei «delitti contro l’economia pubblica»7.
Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: La legge sindacale al Senato, 1° aprile 1926, p. 1; Relazione 1925-1926, 16 luglio 1926, p. 1; Il riconoscimento dell’Unione Industriale Fascista delle Provincie di Milano e Varese, 16 giugno 1927, p. 1.
Nel tempo delle corporazioni Milano è “campo sperimentale” dei nuovi fenomeni economici
Per le associazioni territoriali, la nuova normativa prevedeva la creazione, in ogni provincia del Regno d’Italia, di un’Unione Industriale Fascista. Nel caso di Milano, il primo passo, il 15 luglio 1926, fu la costituzione della Federazione Industriale Fascista della provincia di Milano presieduta da Carlo Tarlarini che subentrava al Presidente federale uscente Raimondo Targetti. Nell’aprile del 1927, ottenuto il riconoscimento giuridico come previsto dalla legge 563/1926, la Federazione assumeva la nuova denominazione di Unione Industriale Fascista delle province di Milano-Varese. L’ultimo passaggio, nel novembre del 1928, fu la creazione di due unioni industriali distinte, una a Milano e una a Varese, quest’ultima diventata nel frattempo provincia. Parallelamente, per migliorare l’assetto organizzativo, veniva revocato il riconoscimento giuridico a diverse organizzazioni territoriali – in particolare a quelle dell’Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza – che furono così raggruppate nell’Unione provinciale milanese con sede nel Palazzo Turati in via Meravigli n. 9.
A gennaio del 1930, nell’Unione provinciale milanese erano rappresentate circa 8.300 aziende, per complessivi 340 mila dipendenti, raggruppate in 39 sezioni, suddivise, a loro volta, in 94 sottosezioni. A queste si andavano ad aggiungere le 2.200 imprese con 110 mila addetti che facevano parte del Consorzio industriali meccanici e metallurgici il quale, in virtù «dell’onorata tradizione e per le benemerenze acquisite», aveva mantenuto una vita autonoma all’interno dell’Unione. Ne facevano parte 10.550 imprese con oltre 450 mila lavoratori. Questi numeri confermavano l’assoluta importanza di Milano in campo associativo e, al tempo stesso, attribuivano al capoluogo lombardo quella funzione di “campo sperimentale” per le trasformazioni economiche e sociali del Paese. Per il Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai, le unioni dovevano «tendere logicamente a divenire un agile strumento della produzione», e questo nel quadro di quella collaborazione tra le varie forze produttive che il nuovo sistema corporativo perseguiva. In questa direzione andavano, per esempio, l’elargizione di contributi per la realizzazione di nuove case per operai e impiegati, nonché un più deciso sostegno dato alla formazione professionale a vari istituti tecnici di Milano e provincia. Proseguiva parallela anche l’attività sindacale, per esempio con la stipulazione del contratto per gli impiegati del settore chimico8.
A queste iniziative si aggiungeva nel 1929 la pubblicazione, in collaborazione con il Consorzio, della prima edizione dell’«Annuario industriale della provincia di Milano». Nel presentare la pubblicazione, il 7 settembre di quell’anno, il «Corriere della Sera» diceva di Milano che «chiamarla culla dell’industria e fulcro del commercio e dei traffici nazionali è affermare una solida realtà» e sottolineava il suo ruolo di “campo sperimentale” per tutti i fenomeni economici, sindacali e previdenziali9. Per fare un esempio, tra il 1928 e il 1929, durante la stipula di alcuni contratti collettivi a livello provinciale erano state inserite alcune parti innovative in termini di trattamento della manodopera che venivano riprese e inserite nei contratti conclusi da altre unioni provinciali.
Cfr. D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 55 ss.
Cfr. La potenza industriale della Provincia di Milano, in «Corriere della Sera», 7 settembre 1929, p. 5.
La crisi del 1929 colpisce l’Italia: il radicale intervento statale e le scelte sociali per i lavoratori
La crisi del 1929 avrebbe avuto importanti conseguenze anche per il nostro Paese e sarebbe penetrata attraverso le sue componenti finanziarie. Il crollo di Wall Street portava al blocco dei finanziamenti esteri all’economia italiana e di conseguenza tutte le grandi industrie e le banche si sarebbero trovate in crescenti crisi di liquidità. A questo seguivano il crollo dei valori azionari di circa il 39% e la forte discesa dei prezzi all’ingrosso. La disoccupazione aumentava da 300 mila a un milione di unità di cui 715 mila nell’industria, mentre la pressione fiscale era di gran lunga la più elevata di tutti i Paesi europei industrializzati.
A Milano le cose non andavano meglio e anche l’operatività dell’Unione appariva penalizzata dalle conseguenze dei controlli sempre più severi da parte del governo. In breve, si assisteva alla progressiva burocratizzazione delle sue funzioni e questo specie dopo che era stata resa obbligatoria l’iscrizione delle imprese alle varie associazioni di categoria.
Per ridurre le difficoltà legate alla situazione economica, in stretta collaborazione con il Consorzio degli industriali meccanici e siderurgici, venivano potenziati i cosiddetti “spacci Liverani” – oltre 600 tra Milano, Roma e la Lombardia – che prendevano il nome dal Segretario dell’Unione Francesco Armando Liverani, che li aveva lanciati nell’agosto del 1926 per offrire, a prezzi calmierati, generi di prima necessità. Proseguiva anche l’impegno in campo sindacale con la stipula o il rinnovo di importanti contratti collettivi. Nel dicembre del 1933, nella sede dell’Unione industriale, veniva annunciata la costituzione di 90 mutue aziendali destinate agli addetti dell’industria tessile che si andavano ad aggiungere alle oltre 260 già create e che tutelavano più di 300 mila lavoratori.
Intanto, a metà luglio del 1932, era scomparso il Presidente dell’Unione Carlo Tarlarini che molto aveva fatto per la crescita dell’associazionismo industriale, ricoprendo varie cariche tra cui la presidenza dell’organizzazione dei cotonieri e quella dell’Associazione fra gli industriali d’Italia per la prevenzione infortuni. Al suo posto veniva chiamato Felice Comi, «notissima personalità del mondo industriale lombardo» e Vicepresidente del Consorzio che, tuttavia, avrebbe ricoperto il nuovo incarico per poco più di un anno, fino alla sua morte, avvenuta nell’ottobre del 1933.
Da pochi mesi era stato costituito l’IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale, pensato per il salvataggio delle banche e delle aziende collegate. Nato come ente temporaneo – nel 1937 divenne permanente – l’IRI avrebbe assunto la proprietà di oltre il 20% dell’intero capitale azionario nazionale e sarebbe diventato di fatto il maggior imprenditore italiano con aziende, solo per citarne alcune, come l’Ansaldo, la Terni, l’Alfa Romeo, la SIP e la SME.
Nella stagione dell’Impero si accentuano protezionismo e sostegni ai settori per la guerra
Il 16 settembre 1934, il «Corriere della Sera» avvertiva: «Si cammina velocemente a Milano sulla strada del nuovo inquadramento corporativo»; citava «il lavoro febbrile nella sede di quel comando supremo delle forze industriali della provincia» e annunciava la nascita di 38 sindacati di categoria che rappresentavano 12 mila aziende con 350 mila dipendenti10. Le varie nomine venivano fatte per acclamazione e questo, per il nuovo Delegato confederale Liverani, era un segnale di entusiasmo e trasparenza. Nove giorni più tardi, tra alti “alalà” rivolti al Duce, s’insediavano i segretari dei sindacati, salutati dal Sottosegretario alle Corporazioni Bruno Biagi che rispondeva: «Non bisogna aver paura delle ombre», a chi si diceva preoccupato degli effetti che l’azione corporativa potesse avere sulle imprese.
Dopo essere rimasto sulla carta per circa otto anni, il Regio Decreto n. 1382 del 16 agosto dello stesso anno aveva dato, in pratica, via libera a un nuovo modello per le relazioni industriali. La nuova norma prevedeva il riordino degli Statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle associazioni a essa aderenti. A differenza del periodo precedente, le imprese erano obbligate a iscriversi sia all’Unione provinciale, sia al Sindacato di categoria, eliminando così la questione del “doppio inquadramento” tra imprese rappresentate e imprese associate, con le prime maggiori rispetto alle seconde. I compiti dell’Unione venivano, per così dire, ridimensionati. I rapporti con Roma venivano rafforzati, tanto che l’Unione milanese diventava di fatto un ufficio periferico della Confederazione industriale, con il compito di creare servizi comuni per i vari sindacati di categoria, diventati ora diramazioni locali delle federazioni di settore nazionali. Tra i compiti affidati all’Unione in ambito provinciale vi erano la stipula di contratti collettivi e di accordi economici di carattere generale, l’erogazione di servizi amministrativi a favore dei sindacati di categoria e la raccolta di dati statistici, mentre avrebbe continuato «a svolgere quella funzione educatrice e di propaganda [...] e a prestare la sua opera per lo studio dei problemi di carattere tecnico». Con il nuovo inquadramento, inoltre, entravano a far parte dell’Unione, presieduta dal marzo 1935 dall’industriale del settore cartario Franco Nodari, le categorie dei trasporti e della proprietà edilizia.
Cfr. Un limpido discorso dell’on. Biagi insedia i Direttori dell’Unione Industriali, in «Corriere della Sera», 25 settembre 1934, p. 7.
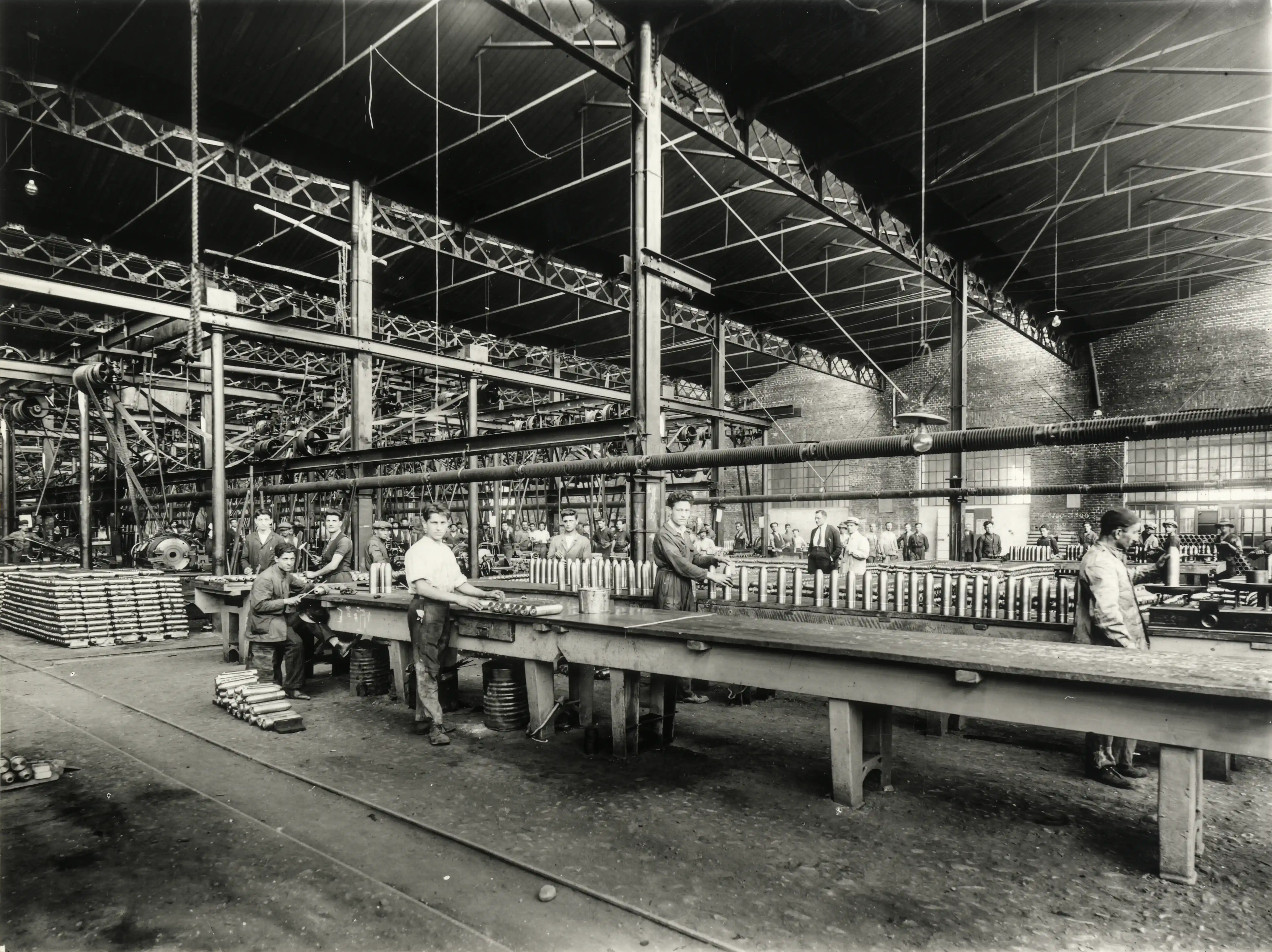
Lavorazione di proiettili alla Breda, Milano, 1914-1918. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.
Tra il 1934 e il 1935, l’attività associativa doveva affrontare con successo nuove questioni quali l’adozione della settimana di 40 ore e, soprattutto, il riassorbimento di oltre 18 mila disoccupati, per i quali venivano anche organizzati corsi di istruzione rapidi. A fronte della ripresa della corsa dell’inflazione, le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori si accordavano per ridurre salari e stipendi del 7%. La media delle retribuzioni nelle aziende milanesi sarebbe risultata sempre superiore a quella dei dati nazionali, sia per la più elevata qualificazione media della manodopera che per le forme d’incentivo legate ai cottimi11. Il 16 novembre del 1935, in una nota, l’Unione industriale milanese esprimeva piena solidarietà e appoggio alle autorità di governo in vista delle sanzioni decise dalla Società delle nazioni contro l’Italia per la conquista dell’Etiopia.
L’avventura etiopica avrebbe favorito la ripresa di alcuni settori dell’economia, in particolare quelli della meccanica e della siderurgia. Il regime virava decisamente verso una politica autarchica con un accentuato protezionismo e il diretto sostegno statale per le produzioni utili alla guerra. L’Unione non avrebbe fatto mancare il proprio appoggio sostenendo, a partire dal 1936, la creazione di consorzi tra industriali del medesimo comparto. Veniva anche organizzato un sistema di rilevazione statistica mensile allo scopo di individuare quali settori produttivi dovevano essere sostenuti con aiuti e incentivi. In generale, le sanzioni avrebbero finito per rinforzare la tendenza alla concentrazione industriale, finanziaria e territoriale. L’area del triangolo industriale avrebbe così raccolto quasi il 50% degli addetti all’industria, il 53,5% della potenza installata e il 64,5% del capitale azionario, di cui il 40% solo in Lombardia.
Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: Gli industriali in linea, 16 settembre 1934, p. 6; S.E. Biagi insedia i Direttori dei 38 Sindacati industriali di categoria, 29 settembre 1934, p. 1; Congedo, 29 dicembre 1934, p. 1.
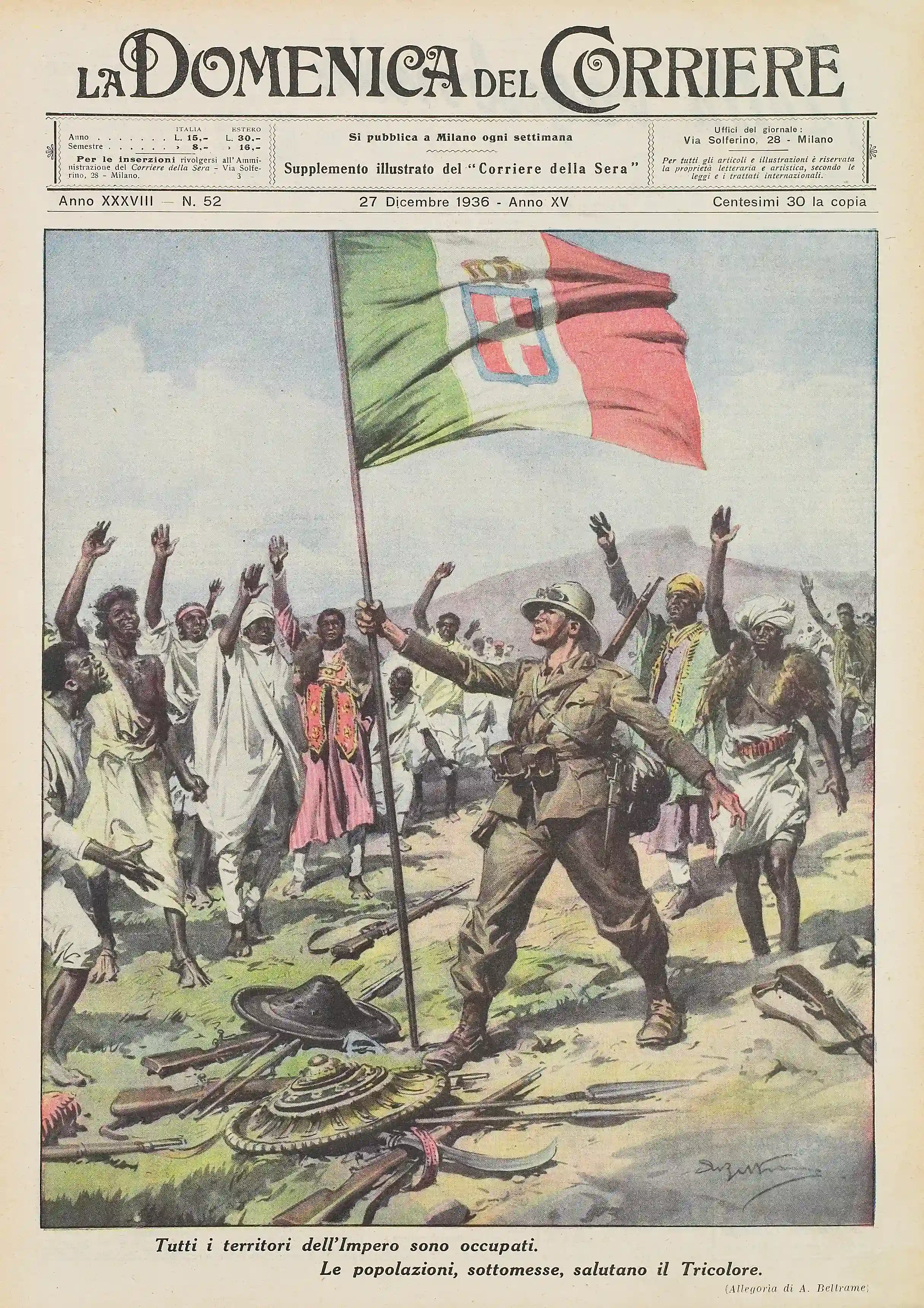
E l’industria continua a produrre nonostante i disagi economici e i pesanti bombardamenti
Sfide ben maggiori avrebbero atteso l’Italia e la sua industria. Il crescere delle tensioni internazionali, lo scoppio del conflitto e i primi passi verso la mobilitazione bellica avrebbero reso indissolubile il legame delle federazioni di categoria e delle unioni provinciali, con le autorità statali. S’intensificarono i rapporti con l’alleato tedesco organizzando viaggi in Germania per operai o attraverso incontri tra delegazioni dei due Paesi12.
Nel settembre del 1940, quando ormai Milano aveva subito i primi attacchi aerei, l’Unione veniva chiamata a far parte della Commissione per la realizzazione di ricoveri antiaerei. Con l’inverno 1941 si entrò sempre più in una fase di economia di guerra e all’Unione spettò il compito di mettere d’accordo industriali e autorità sulla concessione di una razione supplementare – 300 grammi di pasta o riso – per i lavoratori adibiti ad attività usuranti. L’industria milanese, intanto, cominciava ad avvertire le prime difficoltà nel reperimento di materie prime e di carbone e, per garantire la regolarità della produzione bellica, iniziavano i primi contingentamenti.
Per lo stesso motivo veniva applicato il blocco dei licenziamenti, veniva limitato il consumo di energia elettrica e si trasferivano alcuni impianti dal Milanese verso altre parti della Lombardia, mentre l’Unione veniva incaricata di monitorare la situazione. Nel luglio del 1942, dopo essere intervenuta nella vertenza dei lavoratori dell’industria delle calze, l’Unione fu tra le istituzioni che inviarono 50 mila pacchi dono ai combattenti in Russia.
Cfr. Dodicimila industriali, mezzo milione di operai, in «Corriere della Sera», 21 settembre 1937, p. 4.
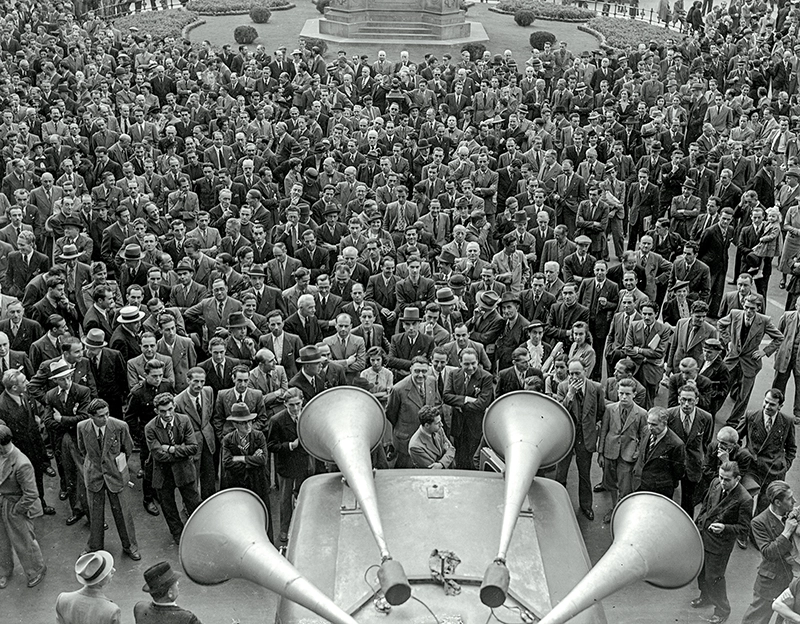
Folla in piazza della Scala a Milano ascolta un discorso diffuso da altoparlanti, luglio 1943. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
Pochi mesi più tardi, dopo aver collaborato per l’apertura di nuove mense aziendali – sarebbero diventate circa 2.500 in grado di assicurare quotidianamente dai 130 ai 150 mila pasti – l’Unione si trovò di fronte alla forte crisi degli approvvigionamenti di materie prime e di energia, tale da mettere in ginocchio diverse aziende. Nonostante la grave situazione, nel gennaio del 1943, il Prefetto di Milano, in visita alla sede dell’Unione, si felicitò per la «piena efficienza degli industriali» e per le 13.300 aziende iscritte insieme ai 2.300 dirigenti d’industria e agli 80 mila proprietari di fabbricati.
Nell’agosto del 1943, Milano veniva colpita da terribili bombardamenti che provocavano danni ingenti a diversi edifici, tra cui anche la sede di via Meravigli. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, le truppe tedesche occupavano il capoluogo e subito iniziavano le prime requisizioni di fabbriche di generi alimentari, distillerie e tabacchi. Nell’ottobre seguente, gli uffici dell’Unione – ospitati nella sede provvisoria di via Petrarca n. 20 – sarebbero stati impegnati, in seguito all’accordo raggiunto con il comando germanico, nell’emissione di due lasciapassare, rosa o giallo, da mostrare durante il coprifuoco.
Alla fine del maggio del 1944, gli industriali decisero il blocco dei licenziamenti sia per sostenere gli operai e le loro famiglie sia per evitare la deportazione di manodopera in Germania. Nei mesi seguenti, l’attività dell’Unione si sarebbe progressivamente ridotta fino a interrompersi del tutto.

Cucina della mensa degli operai della Società italiana Ernesto Breda, Sesto San Giovanni (MI), 1930-1940. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.
“25 giugno 1945” è la rinascita dell’Associazione Industriale Lombarda
Il rarefarsi dell’attività non sarebbe coinciso con l’affievolirsi dello spirito associativo. Nel giugno del 1944, infatti, un ristretto numero di industriali iniziava a progettare la ricostituzione dell’Associazione, affidando a una consulta provvisoria - il cosiddetto “gruppo dei tredici” - il compito di formulare un nuovo schema organizzativo. Gli stessi imprenditori si sarebbero trovati il 29 aprile 1945, pochi giorni dopo la Liberazione di Milano, negli uffici della Falck in via Soncino per dare attuazione al progetto. Cesare Merzagora, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, nominava Giovanni Falck commissario straordinario. Come sede provvisoria, vista che quella di via Meravigli era inagibile, venne scelto l’ultimo piano del palazzo che ospitava il Banco di Roma in via della Posta, nel cuore di Milano. Si arrivava così alla mattinata del 25 giugno seguente, quando 54 soci fondatori sottoscrivevano l’Atto costitutivo dell’Associazione Industriale Lombarda, in sintesi Assolombarda. L’articolo 2 dello Statuto, approvato nella stessa occasione, stabiliva che potevano aderire all’Associazione tutte le imprese industriali della regione lombarda, mentre l’articolo successivo sottolineava come lo scopo della nuova organizzazione fosse “provvedere all’assistenza e alla tutela degli interessi delle aziende industriali in tutti i problemi sindacali e sociali” e di favorire lo sviluppo e il progresso industriale lombardo. Insieme a Milano, tra la tarda primavera e l’estate del ’45, riprendevano l’attività anche altre organizzazioni industriali provinciali tra cui quelle di Bergamo, Brescia e Legnano. Ricostituita l’associazione territoriale, toccava adesso ai diversi sindacati di categoria. Il primato spettava, già nel luglio successivo, all’organizzazione dei metalmeccanici, cui sarebbe seguita la nascita di 30 sindacati che riunivano quasi tutte le categorie produttive.

La prima grande questione da affrontare era la conta dei danni di guerra. Per Falck, primo Presidente di Assolombarda - così veniva chiamata l’Associazione dagli organi d’informazione del periodo - le industrie erano in grado di ripartire in breve tempo e, questo, nonostante i danni subiti a causa dei bombardamenti, della mancanza di materie prime, di carbone e di energia elettrica e della grave situazione di strade e ferrovie. Importante obiettivo militare, Milano aveva subito oltre cinquanta attacchi aerei che avevano distrutto o danneggiato migliaia di immobili, fra cui alcuni simboli della città, quali il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala e la vicina Galleria Vittorio Emanuele. Era andata meglio alle varie aree industriali per le quali non si registravano danni pesanti. Tra le imprese colpite c’erano l’Innocenti a Lambrate, la Caproni e l’aeroporto, l’Alfa Romeo e l’Isotta Fraschini, ma senza che per questo l’attività fosse mai stata interrotta.
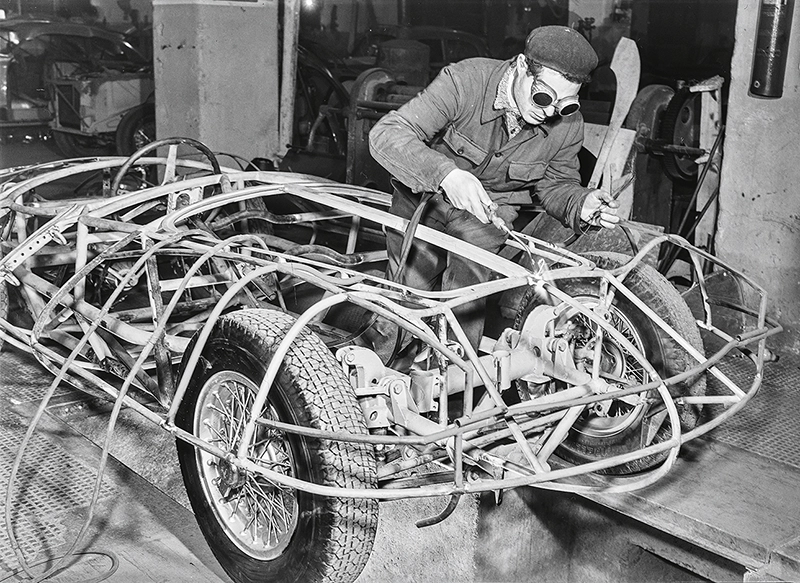
Un operaio in officina salda i tubolari del telaio del prototipo dell’Alfa Romeo C52 spider “Disco Volante”, 1952. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
Più urgenti risultavano essere i problemi legati al personale in esubero e al malcontento popolare per il forte aumento dei prezzi. Il contributo degli industriali fu davvero notevole rinunciando ai tagli ai dipendenti e, anzi, garantendo il livello salariale anche quando gli impianti non erano in funzione. Dal canto suo l’Associazione siglava con la parte sindacale accordi sull’indennità di contingenza, sulla revisione dei minimi retributivi e sulla perequazione di stipendi e salari. Lasciato alle spalle il periodo fascista, la grande novità era il ritorno a libere relazioni sindacali in un clima di collaborazione con gli Alleati, le autorità locali e le organizzazioni dei lavoratori. Il principio basilare che regolava il rapporto tra Associazione e imprese, inoltre, era molto semplice: nessuna distinzione tra grandi e piccole.

Intervento del Sindaco di Milano Antonio Greppi in piazza del Duomo, Milano, 1945. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
Nella seconda parte del 1945, l’attività associativa si concentrava sulla questione approvvigionamento e distribuzione di materie prime e sulla carenza di energia elettrica. In autunno, a fronte di una situazione alimentare sempre difficile, si chiese alle aziende di mantenere il servizio mensa “tanto nei riguardi della minestra calda, quanto del secondo piatto, ove esista” e di partecipare alla “Giornata di solidarietà popolare” invitando gli associati a versare in favore di disoccupati e senzatetto l’importo di un’ora di lavoro per ogni dipendente impiegato.

Un uomo legge un giornale seduto sulla base del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo, Milano, 1956. Archivio Fondazione Fiera Milano.
Il 1946 si apriva con la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 aprile, anche se veniva concesso alle imprese di licenziare gradualmente una percentuale di personale in esubero. Nel maggio del 1946, a riprova della grande attenzione degli industriali nei confronti della popolazione intera, veniva organizzata un’iniziativa con la quale le aziende furono invitate a versare 100 lire per ogni dipendente da far confluire in un fondo benefico13.
Cfr. D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 155 ss. Sull’associazionismo industriale si veda anche il lavoro di L. Vidotto, L’organizzazione industriale lombarda..., cit.

Costruzione di alcune strutture presso il settore edilizia per la Fiera Campionaria di Milano del 1957. Archivio Fondazione Fiera Milano.
“Nuovo Risorgimento dell’economia” tra ricostruzione e severe manovre monetarie
Il 20 luglio dello stesso anno, i pochi giornali in circolazione davano notizia dell’elezione del nuovo Comitato di presidenza di Assolombarda. Alighiero De Micheli, amministratore delegato del Lanificio di Somma Lombardo, nonché futuro Presidente di Confindustria dal 1955 al 1961, subentrava a Falck. Quest’ultimo, qualche tempo prima, aveva sottolineato come “attorno all’Associazione si è stretta la stragrande maggioranza delle aziende della nostra Provincia .... la nostra organizzazione potrà costituire un valido strumento fiancheggiatore degli sforzi che gli industriali dovranno compiere per la ripresa”. Danni a parte, la guerra aveva lasciato anche un’altra importante eredità. Lo sforzo bellico aveva portato a un forte aumento della capacità produttiva in diversi settori, tra i quali quello delle macchine utensili, dell’aeronautica, dei motori, dell’elettromeccanica. A questi, si aggiungevano il comparto della chimica, quello della gomma e dei derivati del petrolio e del carbone. Sarebbero stati questi i rami produttivi su cui si sarebbe basata la strategia di ricostruzione dell’industria italiana nel secondo dopoguerra.
A differenza di quanto avvenuto nel primo conflitto mondiale in cui si era puntato su una produzione di massa con tecnologie molto semplificate e spesso obsolete, la Seconda guerra mondiale avrebbe attribuito un ruolo decisivo ad armamenti molto complessi che richiedevano elevati standard di precisione e qualità in tutte le fasi del ciclo produttivo. Per questo, molte aziende avevano puntato sulla tecnologia e sulla professionalità degli operai; due aspetti che sarebbero tornati molto utili nel periodo successivo.
In questo dopoguerra, la vera questione diventava come evitare la paralisi produttiva acuita da un mercato quasi isolato dal contesto nazionale e internazionale e dall’aumento del tasso d’inflazione che indeboliva la lira. Se il risanamento della moneta nazionale era ormai improrogabile, a preoccupare l’Associazione era sempre la ricerca di quel particolare equilibrio tra imprenditori e masse operaie. Tra il 1945 e il 1947, venivano sottoscritti 23 grandi accordi con le rappresentanze del mondo del lavoro e siglata l’intesa per l’indennità di contingenza che aveva richiesto ben 18 riunioni. Intanto, nel settembre del 1946, sotto gli auspici di Confindustria, si era tenuto il primo convegno per la ricostruzione dell’industria, con la presenza di oltre mille congressisti. In autunno, in una Milano alle prese con la rimozione delle macerie, dove erano attivi oltre 200 cantieri, l’Associazione si appellava agli associati invitandoli a sottoscrivere il Prestito della Ricostruzione.

Interno del padiglione auto, avio, moto, ciclo alla Fiera Campionaria di Milano del 1955. Archivio Fondazione Fiera Milano.
I primi mesi del 1947 facevano registrare una certa ripresa, anche se non uniforme. Lo sblocco dei licenziamenti diventava motivo per diversi scioperi, tanto che il 24 ottobre una «moltitudine tumultuante» – come si legge tra le notizie di cronaca riportate dal «Corriere della Sera» del giorno seguente – faceva irruzione nella nuova sede dell’Associazione in via Torino n. 61, all’interno di Palazzo Casati Stampa. L’esigenza di trasferire gli uffici associativi in uno spazio più grande era la diretta conseguenza del forte aumento di nuove adesioni e del moltiplicarsi degli impegni associativi. Il 18 gennaio, intanto, era ripresa la pubblicazione del periodico «L’Industria Lombarda», con una tiratura di 7 mila copie.
Alla fine del 1947, l’Associazione Industriale Lombarda inquadrava 30 sindacati di categoria, e l’organizzazione interna era strutturata attraverso l’Ufficio di consulenza generale, quello per gli studi sul lavoro, l’Ufficio studi economici che raccoglieva i dati statistici nazionali e internazionali e, infine, quello per la consulenza fiscale. Il sodalizio era collegato alle consorelle di Monza, Legnano e Lodi nonché a diversi sodalizi di categoria, per un totale di 8.000 aziende associate con circa 450 mila dipendenti. La domanda di partecipazione trovava conferma nella grande adesione – oltre 2.400 partecipanti – al primo convegno organizzato dall’Associazione il 4 marzo 1948, per discutere dei principali problemi del periodo: la questione salariale, l’intervento dei poteri pubblici nella vita economica e la previdenza sociale14.
Veniva invocato un «nuovo Risorgimento dell’economia» ma, nel frattempo, gli industriali si dovevano confrontare con gli effetti della complessa manovra monetaria – la cosiddetta “Linea Einaudi”, dal nome dell’allora Ministro delle Finanze e futuro Presidente della Repubblica Luigi Einaudi – che provocava una battuta d’arresto nella ripresa produttiva e il riavvio della protesta operaia che sfociava in un rapido aumento delle vertenze sindacali. Di queste ultime, l’Associazione ne discuteva oltre un migliaio, e arrivava alla firma, dopo ben 16 mesi di trattative, del nuovo contratto dei metalmeccanici che, nella sola provincia di Milano, interessava 1.800 aziende e 150 mila lavoratori15.
Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: L’assemblea dell’Associazione Industriale Lombarda, 25 gennaio 1947, p. 1; Organizzazione orizzontale o verticale? Scopi e struttura delle associazioni industriali, 8 febbraio 1947, p. 1; Assemblea dell’Assoc. Ind. Lombarda, 5 luglio 1947, p. 1; La situazione economico-finanziaria nella relazione del Dott. De Micheli, 20 dicembre 1947, p. 1. Si veda anche la relazione del Presidente all’Assemblea Straordinaria, 24 gennaio 1947 e quella del 1° luglio 1947 (Archivi Assolombarda), e l’articolo Un appello al Governo perché rianimi l’iniziativa privata pubblicato sulle pagine del «Corriere d’Informazione», 21 marzo 1946, p. 2.
Sul periodo post-ricostruzioni, si veda quanto apparso in «L’Industria Lombarda»: L’E.R.P. è un programma economico e non una alleanza di natura politica, 31 gennaio 1948, p. 1; I problemi industriali sono i problemi dell’Italia, 6 marzo 1948, p. 1; Il “Piano Marshall entrato in funzione”, 17 aprile 1948, p. 1; Chiusa la fase più aspra del dopoguerra psicologico, 28 maggio 1949, p. 1; Gli industriali della Lombardia riuniti in assemblea hanno confermato la coscienza della loro funzione di classe dirigente, 8 aprile 1950, p. 1. Sempre sul tema della ricostruzione, si vedano gli Atti del primo Congresso dell’Associazione Industriale Lombarda. Milano, 4-5 marzo 1948, Grafiche Stucchi, Milano [1948].

Cerimonia di consegna delle navi USA alla Marina italiana, Brindisi, 7 dicembre 1951. Archivio ANSA.
Gli effetti del Piano Marshall e il lento ritorno alla normalità, ma restano alte le tensioni sociali
Poco dopo le ore 13 del 23 luglio 1946, un bimotore Douglas era atterrato all’Aeroporto Forlanini. Ne era sceso, accolto dal Sindaco Antonio Greppi e dal Presidente di Assolombarda De Micheli, l’ex Sindaco di New York, Fiorello La Guardia, da poco nominato Direttore dell’UNRRA – United Nation Relief and Rehabilitation Administration. Prima di ripartire per Roma alle 16.30, La Guardia aveva visitato le Acciaierie Falck e la Breda, per poi essere ricevuto a Palazzo Marino per un breve rinfresco e salutato anche da Arturo Toscanini16.
A questo primo e fugace contatto con il mondo americano ne sarebbero seguiti altri in occasione dell’attuazione del cosiddetto Piano Marshall annunciato nel giugno del 1947. Gli aiuti provenienti dagli Stati Uniti – come sottolineava il Presidente De Micheli nel corso dell’Assemblea del 6 luglio 1948 – sarebbero stati decisivi per la realizzazione di opere pubbliche come acquedotti, strade, ferrovie, e soprattutto per ricostruire i quasi 3 milioni di vani distrutti sui 34 milioni esistenti prima della guerra. I generosi aiuti americani impattavano in maniera positiva pure sull’andamento della produzione industriale, anche se non ancora ritornata ai livelli prebellici. Fatto 100 l’indice medio produttivo per il 1938, infatti, si aveva 80 per il 1947 e 87 per l’anno successivo.
Seppur lentamente, Milano si stava riprendendo e questa voglia di ripresa era stata testimoniata, nel giugno dell’anno prima, dall’inaugurazione della prima Fiera Campionaria del dopoguerra, vero e proprio simbolo dell’operosità del capoluogo lombardo. Le principali questioni sul tappeto – come ricordava De Micheli di fronte all’Assemblea Generale del 6 luglio 1948 – erano: il personale in esubero rispetto al fabbisogno, il basso rendimento del lavoro (circa il 65-70% rispetto a prima del conflitto), i salari troppo alti e l’eccessivo peso degli oneri previdenziali che superavano il 30% del totale delle retribuzioni ed erano i più alti nell’Europa occidentale. Lo sblocco dei licenziamenti, decisivo per la definitiva ripresa, diventava occasione per scioperi e proteste da parte operaia. Le agitazioni scoppiate in molte aziende – tra cui la Motta, la Breda e la Marelli – costavano la perdita di 65 milioni di ore di lavoro a livello nazionale ma si concludevano tutte allo stesso modo, con tagli al personale e riduzione di orario.
Cfr. 3 ore milanesi di La Guardia, in «Corriere d’Informazione», 25 luglio 1946, p. 1, e La prima giornata del Convegno per la ricostruzione industriale, in «Corriere della Sera», 15 settembre 1946, p. 2.

Operai dello stabilimento Guzzi al lavoro sui cerchioni delle motociclette, Mandello del Lario (LC), 1950. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
Sotto accusa, in questo periodo, l’azione del governo. Per gli industriali lombardi, infatti, l’esecutivo sembrava muoversi a tentoni senza coordinamento e senza una chiara direttiva di politica economica in grado di assecondare la formazione del risparmio e sostenere l’iniziativa privata. «È un delitto pensare che l’economia sia subordinata a preoccupazioni politiche o, peggio ancora, alla demagogia», sosteneva De Micheli nella sua relazione del 1949. Ancora in quella dell’anno seguente, non mancavano critiche all’operato governativo. La riforma fondiaria veniva definita una “doccia scozzese” perché rischiava di deprimere il settore agricolo; il blocco degli affitti mortificava capitali e rendite e la nominatività dei titoli azionari veniva vista come un autentico spauracchio. Anche il giudizio sulla politica fiscale era assai negativo: «il fiscalismo pare consideri il profitto un illecito da perseguitare», affermava il Presidente di Assolombarda nel corso dell’Assemblea del 4 aprile 1950. Nel suo discorso si sottolineava il valore politico, e non economico, della lira e la necessità per le aziende di una maggiore libertà organizzativa.
A due anni dall’avvio del Piano Marshall, nella primavera del 1950, il bilancio si poteva dire positivo. Oltre all’arrivo di cibo e medicinali, le province lombarde avevano ricevuto 11 miliardi di lire per la realizzazione di opere pubbliche, il ripristino di linee ferroviarie e il sostegno all’agricoltura, mentre le aziende avevano ricevuto in prestito ben 25 miliardi. Per Assolombarda, questi soldi sarebbero dovuti servire soprattutto al rinnovo degli impianti obsoleti e lo Stato avrebbe dovuto agevolare questo passaggio.
Il 1950 segnava anche un chiaro aumento della conflittualità operaia, con una perdita di ore di lavoro stimata, nella sola Lombardia, intorno ai 10 milioni, 2 in più rispetto all’anno precedente. L’attività dell’Associazione in campo sindacale rappresentava sempre il primo impegno per la sede milanese attraverso la partecipazione alle più importanti trattative a livello nazionale. Parecchie novità anche in altri settori d’attività. Venivano organizzate le prime colonie marine e montane, prendeva avvio la pubblicazione della «Rassegna stampa estera», distribuita a tutti i soci, e la ripresa della stampa dell’«Annuario industriale della provincia di Milano», largamente diffuso in Italia e all’estero. Il Piano INA-Casa, ideato nel 1949 dall’allora Ministro del Lavoro Amintore Fanfani, trovava largo consenso in Assolombarda, che sosteneva anche la creazione della Domus Ambrosiana, un’iniziativa voluta dall’Arcivescovo di Milano allo scopo di costruire abitazioni per i tanti senzatetto.
Verso la stabilità: retribuzioni migliori, scala mobile e prime aperture dell’economia
L’improvviso scoppio del conflitto coreano nel giugno del 1950 pareva interrompere il graduale ritorno alla normalità. I primi effetti furono una minore disponibilità di materie prime, un generale aumento dei prezzi e, in molti Paesi, l’avvio di programmi di riarmo, l’applicazione di tutta una serie di misure intese a regolamentare la produzione e, infine, il parziale ripristino delle restrizioni agli scambi internazionali che erano state da poco eliminate. Una volta riassorbite le tensioni internazionali, la situazione interna tornava più tranquilla con un deciso calo, tra il 1951 e il 1952, degli scioperi, nonostante alcuni gruppi di sinistra tentassero di minare l’equilibrio con nuove organizzazioni di lotta che utilizzavano sigle come: “comitati sindacali di fabbrica”, “brigate dei costruttori”, “pionieri del partito” o “collettori di fabbrica”.
La creazione della Cassa del Mezzogiorno veniva vista con favore, come del resto l’avvio del processo di integrazione europea a fronte del crescere di certi nazionalismi economici, «che mai come oggi devono impensierirci» (De Micheli, relazione presentata all’Assemblea Generale dell’8 aprile 1952).
Sempre in quel periodo si erano chiusi tre importanti capitoli: la rivalutazione delle retribuzioni in base alle qualifiche professionali, il ripristino della scala mobile e, infine, la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per motivi individuali. Su alcune scelte del governo, il giudizio rimaneva estremamente negativo. L’aumento degli oneri previdenziali e la riforma dell’assicurazione di anzianità e d’invalidità, per cui era stato redatto un opuscolo esplicativo che ne spiegava la forte incidenza sul costo del lavoro, faceva esclamare a De Micheli nella sua relazione presentata all’Assemblea Generale dell’8 aprile 1952: «Nel vasto campo della previdenza sociale appare invece obliterato ogni freno e ogni prudenza», mentre in campo fiscale vigeva «un generico pregiudizio contro la ricchezza e contro chi, a prezzo di rischi e sacrifici, è riuscito a realizzare le proprie iniziative».
Nella stessa relazione, il Presidente rifletteva sul principio che doveva ispirare l’azione associativa. Rispetto al 1945, nulla era cambiato, e la formula era rimasta la stessa: «Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita di tutta la popolazione poiché il benessere degli uni è legato al benessere degli altri». La condizione fondamentale per raggiungere tale risultato era l’incremento del reddito nazionale, ottenibile attraverso l’aumento della produzione. Occorreva però superare ogni accomodamento tra realtà e soluzioni politico-economiche: «Ci avvicineremo tanto più al bene comune quanto più, avendo ripugnanza per il compromesso, ci imporremo il rispetto della verità». La critica al governo, «mai cieca né soprattutto faziosa», non era mai un’opposizione aprioristica, bensì voleva essere un freno e uno stimolo per chi gestiva il Paese. Si sarebbe dovuto, insomma, lottare contro tutto quello che frenava l’iniziativa privata «la quale rappresenta per noi la fonte insostituibile di ricchezza e di progresso per la Nazione».
Negli anni seguenti, si sarebbe registrato un sensibile calo delle vertenze sindacali. Risolti i due maggiori problemi, ossia il ridimensionamento degli organici in relazione alle esigenze produttive e il generale miglioramento delle condizioni di lavoro, si creava un sostanziale clima di collaborazione con le organizzazioni operaie, tanto che, nel 1955, le ore di lavoro perse sarebbero state poco meno di 600 mila. A questo proposito, nel corso della sua ultima relazione all’Assemblea, il 9 maggio 1955, il Presidente De Micheli sottolineava come la nuova armonia salariale «era anche la riprova che il contrasto tra capitale e lavoro era facilmente componibile con reciproca soddisfazione. L’affermazione di un inseparabile potere di attrazione dell’ideologia comunista presso i lavoratori italiani si era rilevata, ancora una volta, palesemente non vera».
Terminato nel 1953 il conflitto coreano, l’economia tornava a crescere grazie anche al contributo del settore secondario. Le principali caratteristiche dell’industria nazionale dell’epoca erano il crescente e rapido grado di apertura dell’economia italiana nei confronti delle economie occidentali, la forte presenza dell’impresa pubblica nei settori industriali di base e nell’intero sistema creditizio, le produzioni “pesanti” poco concorrenziali a confronto di altri Paesi e, infine, il costo del lavoro generalmente più contenuto, oltre a una forte disoccupazione in certe aree. Il divario economico tra Nord e Sud rimaneva sempre rilevante e, tra le regioni più avanzate, la Lombardia confermava il proprio primato. Nel 1954, per esempio, il reddito pro capite lombardo era di 299 mila lire contro le 188 mila della media italiana.
Si vedano le relazioni del Presidente De Micheli presentate all’Assemblea Generale nel periodo 1948-1953 (Archivi Assolombarda, Relazioni del Presidente all’Assemblea Generale). Si vedano anche questi articoli apparsi sul «Corriere della Sera»: Centoundici miliardi spesi per la ricostruzione in Lombardia, 7 novembre 1952, p. 2; L’industria vuol collaborare coi governanti e coi lavoratori, 1° aprile 1953, p. 2; Dieci anni di attività dell’Associazione Industriale Lombarda, 10 maggio 1955, p. 2.

Scooter Lambretta e Vespa in piazza Diaz a Milano, anni Cinquanta. Fondazione Pirelli.
Nella stessa relazione, il Presidente rifletteva sul principio che doveva ispirare l’azione associativa. Rispetto al 1945, nulla era cambiato, e la formula era rimasta la stessa: «Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita di tutta la popolazione poiché il benessere degli uni è legato al benessere degli altri». La condizione fondamentale per raggiungere tale risultato era l’incremento del reddito nazionale, ottenibile attraverso l’aumento della produzione. Occorreva però superare ogni accomodamento tra realtà e soluzioni politico-economiche: «Ci avvicineremo tanto più al bene comune quanto più, avendo ripugnanza per il compromesso, ci imporremo il rispetto della verità». La critica al governo, «mai cieca né soprattutto faziosa», non era mai un’opposizione aprioristica, bensì voleva essere un freno e uno stimolo per chi gestiva il Paese. Si sarebbe dovuto, insomma, lottare contro tutto quello che frenava l’iniziativa privata «la quale rappresenta per noi la fonte insostituibile di ricchezza e di progresso per la Nazione».
Negli anni seguenti, si sarebbe registrato un sensibile calo delle vertenze sindacali. Risolti i due maggiori problemi, ossia il ridimensionamento degli organici in relazione alle esigenze produttive e il generale miglioramento delle condizioni di lavoro, si creava un sostanziale clima di collaborazione con le organizzazioni operaie, tanto che, nel 1955, le ore di lavoro perse sarebbero state poco meno di 600 mila. A questo proposito, nel corso della sua ultima relazione all’Assemblea, il 9 maggio 1955, il Presidente De Micheli sottolineava come la nuova armonia salariale «era anche la riprova che il contrasto tra capitale e lavoro era facilmente componibile con reciproca soddisfazione. L’affermazione di un inseparabile potere di attrazione dell’ideologia comunista presso i lavoratori italiani si era rilevata, ancora una volta, palesemente non vera».
Terminato nel 1953 il conflitto coreano, l’economia tornava a crescere grazie anche al contributo del settore secondario. Le principali caratteristiche dell’industria nazionale dell’epoca erano il crescente e rapido grado di apertura dell’economia italiana nei confronti delle economie occidentali, la forte presenza dell’impresa pubblica nei settori industriali di base e nell’intero sistema creditizio, le produzioni “pesanti” poco concorrenziali a confronto di altri Paesi e, infine, il costo del lavoro generalmente più contenuto, oltre a una forte disoccupazione in certe aree. Il divario economico tra Nord e Sud rimaneva sempre rilevante e, tra le regioni più avanzate, la Lombardia confermava il proprio primato. Nel 1954, per esempio, il reddito pro capite lombardo era di 299 mila lire contro le 188 mila della media italiana17.
Si vedano le relazioni del Presidente De Micheli presentate all’Assemblea Generale nel periodo 1948-1953 (Archivi Assolombarda, Relazioni del Presidente all’Assemblea Generale). Si vedano anche questi articoli apparsi sul «Corriere della Sera»: Centoundici miliardi spesi per la ricostruzione in Lombardia, 7 novembre 1952, p. 2; L’industria vuol collaborare coi governanti e coi lavoratori, 1° aprile 1953, p. 2; Dieci anni di attività dell’Associazione Industriale Lombarda, 10 maggio 1955, p. 2.
Crescono produzione e consumi, la lira vince l’Oscar delle valute e la fiducia fa cantare Volare
Si erano poste le basi per l’avvio di un periodo di forte crescita, caratterizzato da un aumento del prodotto interno lordo, dal 1954 al 1963, di quasi il 6% annuo, con un picco del 8,3% nel 1961. Era il “miracolo economico”, una fase straordinaria, capace di trasformare il Paese non solo in termini economici, ma anche sul piano sociale. Al Festival di Sanremo del 1958, Domenico Modugno cantava Volare (Nel blu dipinto di blu) e forse la sensazione era proprio questa. Gli italiani iniziavano ad andare in vacanza d’estate, nelle case arrivavano la televisione e gli elettrodomestici e si iniziava a parlare di motorizzazione di massa: a due e quattro ruote. La Vespa e la Lambretta vendevano milioni di esemplari, il “cinturato Pirelli” era lo pneumatico di maggior successo e, nel luglio del 1957, veniva presentata una delle auto più iconiche di sempre: la Nuova 500. E ancora, nel dicembre 1961, il «Corriere della Sera» avrebbe scritto che per il Natale di quell’anno erano pronti «600 metri cubi di biglietti da diecimila».
«Un intreccio virtuoso di fattori economici e sociali» – come ha scritto Antonio Calabrò – contribuiva a trainare la forte crescita dei consumi. Protagonista di questa fase non era solo il settore privato, ma anche la politica governativa che supportava la funzione espansiva della spesa pubblica e, al contempo, spingeva l’industria pubblica attraverso l’IRI e l’ENI18. Se il primo agiva più da sostegno al sistema industriale pubblico, l’Ente nazionale idrocarburi – nato nel febbraio del 1953 – era interprete «dei tentativi di modifica degli assetti economici e di potere, contro mondi industriali chiusi e monopoli aziendali. Una spinta modernizzatrice accelerata, importante in un Paese che non aveva norme antitrust e moderna cultura di mercato ben regolato». Fondamentale, in questo, il ruolo avuto dal Presidente ENI, Enrico Mattei, che avrebbe subito compreso che l’Italia doveva ricercare la propria autonomia energetica per non dipendere, per le forniture di petrolio e metano, dal cartello delle “sette sorelle”, le multinazionali petrolifere. In pochi anni, grazie a massicci investimenti – soltanto tra il 1959 e il 1960 superavano i 69 miliardi di lire di cui 6 per iniziative all’estero – ENI dotava il Paese di una rete di gasdotti e di distributori di benzina, costruiva il nuovo petrolchimico di Ravenna e procedeva al salvataggio di diverse imprese, tra cui la Nuovo Pignone di Firenze e la vicentina Lanerossi.
Cfr. Antonio Calabrò, Le radici forti di una storia economica nel cuore dell’Europa, in AA.VV., Storie del Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia, a cura della Fondazione Pirelli, Marsilio, Venezia 2020, pp. 21-27.

Folla in piazza del Duomo, Milano, 1961. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.
Il futuro continuava a sembrare roseo ma, in realtà, alcune nubi stavano comparendo all’orizzonte. Nello stesso anno, infatti, si era rotto l’incantesimo della stabilità della lira, un vero vanto dell’economia nazionale che aveva fruttato elogi da tutto il mondo e perfino l’Oscar della moneta più stabile attribuito nel 1960 dal prestigioso «Financial Times».
In questa fase, il ruolo propulsivo dell’industria era determinante nel sostenere il “boom economico” specie in un quadro generale contraddistinto da una domanda in aumento, dai mercati in rapida espansione e da una bassa conflittualità.
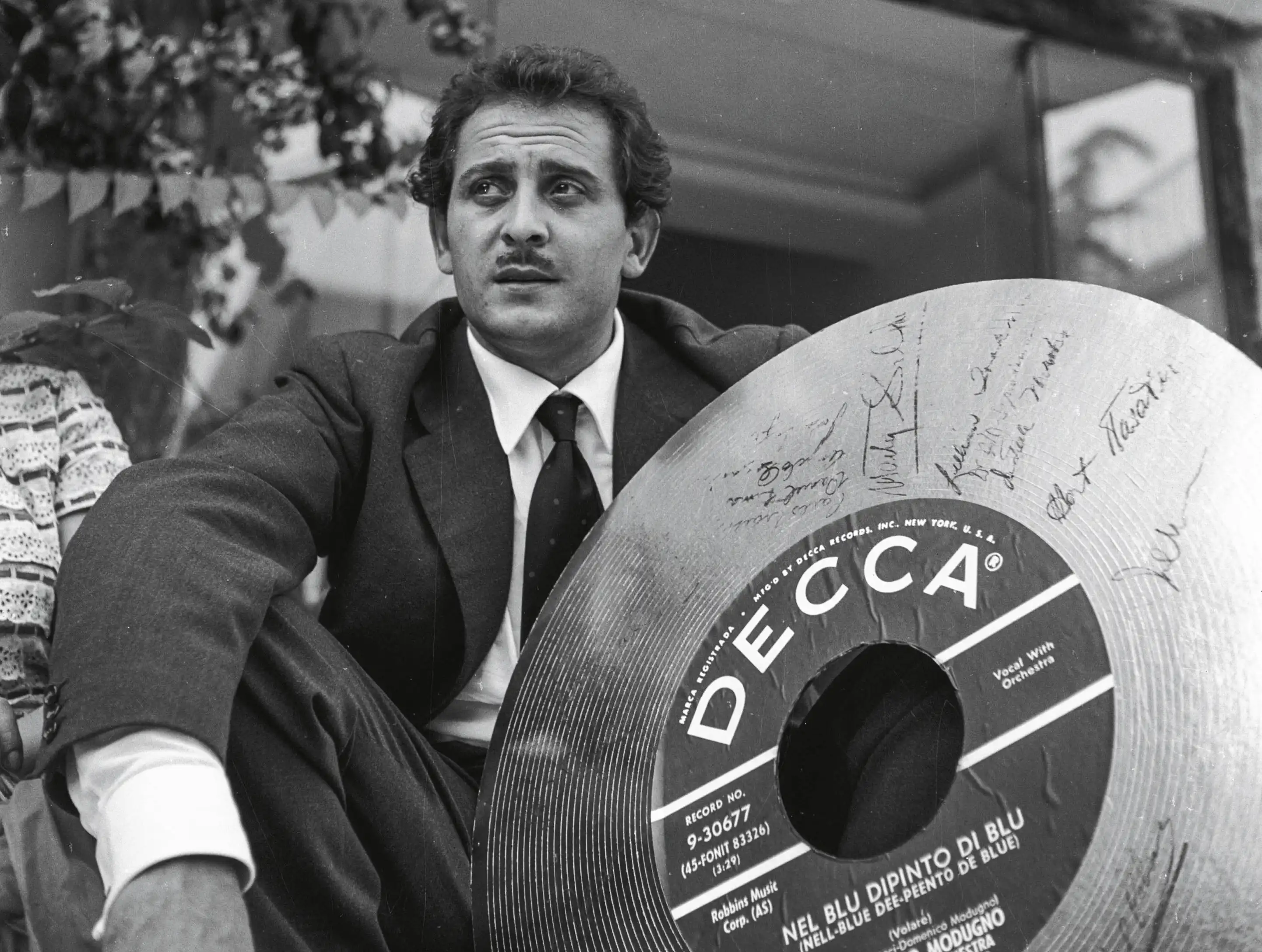
Il cantante Domenico Modugno, vincitore dell’ottava edizione del Festival di Sanremo con la canzone Nel blu dipinto di blu. Archivio ANSA.
Sul versante associativo, si concludeva l’era De Micheli, chiamato a Roma alla presidenza di Confindustria, e al suo posto veniva eletto Furio Cicogna, Presidente della Châtillon e Consigliere delegato Italrayon e Italviscosa, nonché presente nei consigli di amministrazione della Edison e della Cartiera Burgo, e Presidente della Federazione italiana rugby. La continuità di pensiero con il suo predecessore era chiara, a cominciare dalla difesa del sistema privatistico. Nel suo discorso d’insediamento, il 16 aprile 1956, Cicogna criticava l’intervento statale che definiva “antieconomico” e incapace di promuovere un sistema meritocratico invece di uno in senso opposto che garantisse il lavoratore contro ogni rischio. Lo Stato, poi, offrendo ai risparmiatori impieghi al tasso medio del 5-6% con titoli al portatore, limitava di fatto le opportunità e la convenienza di investire nel settore privato. In ultimo, le aziende statali e parastatali erano l’emblema della concorrenza antieconomica, il cui peso finiva per cadere anche sulle spalle delle imprese private, soffocate da un eccessivo carico fiscale e vittime di continue adozioni di provvedimenti che aumentavano i costi aziendali.

Vigile di Milano “ghisa” in attesa della metro della linea Uno, 1965. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.
Il nuovo Presidente analizzava due importanti questioni che stavano emergendo in questi anni. La prima riguardava il pericolo che veniva dai propugnatori del sindacalismo aziendale che voleva anteporsi – come sarà evidente in seguito – alla tradizionale azione sindacale su più livelli. La seconda si rifaceva a una visione di un mondo in «violento, rapido cambiamento, spinto verso nuove possibilità da un progresso tecnico inarrestabile», secondo la quale proprio la crescente importanza della tecnologia rendeva necessaria una maggiore formazione di capitali e la creazione di strumenti in grado di sostenere le aziende.
In campo sindacale, oltre alle vertenze a livello locale e privato, Assolombarda, grazie alla grande esperienza acquisita nel tempo, si confermava tra i maggiori attori nella discussione dei problemi del lavoro a livello nazionale. Importanti, infatti, si rivelavano l’indagine sull’assenteismo avviata nel 1953 e l’applicazione degli accordi per la scala mobile, lo strumento automatico di regolazione del rapporto salariocosto della vita. Nel 1958, Assolombarda rappresentava direttamente 3.781 aziende con 315.592 lavoratori e, insieme alle organizzazioni collegate, 6.989 imprese con 422.702 dipendenti. Negli ultimi quattro anni erano state trattate 6.822 vertenze sindacali, di cui 2.675 individuali e 501 collettive, più un numero imprecisato di casi di licenziamento. Si calcolava che, per seguire la parte sindacale, gli uffici erano stati impegnati per una media di 15 riunioni al giorno.
L’organizzazione interna dell’Associazione si era andata ulteriormente strutturando attraverso la nascita, nel 1955, dell’Ufficio sviluppo – dagli anni Sessanta trasformato in Ufficio inquadramento sviluppo – con il compito di gestire i rapporti con le imprese associate e di svolgere un’azione di propaganda attraverso le visite aziendali e l’invio di materiale pubblicitario19.
Si vedano le relazioni del Presidente all’Assemblea Generale per gli anni 1952-1957 (Archivi Assolombarda).
Il Trattato di Roma per la CEE fa aprire i mercati, è tempo di investire nella formazione
Tra i temi del periodo, la firma del Trattato di Roma nel marzo del 1957 e la conseguente creazione della Comunità Economica Europea (CEE) avrebbero richiesto un robusto sforzo da parte dell’Associazione, specie in favore delle piccole e medie aziende potenzialmente più impreparate di fronte a una novità di tale portata. Indagini conoscitive sulle altre nazioni aderenti, corsi di lingue straniere e consulenza sulla vendita e sulla propaganda erano tra le nuove attività avviate dall’organizzazione imprenditoriale. Ben più probante sul piano intellettuale e giuridico sarebbe risultata la causa intentata al Tribunale di Milano sulla costituzionalità del provvedimento di sganciamento da Confindustria per le imprese a partecipazione statale. La questione aveva suscitato accese discussioni e dibattiti che, in pratica, vertevano su quelli che dovevano essere i limiti di uno Stato produttore e i criteri con cui dovevano essere gestite le aziende.
Assolombarda era convinta non solo della loro scarsa economicità, ma anche del fatto che operassero non a parità di condizioni rispetto alle imprese private e che ci fosse troppa subordinazione politica. Allo scopo, l’Associazione pubblicava uno studio basato sugli indici di efficienza applicati ad aziende di vari settori – elettrico, meccanico, siderurgico, telefonico ecc. – raggruppate all’interno del gruppo IRI. La stragrande maggioranza di esse operava in condizioni di chiara inefficienza e solo alcune alchimie contabili mitigavano l’amara realtà. Alcune aziende si erano potute difendere dall’influenza politica grazie alla loro appartenenza a Confindustria e perché i loro capi erano di formazione privata. L’ultimo aspetto riguarda la supposta maggiore eticità dell’impresa pubblica rispetto a quella privata, ma per il Presidente Cicogna la vera questione era un’altra, e la riassumeva con una semplice domanda: «L’impresa pubblica è veramente capace di gestione economica?»20.
Si vedano le relazioni del Presidente Furio Cicogna del 28 marzo 1958 e 7 aprile 1959 (Archivi Assolombarda).

Nel gennaio del 1960, la Corte Costituzionale aveva dato ragione allo Stato, ma la sentenza riportava che lo sganciamento da Confindustria non avrebbe avuto effetto automatico bensì subordinato alla manifestazione di volontà delle aziende interessate.
L’altro grande tema che teneva banco sul finire degli anni Cinquanta era quello dell’istruzione professionale considerata l’unica via per affrontare un universo produttivo sempre più scientifico e tecnologico e, soprattutto, in rapidissima trasformazione. Milano e provincia stavano assistendo all’arrivo di migliaia di persone in cerca di lavoro e di un nuovo futuro, senza dimenticare gli oltre 50 mila analfabeti e semianalfabeti che già erano presenti. La forte immigrazione aveva riversato sul mercato una grande riserva di manodopera che, tuttavia, non aveva spesso le capacità necessarie per entrare nell’industria e che dunque andava formata.

Lavorazione assali in uno stabilimento industriale in provincia di Brescia, 1967. L’immagine è stata realizzata per la rubrica Informazione Industriale del settimanale «Epoca». Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Fin dagli inizi, l’intervento a favore dell’istruzione professionale venne pensato a 360 gradi per poter comprendere sia chi non era ancora entrato nel mondo del lavoro sia chi già lavorava ma voleva crescere professionalmente. In questo modo si passava dai corsi di apprendistato alle scuole tecniche, fino all’università, anche con corsi di addestramento e specializzazione per operai, impiegati e dirigenti d’azienda. Come ricordava il Presidente Furio Cicogna all’Assemblea del 1957, «i nostri predecessori» avevano promosso due scuole universitarie – il Politecnico e l’Università Bocconi – e occorreva proseguire su quella strada. Primo passo, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali regionali, la creazione del Centro lombardo istruzione professionale (CLIP), l’appoggio concreto al nuovo Istituto Superiore di Scienze Tecnologiche “G. Feltrinelli” al cui interno sarebbe nato l’Istituto Superiore di Tecnologia Industriale, un percorso intermedio tra superiori e università che, dalla fine degli anni Sessanta, verrà gestito dal Politecnico.
Quanto ai corsi organizzati direttamente dall’Associazione, il loro successo era testimoniato dal passaggio dalle poche decine di partecipanti iniziali ai circa 1.600 del 1959. Oltre a quelli destinati ai dipendenti, venivano proposti corsi di aggiornamento per gli insegnanti degli istituti professionali, mentre per 80 giovani che intendevano emigrare a Milano venivano offerti, oltre al soggiorno, corsi per meccanici-riparatori e per elettricisti-impiantisti21.
Negli anni seguenti vennero lanciate nuove iniziative. A partire dal 1965, per esempio, fu prodotta una serie di documentari industriali per gli studenti delle scuole superiori di tutti gli indirizzi e, l’anno seguente, l’Associazione, insieme alla Camera di commercio di Milano, si accollò il pagamento delle tasse scolastiche per quegli studenti che si iscrivevano alle scuole professionali provinciali. Accanto a questo, continuavano i corsi per il personale impiegatizio presso la Scuola Tecnica Barnaba Oriani e soprattutto si moltiplicavano i partecipanti ai tanti corsi interni cresciuti dai 4.000 del 1963 agli oltre 8.000 di cinque anni più tardi.
Si vedano anche gli articoli pubblicati nel «Corriere della Sera»: I corsi piloti professionali dell’Associazione industriali, 3 luglio 1958, p. 4, e Il corso per docenti di istituti industriali, 21 ottobre 1958, p. 4.
Il “miracolo” non c’è più, cresce il divario Nord-Sud e l’inflazione colpisce i salari
Com’era stato per De Micheli, anche Furio Cicogna veniva chiamato a Roma per presiedere Confindustria. Era il 1961 e a guidare Assolombarda veniva eletto Emanuele Dubini, esponente di una famiglia attiva nel settore serico, che ricopriva la carica di Amministratore delegato, Direttore e Vice-presidente del gruppo Pirelli. La sua sarebbe stata una presidenza molto lunga – ben dieci anni dal 1961 al 1971 – e senza dubbio non priva di elementi di discussione. La sua elezione avveniva in pieno “boom economico” anche se, all’orizzonte, iniziavano a comparire le prime nubi. Nel suo discorso introduttivo del 3 maggio 1961, Dubini aveva sottolineato il peso e il ruolo di Assolombarda all’interno dell’universo confederale, in cui i due Vicepresidenti, Borletti e Zacchi, avevano dirette responsabilità quali Presidente e Vicepresidente dello speciale Comitato sindacale. Lo stesso Dubini ricopriva anche l’incarico di Vicepresidente del Comitato economico e 14 industriali lombardi sedevano in diversi comitati confederali di studio e lavoro.

Contrattazioni alla Borsa di Milano, 1963. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.
Nel marzo del 1962, di fronte ai delegati all’Assemblea annuale, sempre Dubini aveva sottolineato come l’industria italiana, e quella lombarda in particolare, si trovavano davanti a due importanti questioni. La prima riguardava l’emergere di una nuova realtà economica e di mercato seguita alla nascita del Mercato europeo comune (MEC); la seconda riguardava il contributo che gli imprenditori milanesi potevano dare all’industrializzazione delle aree meno sviluppate del Paese. E non occorreva andare neanche troppo lontano, visto che 20 comuni della provincia di Milano erano stati dichiarati depressi e quelli nella stessa condizione, calcolati in un raggio di 50 km da piazza del Duomo, erano quasi 200. Proprio in quegli anni erano iniziati i primi casi di decentramento e ben 160 aziende avevano abbandonato Milano trasferendosi a nord e nordovest o in altre province vicine. Pesavano sulle scelte le esigenze di ammodernamento dei processi produttivi e di ampliamento degli impianti, come anche l’aumentato valore delle aree cittadine.
In generale, ancora nel 1962, il reddito nazionale aumentava del 5,6%, un dato senz’altro notevole, ma sempre inferiore alla media degli anni precedenti, che avevano registrato un incremento superiore al 6%. Soprattutto la quota destinata ai consumi aumentava in misura chiaramente superiore a quella destinata agli investimenti, frenando la molla propulsiva per la crescita. L’altro elemento congiunturale negativo era il costante aumento dei prezzi, e questo faceva venire meno una delle condizioni, la loro stabilità, che aveva permesso il grande sviluppo economico del Paese. Di fatto si rompeva l’equilibrio tra gli incrementi medi dei salari e quelli della produttività con due importanti conseguenze: l’aumentata pressione inflazionistica e la minore competitività del sistema italiano.

Elettrotreno ETR 303 “Settebello” in servizio fra Roma e Milano, 1952. Archivio ANSA.
Un anno più tardi, la situazione era molto diversa. La lira si caratterizzava per una forte instabilità, la bilancia commerciale era in grave disavanzo, i capitali abbandonavano gli impieghi italiani, la speculazione era al ribasso. Non era tutto. I prezzi e i salari continuavano a crescere, la piena occupazione era stata raggiunta nei principali centri industriali e la “stanchezza degli impianti” andava di pari passo a un livello tecnologico generalmente mediocre. In altre parole, il “miracolo economico” non solo si era esaurito ma aveva finito per esasperare la contraddizione che ne era stata alla base: solo salari contenuti potevano sostenere l’industrializzazione ma, al tempo stesso, serviva un aumento dei consumi privati. La coperta era troppo corta.
All’alba del 1° maggio 1963, una bomba esplodeva di fronte alla sede di Assolombarda. L’attentato, al pari di quelli che avevano colpito la Stazione Centrale, Palazzo Marino e un’associazione cattolica di via Statuto, era opera di una banda di terroristi che si dichiaravano “filocinesi”. La “bomba allo zucchero”, così battezzata dai media per via dell’ingrediente principale contenuto nell’ordigno, segnava in un certo senso la fine di un’epoca straordinaria e forse irripetibile. La sensazione di benessere diffuso, figlia del “boom economico”, nascondeva in realtà alcune contraddizioni che mettevano in dubbio il modello di crescita e che sarebbero scoppiate di lì a qualche anno22.
Cfr. Quattro giovani fermati per la bomba in Comune, in «Corriere della Sera», 3 maggio 1963, p. 4.

Esposizione di prodotti realizzati in Moplen, nuova materia plastica frutto degli studi di Giulio Natta e realizzata dalla Montecatini alla Fiera Campionaria di Milano del 1957. Archivio Fondazione Fiera Milano.
La fine del “miracolo” stava mettendo in luce aspetti non certo confortanti: l’abbandono dell’Italia meridionale, la crescita del divario tra Nord e Sud e la congestione urbana che soffocava le principali città italiane vittime di ardite speculazioni fondiarie e, in alcuni casi, di veri e propri scempi edilizi. Il costo sociale era enorme e si diffondeva l’idea, in molti circoli politici e tra gli economisti, che – come ha scritto Antonio Calabrò – l’economia andasse guidata alla ricerca di un equilibrio tra logiche di mercato, libertà degli imprenditori ed esigenza di una crescita più graduale. Il termine “programmazione” – diverso da “pianificazione” che sapeva troppo di dirigismo e ricordava i modelli negativi dell’economia pianificata sovietica – invadeva il mondo economico, politico e culturale e il dibattito si faceva acceso. L’Assemblea di Assolombarda del 5 aprile 1963 diventava l’occasione per far sapere all’opinione pubblica il proprio pensiero sull’argomento: «La programmazione potrà essere un bene o una disgrazia per il nostro sistema economico» – scandiva Dubini – «a seconda delle politiche che attraverso di essa verranno condotte. Avrà effetti positivi solo se riconoscerà e favorirà il funzionamento del mercato quale mezzo di determinazione delle scelte economiche».

Pubblicità della lavatrice super automatica WA 2 S Siemens Elettra, 1963. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Nella stessa sede, il Presidente dell’Associazione commentava il grande avvenimento che aveva contraddistinto gli ultimi mesi del 1962: l’approvazione della legge per la nazionalizzazione delle società produttrici di energia elettrica e la creazione dell’ENEL. Dubini sosteneva inoltre che le conseguenze si sarebbero viste solo in futuro, ma era altrettanto sicuro che le ragioni di carattere economicotecnico addotte per spiegare la nascita della compagnia elettrica statale – in breve, l’incapacità dell’iniziativa privata di sostenere il forte aumento di domanda – erano false, e che anzi il settore elettrico privato aveva sempre risposto con efficacia alle richieste del sistema economico, essendone riprova il sostegno fornito al recente sviluppo industriale italiano. Esprimendo piena solidarietà alle aziende espropriate, si soffermava anche su un altro aspetto che riguardava le modalità del rimborso agli innumerevoli azionisti. Le migliaia di risparmiatori avevano ragione non solo nel giudicare lesivo il modo in cui erano stati valutati i beni espropriati, ma anche nel criticare il principio di dilazione del pagamento in dieci anni che riversava proprio sugli azionisti, con l’aumento dei prezzi, una parte del costo dell’operazione23.
Si vedano le relazioni del Presidente all’Assemblea Generale del 5 maggio 1960, del 3 maggio 1961 e del 28 marzo 1962 (Archivi Assolombarda). Interessanti anche i due contributi pubblicati in «L’Industria Lombarda»: Le imprese private hanno contribuito per i nove decimi allo sviluppo della produzione industriale dell’anno scorso, 6 maggio 1961, pp. 1-3, e Iniziativa privata ed economia di mercato risolveranno sicuramente i gravi problemi rimasti insoluti fin dall’inizio dell’Unita d’Italia, 31 marzo 1962 pp. 1-3.
È tempo di scelte e simboli, Gio Ponti progetta la nuova casa di Assolombarda
L’Assemblea si teneva i primi giorni di aprile del 1963 ed era la prima ospitata dalla nuova sede di Assolombarda in via Pantano n. 9, a poca distanza dal Duomo. Erano passati cinque anni da quando era stato deciso di abbandonare gli uffici in affitto di via Torino che, negli anni, erano diventati insufficienti a ospitare un’organizzazione che dal dopoguerra si era sempre più allargata e strutturata. Non erano stati risolutivi i diversi interventi di ristrutturazione e i ripensamenti degli spazi, tanto che alcuni uffici avevano dovuto trovare una sede diversa con tutte le difficoltà organizzative che ne conseguivano. Sullo sfondo c’era poi l’idea di avere, a distanza di quasi quarant’anni dalla costituzione della Federazione Industriale Lombarda, una sede propria all’altezza dell’importante ruolo economico-sociale da sempre svolto dall’Associazione.
Niente di nuovo, in realtà. Già negli anni Trenta, infatti, era stata acquistata una porzione di terreno prossima a piazza Cavour dove già si trovava l’ex Politecnico, ma lo scoppio della guerra aveva di fatto arrestato il progetto. Approvata la decisione di realizzare la nuova sede, l’Associazione individuò un’area in via Pantano, tra via Larga e l’Università Statale, per poi bandire un concorso nel 1960. L’edificio a corte doveva rispettare la tradizione cittadina in linea con un certo stile di sobrietà e riservatezza tipico della borghesia imprenditoriale lombarda.

Cortile di Palazzo Assolombarda, Milano. Archivi Assolombarda.
Il progetto vincente portò la firma dell’architetto Gio Ponti che, nel presentarlo alla stampa, sottolineava come «l’intera struttura dell’edificio voleva essere l’espressione dell’evoluzione tecnologica della stessa industria moderna». Lo Studio Ponti, noto in tutto il mondo per aver progettato, tra gli altri, il Grattacielo Pirelli, realizzava un edificio in acciaio e cemento armato di sei piani fuori terra e due interrati – uno dei quali ospitava l’auditorium di 500 posti – su una superficie complessiva di circa 7.000 metri quadrati. Il risultato finale era davvero notevole, un vero e proprio modello di razionalità e praticità nell’organizzazione degli interni arredati con la consueta cura ed eleganza24. Tra il 1978 e il 1979 saranno riorganizzati alcuni spazi interni arricchiti da una biblioteca e da nuove sale riunioni, mentre l’auditorium verrà ristrutturato. La crescita dell’Associazione riaprirà nuovamente la questione degli spazi. La soluzione immediata sarà quella di affittare un intero piano in un edificio adiacente alla sede e, nel contempo, progettare un nuovo intervento edilizio. All’inizio di luglio 1987 verrà inaugurata una nuova palazzina di quattro piani, uno interrato, che si affaccia su via Chiaravalle, la quale ospiterà i diversi uffici all’esterno della sede storica. Nei primi anni Duemila, quest’ultima verrà sottoposta a un intervento di restauro che restituirà al palazzo la sua originale bellezza.
Tornando ai primi anni Sessanta, nel marzo del 1963 era stato creato in Assolombarda l’Ufficio stampa. Nel luglio seguente i suoi quadri erano stati completati e la struttura era in grado di svolgere le sue due funzioni principali: la divulgazione delle notizie interne e la raccolta di quelle esterne. Le motivazioni che aveva portato alla nascita dell’ufficio erano la semplice constatazione del moltiplicarsi delle fonti d’informazione e, per così dire, la maggiore importanza dell’opinione pubblica.
A fronte di un flusso crescente di informazioni, era quanto mai necessario raccogliere, selezionare e interpretare le notizie provenienti dal mondo esterno. Allo stesso tempo, occorreva avere uno strumento in grado di divulgare e valorizzare le opinioni e i risultati ottenuti dall’Associazione. C’era poi un altro aspetto assai rilevante che derivava dal mutare della congiuntura economica degli anni del “boom”. Il 1963, infatti, segnava la fine del “miracolo economico” e il ritorno a una realtà fatta di rivendicazioni salariali, una troppo rapida crescita dei prezzi accompagnata da una stretta creditizia e da una perdita di competitività delle esportazioni.
Dopo un periodo forse irripetibile, il risveglio aveva un sapore amaro. Ai vertici dell’Associazione non era affatto sfuggita – come evidenziava lo stesso Presidente Emanuele Dubini nel corso della sua relazione all’Assemblea del 9 aprile 1964 – la tendenza crescente di “politicizzare” fatti, avvenimenti e fenomeni di ogni genere finendo spesso per distorcerne il significato «secondo interpretazioni di comodo subordinate a finalità politiche».
Sulla nuova sede di via Pantano, cfr. Un nuovo palazzo per l’Assolombarda, in «Corriere della Sera», 17 giugno 1958, p.4, e Una nuova sede per l’Assolombarda, in «Corriere della Sera», 3 aprile 1963, p. 4. Cfr. anche Nella moderna e funzionale sede dell’Assolombarda saranno potenziati i servizi per le 6.600 aziende rappresentate, in «L’Industria Lombarda», 6 aprile 1963, p. 3. Riferimenti anche nelle relazioni del Presidente Furio Cicogna del 3 aprile 1957, 28 marzo 1958 e 5 maggio 1960, e in quelle del suo successore, Emanuele Dubini, del 5 aprile 1963 e 9 aprile 1964 (Archivi Assolombarda).
Imprese in cerca di crescita: investimenti per la produttività in attesa della programmazione
Il 1964 segnava un deciso colpo di freno alla crescita economica nazionale. La produzione industriale, dopo aver toccato il suo massimo nel biennio 1961-1962, si arrestava bruscamente. Il termine “recessione” diventava comune. Intanto, sul finire del 1963, si era avuta un’importante svolta politica. Per la prima volta nella giovane storia della Repubblica Italiana, i socialisti entravano nella compagine governativa guidata da Aldo Moro. Nasceva il centrosinistra. Il Paese aveva bisogno di grandi riforme strutturali economiche e sociali, ma le aspettative sarebbero andate deluse. Più volte annunciate, le riforme non si facevano o andavano troppo a rilento e – come ha scritto Calabrò – il «centrosinistra si avvita in una spirale di ambizioni-frustrazioni, velleità-delusioni che ne determina la crisi per “riforme mancate”».
La difficile situazione economica innescava nuove discussioni su quale indirizzo dare all’industria nazionale. All’interno di Assolombarda e di Confindustria i punti di vista coincidevano. Per rispondere al particolare momento economico, la ricetta era sempre la stessa: ridurre i costi di produzione. Solo questo avrebbe permesso di combattere le pressioni inflazionistiche e di recuperare competitività sui mercati. Oltre ad agire sui costi, era necessario aumentare la produttività, specie attraverso l’incremento del rapporto capitale/lavoro, in altre parole: investire. La palla passava ora alla politica, ma la risposta non avrebbe soddisfatto le aspettative degli industriali. Mancava una chiara politica d’incentivazione degli investimenti, concetto condiviso e raccomandato peraltro dal Consiglio Nazionale dell’Economia, unita a forti opposizioni da parte di certi ambienti politici per i quali – come ricordava Dubini all’Assemblea del 7 maggio 1965 – «il nostro intento è di sabotare un’azione tendente allo sviluppo sociale del Paese, e ciò per provocare una situazione tale da coinvolgere in una crisi generale la formula politica attuale».
A proposito dei rimedi alla crisi, il Presidente affermava: «Il problema della spartizione della torta non deve diventare tale da impedire che questa diventi ogni anno più grande, così che tutti possano averne ogni anno una fetta maggiore». Si tornava a parlare di programmazione e il parere degli industriali era molto chiaro. Il settore privato avrebbe collaborato a una programmazione solo se questa avesse avuto lo scopo di eliminare le distorsioni che non solo impedivano l’equilibrio di mercato, ma l’avrebbero reso più elastico alle variazioni della domanda dei consumatori.

Viale dell’industria alla Fiera Campionaria di Milano del 1973. Archivio Fondazione Fiera Milano.
C’era poi un altro aspetto che andava migliorato. In qualsiasi iniziativa di programmazione ci doveva essere un’estrema chiarezza nei mezzi e negli obiettivi da raggiungere. Non sfuggiva di certo, nel mondo confederale, come anche i tanti governi di centrosinistra che si avvicendavano annunciassero senza sosta riforme il cui destino era la mancata attuazione o il procedere troppo a rilento. Le diverse “riforme mancate” coglievano un aspetto della politica del tempo: il suo avvitarsi in una spirale di ambizioni e frustrazioni, di velleità e di delusioni.
Nella storia del capitalismo italiano, il 1966 segna un momento importante con la fusione tra la Edison e la Montecatini e la nascita della Montedison. Quello delle fusioni e delle concentrazioni era un tema che Assolombarda aveva iniziato a trattare da qualche anno, soprattutto in seguito alla nazionalizzazione del sistema elettrico. Per l’Associazione di via Pantano il processo di aggregazione andava accelerato seguendo anche l’esempio estero. Questi passaggi aziendali, spiegava Dubini alla fine dell’aprile di quell’anno, erano necessari, e faceva qualche esempio. Erano utili quando i costi per la ricerca erano rilevanti come nel settore chimico, quando il ciclo produttivo aveva bisogno di impianti molto grandi come nella siderurgia e, infine, quando occorreva avere una rete di vendita molto vasta come nel caso dell’alimentare e del tessile. Va detto che, il 18 marzo 1965, era stata salutata con favore l’approvazione della legge n. 170 sul Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali perché andava nella direzione indicata dall’Europa.

Area espositiva Italsider alla Fiera Campionaria di Milano del 1964. Archivio Fondazione Fiera Milano.
Le aziende dovevano avere dimensioni più grandi perché questo chiedevano il mercato, il progresso tecnologico e il generale processo di liberalizzazione degli scambi internazionali. L’economicità di gestione era un concetto valido anche per le piccole e medie imprese che dovevano puntare sulla specializzazione produttiva. Nel suo discorso, il Presidente si soffermava anche sul ruolo dell’impresa all’interno del sistema economico, e lo faceva riportando una citazione di Luigi Einaudi: «Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli [...], è la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ampliare gli impianti [...] costituiscono una molla di progresso, altrettanto potente che il guadagno».
La ripresa del mercato delle auto tra il 1965 e il 1966 sottolineava il superamento della fase di recessione. La situazione, tuttavia, rimaneva “delicata” e sulle prospettive future pesavano tre questioni: la crisi del settore edilizio residenziale con tutte le ripercussioni per le industrie fornitrici, il basso livello degli investimenti produttivi e, infine, il carico eccessivo della spesa pubblica. Preoccupava anche una certa ripresa dell’attività sindacale. L’Assemblea del 4 aprile 1967 diventava occasione per tornare sull’ormai “storica” mancata attuazione dell’articolo 40 della Costituzione e, dunque, sulla conseguente inesistenza della necessaria regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero in esso sancito. Nessun dubbio da parte industriale che lo sciopero fosse un diritto e, come tale, andasse tutelato, ma si continuava a ignorare entro quali limiti potesse essere esercitato.
Nasceva anche un altro problema: le procedure di composizione pacifica delle controversie di lavoro non avevano nessun rilievo, e questo a differenza di molte nazioni europee, come per esempio la Francia, dove il tentativo di conciliazione era espressamente imposto dalla legge. Uno studio statistico realizzato da Assolombarda nel 1965 aveva anche evidenziato che l’arma dello sciopero era largamente utilizzata in Italia. Su mille lavoratori dipendenti, infatti, si erano avuti in media 2 giornate di sciopero in Germania, 20 in Belgio, 70 in Francia, 130 in Inghilterra e ben 570 in Italia.
Tra le iniziative avviate da Assolombarda in questo periodo particolarmente importante si rivelava, sul finire del 1967, la creazione del Consorzio garanzia collettiva fidi in collaborazione con la Camera di commercio di Milano e di alcune grandi aziende. La questione dei finanziamenti alle imprese, come si è visto, era da sempre presente nell’azione associativa, ma, ormai da alcuni anni, era sempre più evidente che la politica del credito in Italia denunciava una netta tendenza a rinunciare alla neutralità e a effettuare scelte preferenziali a favore di settori e aziende a danno di altre. In quest’ottica, l’attività del Consorzio sarebbe servita a riequilibrare il più possibile la situazione25.
Si vedano la relazioni del Presidente del 9 aprile 1964, 7 maggio 1965 e 29 aprile 1966 (Archivi Assolombarda). Si veda anche quanto scritto da A. Calabrò, Le radici forti..., cit., p. 29 e quanto riporta l’articolo Gli imprenditori sempre pronti a dare ogni loro energia per risolvere i problemi di fondo dell’economia nazionale pubblicato in prima pagina su «L’Industria Lombarda» dell’8 maggio 1965. Sempre sul periodo, si vedano gli articoli pubblicati nel «Corriere della Sera» Gli imprenditori chiedono chiarezza in politica economica, 8 maggio 1965, p. 8, e Dubini: anche gli imprenditori devono fasi una nuova mentalità, 29 gennaio 1966, p. 5.
Il mercato dell’auto traina la ripresa. Nasce il Consorzio fidi per il credito alle imprese
Tra il 19 e il 20 maggio 1968, si svolgevano in Italia le elezioni politiche che segnavano la vittoria della Democrazia cristiana e la sconfitta del centrosinistra, frutto della debolezza riformatrice e delle tante speranze deluse di un Paese in bilico tra ansia di cambiamento, riforme e spinte conservatrici. Sull’esperienza politica degli ultimi anni, il giudizio di Assolombarda non poteva che essere negativo. «Si era accentuata» – come riferiva Dubini – «la tendenza alla riduzione del grado di libertà del nostro sistema economico sia in senso quantitativo, attraverso l’eccezionale espansione delle attività gestite dallo Stato, e sia in senso qualitativo, tramite il crescente condizionamento dell’azione pubblica. Non bisognava imbrigliare il meccanismo di sviluppo». Veniva anche criticato il comportamento di alcune parti di governo che avevano prima chiesto la collaborazione degli industriali senza preclusioni pregiudiziali per poi non tenere quasi conto delle loro opinioni. E mentre si tornava a parlare di «una nuova formula per il Paese, di contrattazione programmatica e di un’auspicabile collaborazione tra il settore pubblico e quello privato», le rivolte studentesche, a Roma come a Parigi, diventavano sempre più dure e difficili da spegnere.
I tanti problemi irrisolti e le “riforme mancate” avevano creato una miscela esplosiva. In tante città italiane si registravano massicce proteste di piazza, con scontri anche violenti tra gli studenti e le forze dell’ordine. A loro si sarebbero aggiunti, con il 1969, i primi scioperi e cortei operai. In un clima sempre più incandescente, Assolombarda era ancora una volta un simbolo da colpire. Alle 3 di notte del 26 giugno dello stesso anno, due bombe molotov venivano lanciate contro la sede di Assolombarda e poco dopo due giovani venivano visti allontanarsi su una Fiat 500. Era il trentasettesimo attentato a Milano dall’inizio dell’anno.

Operai al lavoro nel reparto calandratura e saldatura cerchioni alla Gianetti di Ceriano Laghetto (MI), 1969. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Nel dicembre seguente, una drammatica esplosione, un evento sconvolgente che avrebbe segnato lo Stato italiano negli anni successivi: lo scoppio di una bomba nella filiale della Banca dell’Agricoltura in piazza Fontana, uccideva 17 persone e ne feriva 88. Si iniziava a parlare di “strategia della tensione”: la protesta si era trasformata in qualcos’altro. Il terrorismo, rosso e nero, avrebbe a lungo tenuto in ostaggio lo Stato e il Paese.
Il 1969 faceva anche registrare il record di ore di lavoro perse: ben 54 milioni. Nell’ultima parte dell’anno, il cosiddetto “autunno caldo”, la mobilitazione operaia e la contestazione studentesca si erano saldate alle agitazioni per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Questa vicenda sarebbe finita nella tarda mattinata del 21 dicembre con la firma dei nuovi accordi di lavoro, ma molte cose erano cambiate per sempre.
Che gli anni Sessanta sarebbero volti al termine in un clima generale completamente diverso da come si erano aperti in pieno “miracolo economico” lo si era già intuito nel 1968, anno che si era chiuso, per l’industria nazionale, con un risultato economico soddisfacente, accompagnato però da un calo della propensione al consumo dovuto a ragioni sia tecniche sia psicologiche.
Anche gli industriali lombardi, infatti, denunciavano il disorientamento, l’incertezza e la sfiducia nella società del tempo, così come, dalla seconda metà dell’anno, l’inizio di un’ondata di scioperi «con carattere di violenza e illiceità» che avevano turbato l’attività economica e l’opinione pubblica, già fortemente impressionata dal dilagare delle agitazioni studentesche iniziate in primavera. La protesta degli studenti aveva influenzato il fronte sindacale italiano che si doveva confrontare con nuove forme di rivendicazioni diverse da azienda ad azienda e l’affermarsi di una massa operaia più radicalizzata che contribuiva a far assumere ai movimenti di protesta un «tono eversivo e massimalista».

Addetta in un laboratorio allo stabilimento Helene Curtis, Milano, 1962. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Il 1968 si chiudeva in un’atmosfera pesante, che faceva presagire un inasprimento dei conflitti di lavoro dentro e fuori le fabbriche. Il 5 dicembre una manifestazione degli studenti delle scuole professionali si concludeva davanti alla sede di Assolombarda che, di lì in avanti, diventerà punto d’arrivo di molti cortei di protesta.
Il 1969 si sarebbe confermato un anno tra i più difficili per l’economia italiana. Soltanto per la provincia di Milano, l’Associazione industriali accertava 850 violazioni di uffici e stabilimenti con occupazioni, decise spesso direttamente dai lavoratori, che in alcune aziende erano durate settimane intere. L’aprirsi della stagione dei grandi rinnovi contrattuali, in primo luogo quello dei metalmeccanici in luglio, aveva esasperato un clima già di suo molto acceso. Nel maggio del 1969, ancora una volta, due molotov venivano lanciate contro la sede di via Pantano.
Nei mesi successivi, le manifestazioni, in cui s’infiltravano gruppi estremisti, finirono quasi sempre per degenerare in scontri con le forze dell’ordine e con devastazioni e danneggiamenti. Intimidazioni, blocchi stradali e attacchi ai “simboli del potere”, tra cui la sede di Assolombarda, contro cui venivano lanciate bombe incendiarie, facevano del capoluogo lombardo il centro della protesta operaia. Tra il 27 e il 31 ottobre, via Pantano veniva presidiata da picchetti di operai metalmeccanici cui si contrapponeva un doppio cordone di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri schierato a protezione della sede di Assolombarda26.
Si vedano la relazioni del Presidente all’Assemblea del 5 aprile 1968 e del 7 maggio 1969 (Archivi Assolombarda). Si veda anche quanto scritto da A. Calabrò, Le radici forti..., cit., pp. 27 ss. e l’articolo Attentato all’Assolombarda, in «Corriere della Sera», 29 giugno 1969, p. 8.
Comincia l’autunno caldo. Le imprese nella morsa di una conflittualità crescente
La relazione sull’attività di Assolombarda per il 1968 era stata dedicata ai problemi connessi alla vita associativa. Le aziende che ne facevano parte superavano di poco le 3.700 unità e rappresentavano la totalità delle grandi e medie imprese e la maggioranza delle piccole operanti nella provincia di Milano. Rispetto a dieci anni prima, c’era una certa costanza nei numeri che però nascondeva un’intensa dinamica interna. Il turnover nel periodo era stato notevole. Molte nuove aziende erano entrate nell’Associazione, altrettante avevano chiuso o si erano trasferite altrove: tutti segni evidenti della grande vitalità e capacità di trasformazione dell’economia milanese. Quanto da tempo auspicato da Assolombarda stava pienamente avvenendo. I processi di concentrazione erano sempre più frequenti e coinvolgevano le imprese ad alto contenuto tecnologico e di capitali cui si contrapponeva il decentramento di attività industriali più tradizionali ad alto contenuto di manodopera.

Sit-in del movimento studentesco in piazzale Loreto, Milano, 1° maggio 1970. Fotografia di Uliano Lucas, Archivio Uliano Lucas.
Questa tendenza aveva finito per aumentare la propensione di Milano e della Lombardia ad assumere un ruolo particolare nello sviluppo economico nazionale, ossia quello di centro di servizi e di direzione delle attività produttive. Di pari passo, infatti, si era assistito a un forte potenziamento del settore terziario e al fiorire di nuove attività commerciali, creditizie, assicurative e di trasporti. Milano rimaneva il riferimento anche per quelle aziende che avevano trasferito altrove la produzione ma avevano deciso di mantenere la sede e la direzione nel capoluogo lombardo.
Tra le aziende associate, il settore metalmeccanico confermava la sua storica importanza con circa metà delle iscritte, e questo valeva sia in relazione al numero di aziende sia in termini di occupazione, con un’incidenza, sul totale, pari al doppio del dato nazionale. A seguire, le imprese chimiche, della gomma e della plastica che insieme rappresentavano i settori numericamente più in crescita all’interno dell’Associazione, anche in questo caso, sia per numero di società che per dipendenti.

Funerali delle 14 vittime uccise nell’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, Milano, 1969. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
Passando all’attualità, Assolombarda si allineava sulla posizione espressa del Presidente di Confindustria Angelo Costa, che aveva espressamente condannato la violenza del periodo e, al tempo stesso, evidenziava la necessaria evoluzione dei rapporti industria-mondo del lavoro, per effetto delle profonde trasformazioni delle strutture economiche e della società. L’esempio da seguire arrivava dalla Gran Bretagna, dove il governo laburista aveva da poco presentato il “Libro bianco”, con l’obiettivo di formulare una nuova legislazione organica per regolare i conflitti di lavoro e gli scioperi.
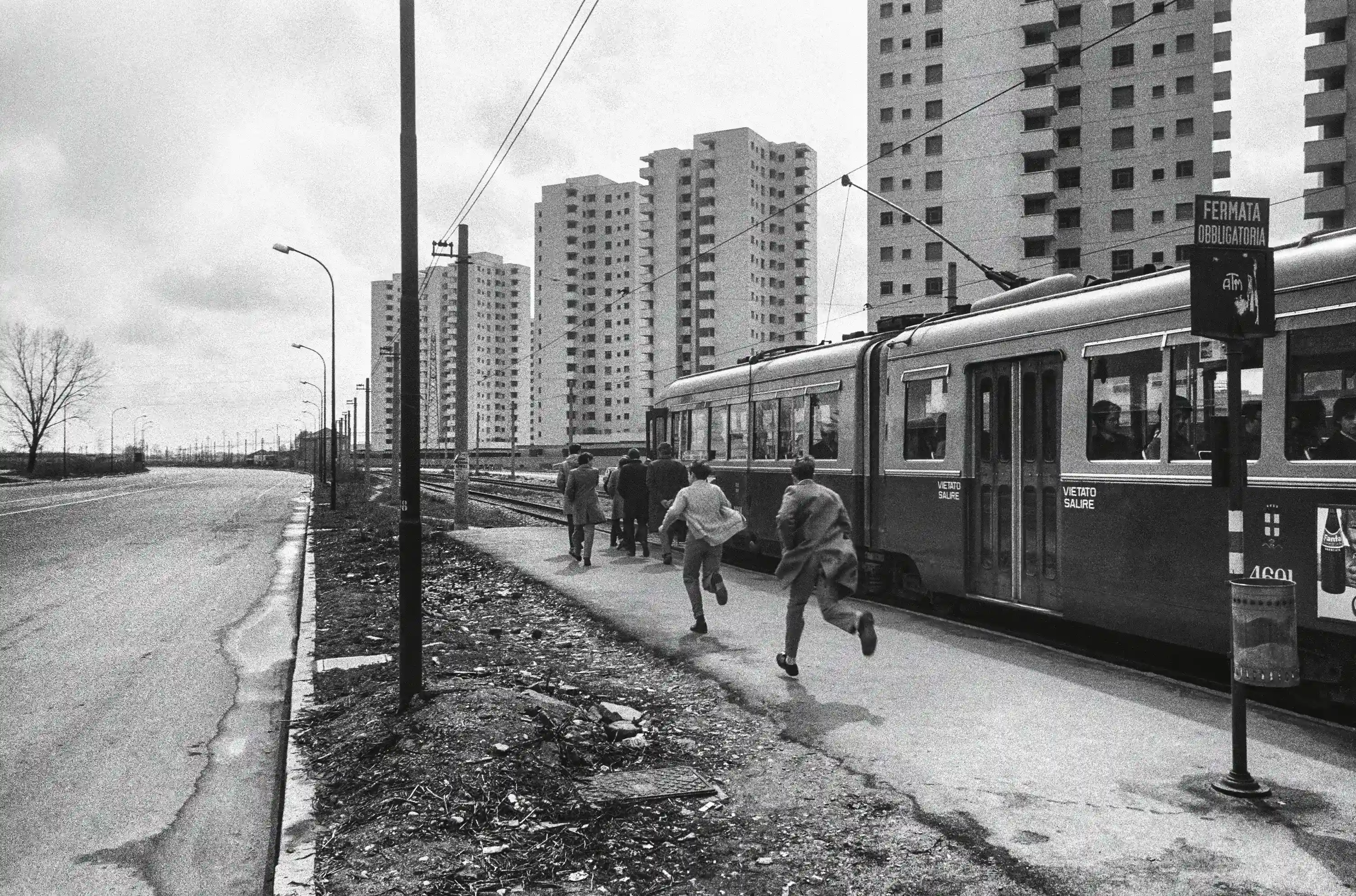
Quartiere Gratosoglio, Milano, 1971. Fotografia di Uliano Lucas, Archivio Uliano Lucas.
Del resto, l’attività sindacale si era fatta via via più intensa e il numero delle vertenze era più che raddoppiato. La spiegazione non andava ricercata soltanto nell’andamento congiunturale quanto soprattutto nella maggiore politicizzazione del sindacato (non a caso, le vertenze per licenziamenti collettivi erano state inferiori della metà). Il rapido aumento dei conflitti sindacali non era motivato dalla mancata applicazione dei contratti collettivi ma – come veniva detto nella relazione del 1969 – «dalla pretestuosa impostazione da parte dei sindacati operai di vertenze interpretative che, nella realtà, sono determinate da pure e semplici pretese innovative di contratti liberamente stipulati e sottoscritti». Completavano il quadro i tempi molto lunghi del lavoro della magistratura, unita a una certa impreparazione tecnica di coloro che avrebbero dovuto applicare la normativa sul lavoro27.
Si vedano le relazioni del Presidente all’Assemblea del 5 aprile 1968 e del 7 maggio 1969 (Archivi Assolombarda).

Presidio e comizio davanti alla sede di Assolombarda durante uno sciopero dei lavoratori, Milano, 1969. Fotografia di Silvestre Loconsolo, Archivio del Lavoro.
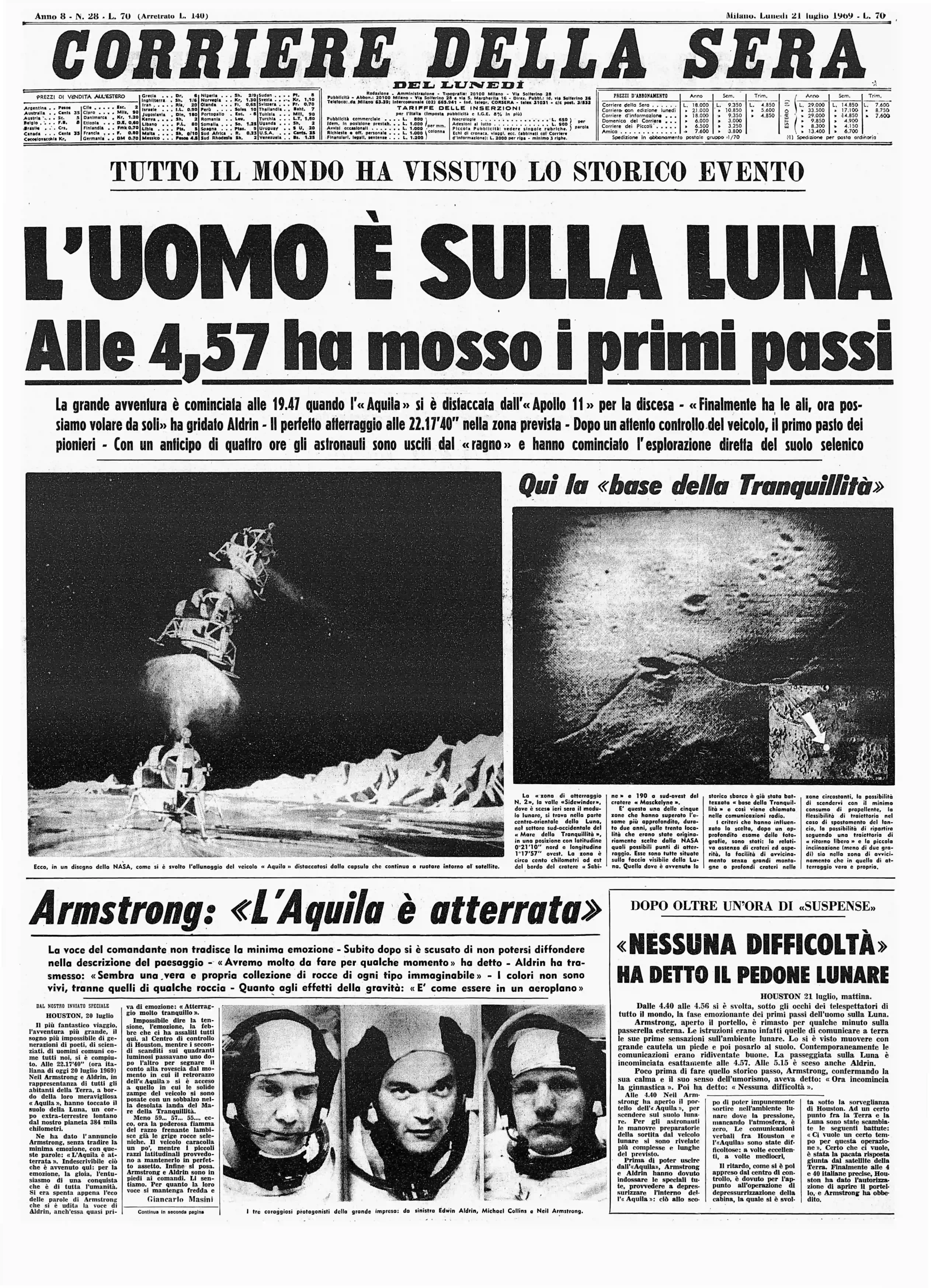
I Giovani Imprenditori rivendicano un maggior peso progettuale e politico
La pagina “Economia e Finanza” del «Corriere della Sera» del 6 maggio 1966 riportava la notizia che presso la sede di Assolombarda si era tenuto il primo convegno regionale dei giovani industriali. Erano intervenuti delegati e rappresentanti dei gruppi di Milano, Monza, Busto Arsizio, Brescia, Como e Mantova, oltre a una trentina di partecipanti arrivati da altre regioni italiane. Tema dell’incontro, un primo bilancio sull’attività dei gruppi regionali28.
Il Gruppo Giovani Industriali era stato istituito nel 1964 seguendo il dettato di una circolare confederale di qualche tempo prima. Come risultato di un’intensa e impegnativa serie di incontri nei quali erano stati precisati e messi a fuoco – come riporta la relazione del 1967 – «i motivi stessi della propria esistenza e validità», l’attività si articolava in tre direzioni distinte: quella sindacale, quella dell’organizzazione aziendale e quella dei Piani d’informazione, che comprendevano diverse tematiche tra cui lo studio del comportamento, le motivazioni sul lavoro e la comunicazione aziendale, oltre all’organizzazione di una serie di conferenze alle quali venivano invitati importanti esponenti del mondo imprenditoriale milanese.
«Corriere della Sera», 3 maggio 1966, p. 9.

Prima giornata senza benzina in piazza del Duomo, Milano, 2 dicembre 1973. Fotografia di Uliano Lucas, Archivio Uliano Lucas.
Mentre a Milano il Gruppo prendeva forma, a Torino i Giovani Imprenditori – sostenuti in questo da Gianni Agnelli che nel 1966 era stato nominato Presidente della Fiat al posto di Vittorio Valletta – avviavano una profonda riflessione sul sistema di rappresentanza che avrà importanti effetti sulla struttura confederale. Il punto di partenza – come ha scritto Giuseppe Berta nel suo L’Italia delle fabbriche – era la consapevolezza che il ceto industriale non godeva affatto di una buona immagine e tanto meno di una buona stampa: «L’industria era meno percepita come il canale di promozione individuale e collettiva come in passato e più come l’origine di squilibri sociali, territoriali, di disuguaglianze, di disparità di diritti». Se negli ambienti politici, e in alcune parti della società, l’industria veniva vista con diffidenza e sospetto era anche a causa di una rappresentanza industriale, di cui Confindustria era il simbolo, che appariva chiusa, priva di ricambio nel suo ceto dirigente e «arcigna quanto alle pratiche e ai riti interni che ne esasperano la distanza dalla società». Questa spinta alla modernizzazione proveniente dal Gruppo Giovani Imprenditori piemontesi – che si concretizzava anche attraverso la realizzazione di un fascicolo di 300 pagine dal titolo Una politica per l’industria, realizzato dal Centro Einaudi – concorreva all’avvio del processo di riforma di Confindustria. Punto d’avvio era l’istituzione di una commissione presieduta da Leopoldo Pirelli allo scopo di riformare lo Statuto confederale29.
Cfr. anche Giuseppe Berta, L’Italia delle fabbriche, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 180 ss.
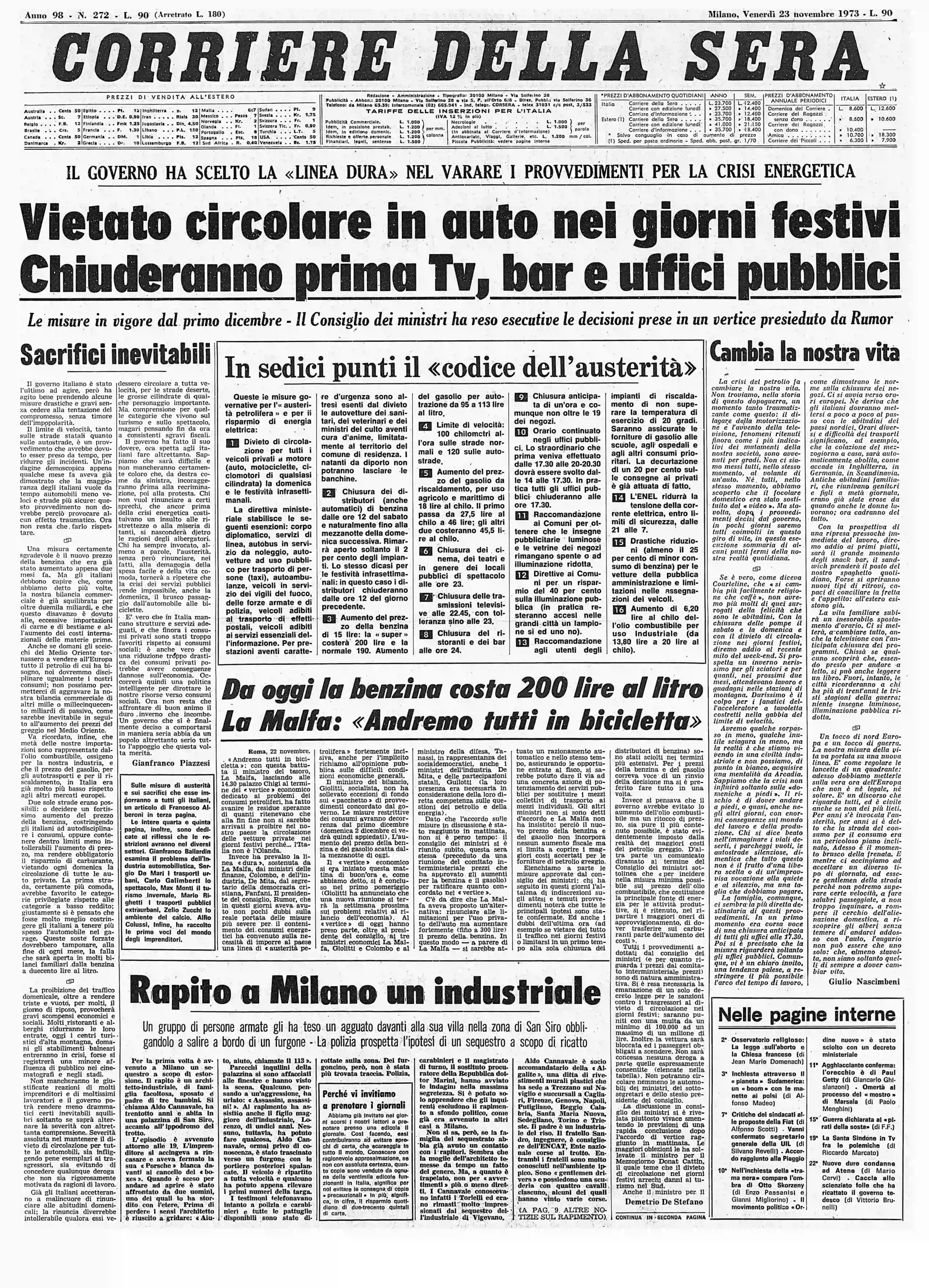
Dal “Rapporto Pirelli” al nuovo Statuto di Assolombarda
Dall’aprile del 1969 al febbraio dell’anno seguente, la commissione si sarebbe incontrata ogni lunedì a Milano, ai piani alti del Grattacielo Pirelli. Nel documento finale, noto come “Rapporto Pirelli”, l’aspetto più rilevante – secondo Berta – è proprio «la sintesi politica in cui veniva declinata in modo nuovo la funzione imprenditoriale nella società e si tracciavano i contorni di una Confindustria decisa a passare all’iniziativa su tutti i fronti, dai rapporti con il sindacato a quelli con il sistema politico e le istituzioni». La successiva riforma statutaria, approvata nell’aprile del 1970, portava a cascata a una riorganizzazione dell’azione associativa, anche a livello locale, secondo le nuove linee decise a Roma. Il 22 marzo 1971, l’Assemblea Generale di Assolombarda dava il via libera ad alcune modifiche del proprio Statuto. Ad annunciarle era il nuovo Presidente, il milanese Giuseppe Pellicanò, Amministratore delegato e Direttore Generale della Tecnomasio Italiano Brown Boveri e Presidente degli industriali di Legnano, eletto il giorno prima, subentrando a Emanuele Dubini, diventato, nel frattempo, Vicepresidente di Confindustria. Commentando alla stampa la nuova carta statutaria, Pellicanò diceva: «Particolare importanza verrà data ai rapporti esterni soprattutto per un costante contatto con coloro che son più vicini al mondo industriale e al nascente Centro Studi – che sarà guidato dal futuro Presidente Antonio Coppi – che deve essere considerato la cerniera fra mondo industriale e mondo culturale lombardo». Il cambiamento era sostanziale. L’attività veniva articolata per linee nelle quattro funzioni previste dall’organigramma confederale: rapporti economici, rapporti sindacali, rapporti esterni e, infine, rapporti interni. La nuova struttura interna, come detto, rifletteva la volontà di Confindustria di rafforzare la propria organizzazione e, al contempo, di renderla più moderna alla luce delle grandi trasformazioni politiche e sociali degli ultimi anni. L’Italia aveva conosciuto un grande sviluppo economico, era tra le nazioni più ricche al mondo e questo grazie soprattutto all’industria e agli industriali. Di fronte a questa nuova realtà, le associazioni, che per decenni avevano mantenuto un atteggiamento per lo più difesivo, dovevano diventare parte attiva nei processi di cambiamento in corso. Settore vitale dell’economia italiana, l’industria e il suo sistema di rappresentanza non potevano più limitarsi a difendere specifici interessi di categoria, ma dovevano ampliare la loro sfera d’azione in campo economico e sociale.

La statua di re Vittorio Emanuele II impacchettata: performance dell’artista Christo Javacheff in piazza del Duomo, Milano, 1970. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.
In concreto, nel dicembre del 1971, un team di consulenti venne incaricato da Assolombarda di realizzare un’indagine analitica sul funzionamento degli uffici e di formulare eventuali proposte di miglioramento organizzativo. Nel settembre dell’anno successivo, si passò alla fase attuativa e l’attività venne incentrata sulle quattro linee operative di cui abbiamo appena parlato. Sempre nel 1972, si registrava il primato di nuove adesioni all’Associazione, con 348 nuove aziende. A spingere le imprese a entrare a far parte di Assolombarda non era solo il difficile periodo economico, ma anche la crescita dei servizi offerti ai soci. Oltre alla nascita del Centro Studi, infatti, venivano promosse diverse iniziative che affrontavano le questioni più urgenti del periodo, come per esempio i corsi propedeutici all’introduzione dell’IVA tra il 1972 e il 1973, che ottennero un grande successo con l’adesione di oltre 900 aziende e tutta una serie di servizi di consulenza sul tema dell’inquinamento e della protezione dell’ambiente. Ancora, nel 1971, in seguito all’approvazione del nuovo regolamento statutario, il Gruppo Giovani Industriali assumeva la nuova denominazione di Gruppo Giovani Imprenditori, forte di 440 iscritti, e, allo stesso tempo, ne venivano meglio precisati gli scopi istituzionali. Insieme all’impegno a «sollecitare negli Imprenditori Giovani lo spirito associativo», doveva promuovere, «nel contesto di una libera società in sviluppo, il comportamento proprio dell’imprenditorialità e la coscienza dei valori sociali e civili». Alla formazione professionale, attraverso corsi, dibattiti e contatti con altri gruppi e associazioni, si sarebbe aggiunto un costante apporto di idee e d’azione all’interno dell’Associazione Industriale Lombarda nonché lo sviluppo dei rapporti con tutte le parti sociali30.
Cfr. Al di là delle sfide, in «Corriere della Sera», 22 gennaio 1970, p. 5, e La nuova Confindustria, in «Corriere della Sera», 21 febbraio 1970, p. 7. Sul “Rapporto Pirelli”, cfr. anche G. Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., pp. 188 ss.
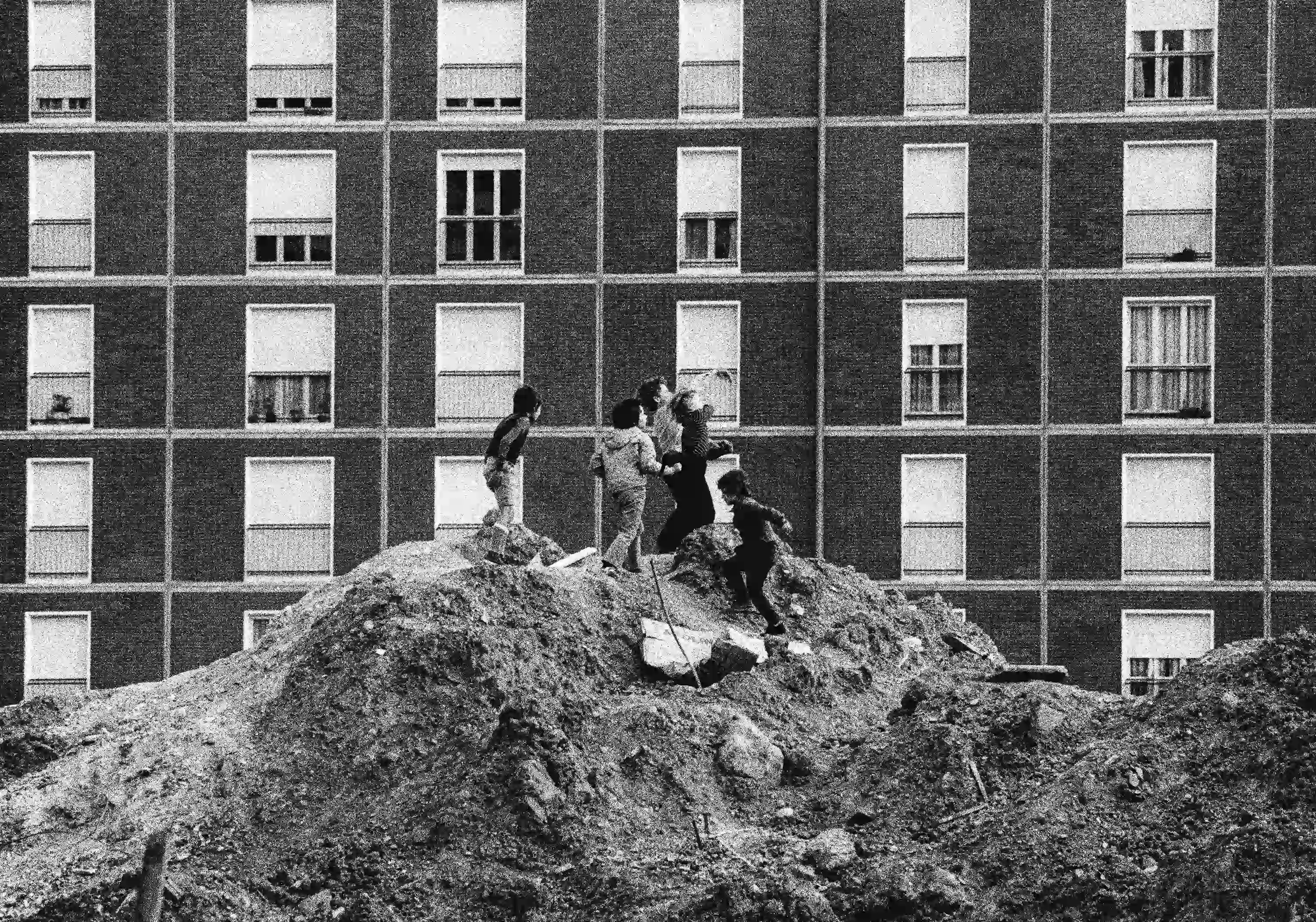
Ragazzi giocano su un mucchio di terra nel quartiere Sant’Ambrogio, Milano, 1970-1973. Fotografia di Gabriele Basilico, Archivio Gabriele Basilico.
Nel cuore degli “anni di piombo”, lo Statuto dei lavoratori e la linea sindacale Assolombarda
La riforma confederale entrava in vigore in un periodo storico – come ha scritto Antonio Calabrò nel già citato volume Storie del Grattacielo – «carico di forti, radicali tensioni politiche e sociali. Erano gli anni di piombo, secondo uno stereotipo di successo». Le parole chiave della prima metà degli anni Settanta evocavano la realtà: terrorismo, scioperi e shock petrolifero. La risposta politica dei governi rimaneva debole, si cedeva alle rivendicazioni, ma senza indicare prospettive concrete. E l’aumento della spesa pubblica era lo strumento più usato con un’unica grande controindicazione: la pesante inflazione. Si continuava a parlare di programmazione e di “politiche di sostegno”, intese anche a definire i grandi sistemi di relazione che dovevano articolare l’economia italiana. Le due maggiori novità del periodo erano la stesura dello Statuto dei lavoratori nel 1970 e l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 1973. Il primo riconosceva al sindacato la legittimità a essere uno degli attori del sistema di regolazione sociale su cui si articolava il sistema decisionale; la seconda, invece, ridisegnava il modello statale centralista per riconoscere autonomie locali a cui attribuire anche una propria capacità programmatoria. E in vista di questo, già sul finire del 1971, era stata creata la Federazione regionale per le associazioni industriali della Lombardia (in breve Federlombarda), presieduta sempre da Pellicanò, che riuniva i rappresentanti delle diverse organizzazioni territoriali operanti nella regione.
In questi anni, ma sarà così ancora per tutto il decennio, l’azione sindacale di Assolombarda continuò a rappresentare l’impegno principale e caratterizzante. Nel maggio del 1977, solo per fare un esempio, le vertenze a Milano e provincia erano ancora molto numerose, tanto che la sola Assolombarda stava discutendo circa 200 piattaforme contrattuali. La sede di via Pantano continuava a essere uno dei simboli e degli obiettivi della contestazione operaia e studentesca. Agli inizi di dicembre del 1975, una manifestazione si era conclusa con il lancio di sassi e cubetti di porfido che scalfirono i nuovi vetri antiproiettile, gli stessi che nel marzo di due anni dopo resisterono a bombe molotov e colpi di pistola.

Lavoratori presso l’ufficio tecnico allo stabilimento Necchi di Pavia, 1972. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Nel tempo, erano anche cambiati i contenuti della protesta operaia, che non si limitava più a occuparsi dell’ambito contrattuale e salariale, ma utilizzava l’arma dello sciopero anche per ulteriori questioni, come il problema della casa, il peso fiscale, i trasporti e altro ancora. Il rapporto sindacale era diventato il terreno – come riportava la relazione del 1973 – in cui le vicende ideologiche, culturali e politiche trovavano la loro traduzione più diretta e sollecita. Si rendeva allora necessario, per Assolombarda, elaborare e aggiornare la propria linea sindacale specie a fronte del radicarsi di una forte coscienza di classe da parte operaia. Tra le novità introdotte, la principale riguardava la creazione di Zone che riunivano tutte le aziende di quel territorio. Nel 1973, erano attive 11 Zone tra capoluogo e provincia, ma queste raggruppavano soltanto le aziende del settore metalmeccanico. L’attività si concretizzava in frequenti riunioni – oltre 100 solo nel 1974 – in cui venivano discussi i temi più attuali, come la stretta creditizia, le nuove localizzazioni industriali, l’istituzione dei servizi di medicina dell’ambiente del lavoro e il crescere dell’assenteismo. Nel 1978, a seguito del riassetto delle Zone secondo il decentramento amministrativo o sindacale avvenuto due anni prima, l’Organizzazione zonale – così veniva chiamata all’interno di Assolombarda – andava a comprendere tutte le categorie industriali. Oltre ai problemi sindacali – le riunioni si aprivano con un “giro di tavolo” per verificare la situazione delle vertenze nelle singole imprese – continuavano a essere discussi temi di interesse generale, come per esempio lo smaltimento dei rifiuti o i collegamenti con Milano, e di carattere economico31.
Cfr. A. Calabrò, Le radici forti..., cit., pp. 30-31, e si vedano anche le varie relazioni sull’attività dell’Associazione degli anni Settanta, insieme alle relazioni del Presidente (Archivi Assolombarda).
Una nuova politica per i servizi alle imprese. C’è anche “il dottor Freud in azienda”
Il nuovo corso, voluto dalla riforma confederale, portava a una maggiore diversificazione dell’attività di Assolombarda, verso una più ampia offerta di servizi. I destinatari, perlopiù, erano le piccole e medie aziende che, proprio per le loro dimensioni, non erano in grado di gestire alcune tematiche in autonomia. Insieme alle convenzioni firmate con alcuni gruppi assicurativi per polizze che coprivano la malattia e l’infortunio dell’imprenditore, molto apprezzata era una serie di servizi di consulenza legale di diritto amministrativo, industriale, comunitario e societario e un ciclo ripetuto di corsi sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni. Nel 1975, la gamma dei servizi offerti si ampliò con la creazione del Centro Elaborazione dati, la riorganizzazione del Centro Stampa e l’avvio dell’attività di consulenza, insieme a Unionscambi, nata nel settembre di quell’anno, che si occupava di scambi commerciali con l’estero e comprendeva un’assistenza completa, dal primo contatto, alla presentazione di offerte, fino al trasporto e alla consegna delle merci. Nei primi mesi dell’anno seguente, fu la volta del Servizio Telex, utilizzato da molte imprese minori, e venne aperto un ufficio per le “onorificenze al merito del lavoro” come, per esempio, la Stella al merito del lavoro, conferita ogni anno dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, e il premio “Fedeltà al lavoro”, assegnato, nel giorno dedicato a sant’Ambrogio, dalla Camera di commercio milanese. L’offerta di nuovi servizi avrebbe compreso anche nuovi argomenti, come l’iniziativa, sul modello svedese, “Il dottor Freud entra in azienda”: un progetto durato due anni che portò alla realizzazione di un manuale di autoanalisi per piccoli e medi imprenditori. Ancora nel 1977, Assolombarda distribuiva un prontuario dedicato a un tema cruciale per le piccole e medie imprese, ossia quello dell’accesso al credito, mentre erano oltre 600 le aziende che aderivano a Confidi – Consorzio garanzia collettiva fidi – nato nel 1968, leader in Italia con 25 miliardi di lire di affidamenti.
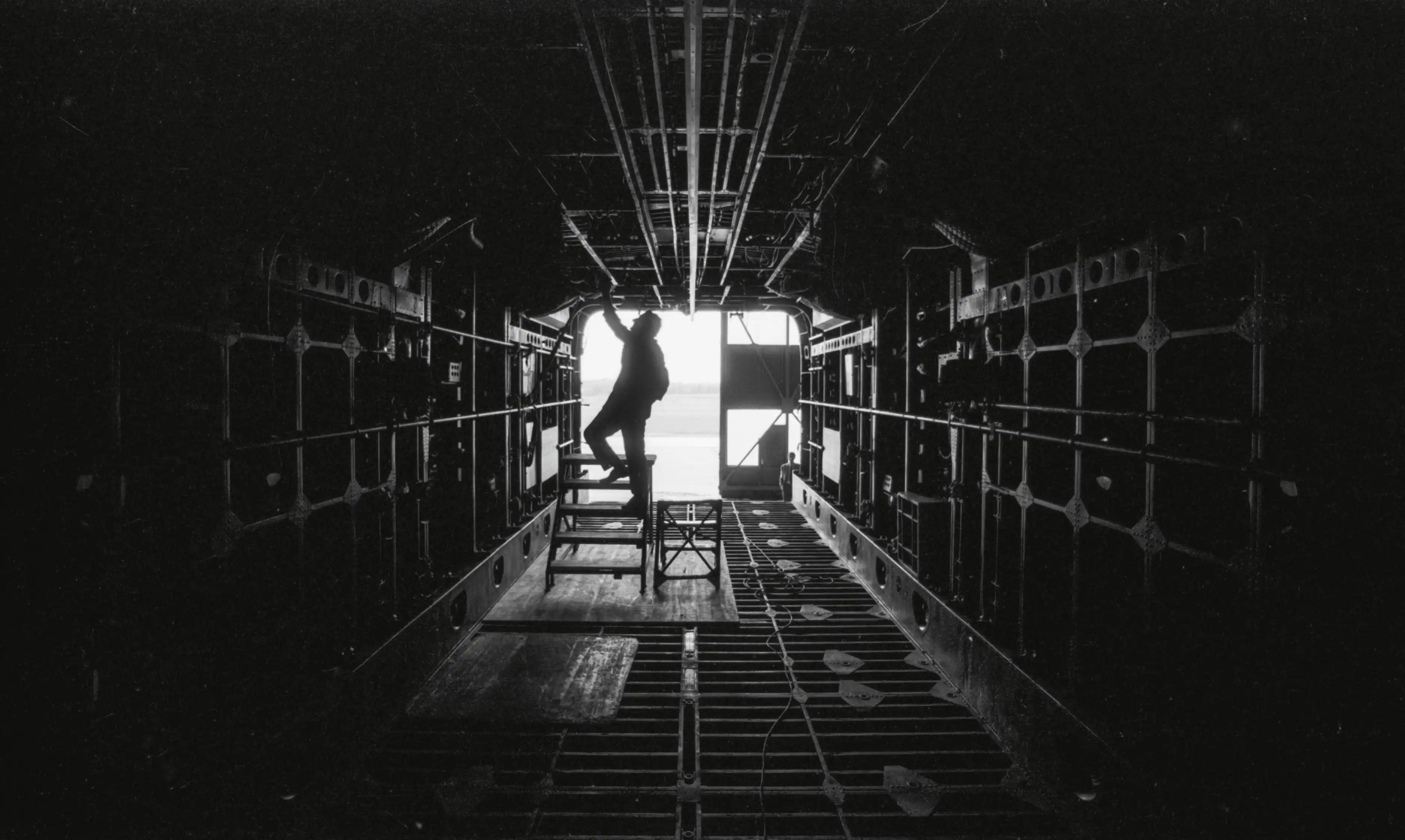
Fusoliera dell’elicottero birotore Chinook in costruzione alla Siai Marchetti, 1972. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Un ulteriore passo in avanti nel settore dei servizi offerti da Assolombarda fu, nell’aprile del 1977, la costituzione di Assoservizi S.p.A. – Società generale di servizi per imprese industriali ed associazioni industriali. Come veniva spiegato nella relazione presentata in occasione dell’Assemblea dell’11 maggio 1978, alla base della decisione di creare la società c’era «la nostra filosofia associativa per la quale è necessario che un’azienda non si senta sola... e per questo i servizi devono essere razionalizzati e migliorati». In questo senso, Assoservizi, operativa dai primi mesi del 1978, era la risposta all’esigenza di sviluppare una visione “organica e unitaria” dei servizi offerti. La gamma si era ulteriormente diversificata finendo per comprendere la consulenza per il rilascio della fideiussione assicurativa al fine di ottenere il rimborso accelerato dell’IVA e anche l’elaborazione meccanografica delle retribuzioni per conto delle associate32.
Si vedano le relazioni sulle attività dell’Associazione per il 1974-1978 (Archivi Assolombarda).
Il malessere delle aziende e la crisi della rappresentanza: il “fantasma dell’Assolombarda”
All’attivismo del periodo, tuttavia, si contrapponeva un certo malessere nel mondo imprenditoriale. I motivi erano diversi. A cominciare dall’assai mutevole situazione internazionale, per la quale, nell’ottobre del 1974, il Presidente francese Giscard d’Estaing aveva coniato una felice espressione: «la gestione dell’imprevedibile». A livello nazionale, come aveva sottolineato il Presidente Pellicanò nel maggio precedente, la perdita d’immagine degli industriali italiani di fronte all’opinione pubblica appariva sempre più grave e occorreva reagire a quel tipo di letteratura che faceva dell’industria «il catalizzatore di ogni male della realtàcontemporanea». Era necessario replicarea questo attacco «affermando senza equivoci il proprio insostituibile ruolo in una dinamica sociale e moderna». Nelle relazioni del periodo, il tema del rilancio dell’impresa, specie quella piccola e media – intesa come «unico strumento vitale e manovrabile in un’atmosfera ancora molto confusa» –, ritornerà spesso, affiancata alle ripetute richieste di una politica di riforme in un quadro di compatibilità. Nel suo discorso di commiato dalla carica di Presidente, nel maggio del 1977, Pellicanò ripercorreva quella che era stata la strategia di Assolombarda negli ultimi sei anni. In primis, l’Associazione era stata attenta «a non cedere alla moda di smantellare certe regole di fondo cui doveva richiamarsi una societàcivile. Mentre alcuni pilastri della società cedevano all’anarchia, spesso presentata come progresso, noi rimanevamo convinti che il solo progresso fosse rappresentato da quello delle riforme e del dialogo tra le forze sociali». Tra i punti chiave vi erano la collocazione dell’Italia e del suo sistema industriale nel contesto internazionale, la Lombardia come ponte tra Europa e Mezzogiorno, la stretta integrazione con il mondo della cultura e, infine, il dialogo costante con tutte le forze sociali.
L’addio alla presidenza di Pellicanò avveniva in un momento particolare nella lunga storia di Assolombarda. Poco più di un anno prima, il 5 febbraio del 1976, il «Corriere della Sera» aveva pubblicato la prima puntata del reportage Inchiesta su chi comanda a Milano, e il titolo dell’articolo dedicato all’Associazione era critico: Il fantasma dell’Assolombarda. Se negli anni Cinquanta «bastava il nome per evocare un’immagine di potenza e di dominio», adesso di tutto questo era rimasto ben poco. Al quotidiano milanese Assolombarda sembrava in costante declino e, ormai, poco influente nella guida della città. La nazionalizzazione dell’industria elettrica, il declino dell’industria privata rispetto al settore pubblico e la perdita del potere industriale erano tra le cause principali della situazione. Il minor peso dell’Associazione era evidente anche a livello confederale. Dopo che negli anni Cinquanta e Sessanta Assolombarda aveva espresso ben due Presidenti, De Micheli e Cicogna, e un Vicepresidente come Dubini, Pellicanò non era andato oltre il Consiglio federale. A questo si aggiungeva il giudizio perentorio di Gianni Agnelli che ai suoi amici ambrosiani aveva detto: «A Milano non c’è più un establishment».
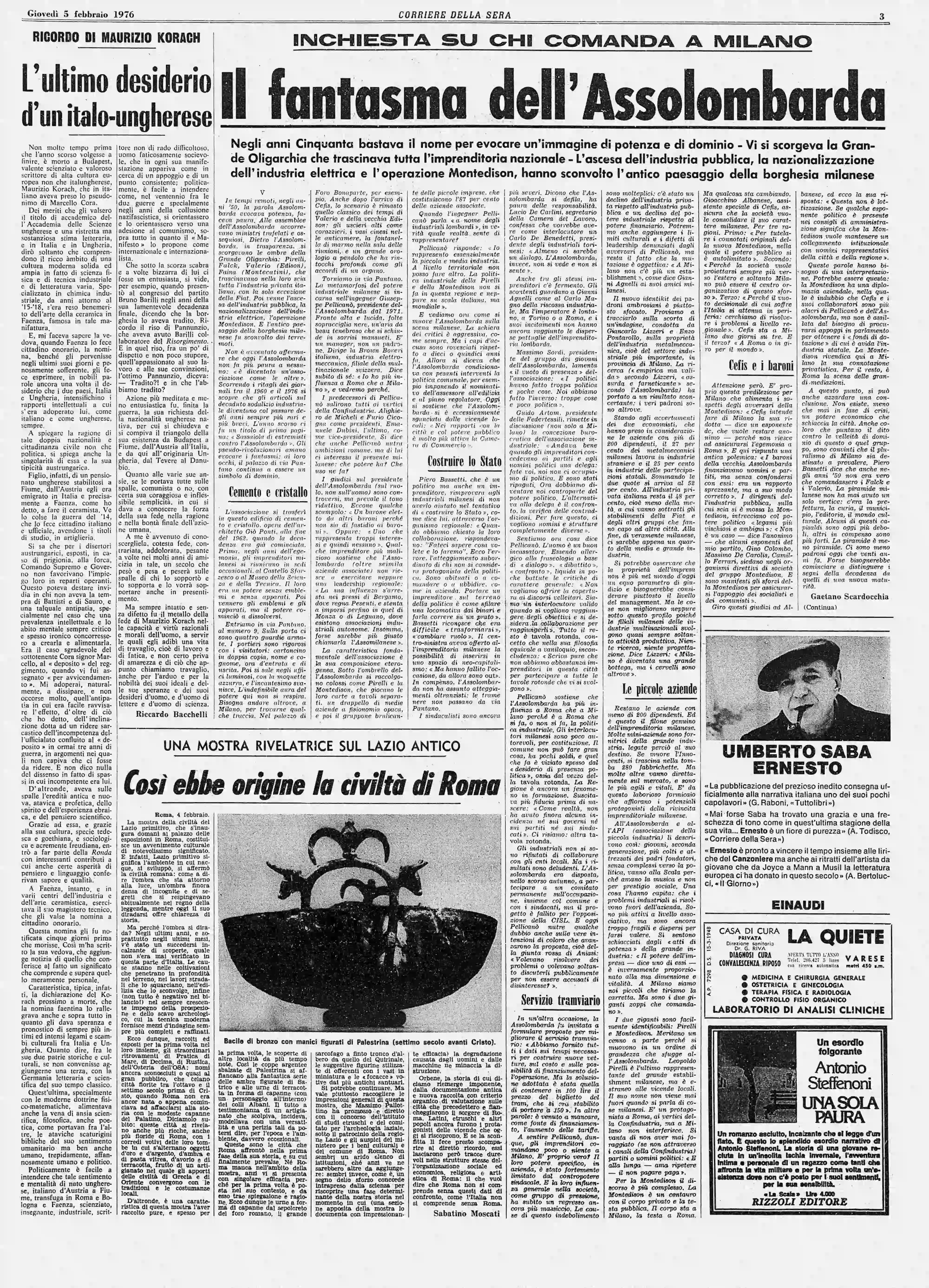
Da via Pantano, il Presidente di Assolombarda replicava colpo su colpo, ma la crisi di prestigio dell’Associazione appariva chiara anche al suo interno. Occorreva dunque avviare un nuovo disegno per il rilancio definitivo. Il nuovo Presidente doveva avere un identikit preciso ovvero essere un «tipico rappresentante dei vecchi imprenditori milanesi», in grado di contrapporsi all’ascesa delle multinazionali – e Pellicanò era un manager di una di queste – e alle tante aziende statali e parastatali operanti nel capoluogo. Il 1° marzo del 1977, la commissione “dei tre saggi” composta da Guido Isolabella, Ludovico Biraghi Lossetti e Paolo Giudici, incaricata di sondare all’interno dell’Associazione e di indicare i possibili canditati alla presidenza, faceva un nome, quello di Alberto Redaelli, Presidente e Direttore Generale dell’azienda di famiglia – la Redaelli Giuseppe & Fratello – che produceva acciai speciali in diversi stabilimenti, con 3.000 dipendenti. La sua elezione aveva anche un altro importante significato: Patto di ferro all’Assolombarda fra 3 gruppi industriali milanesi, intitolava il «Corriere della Sera», il 13 aprile 1977, spiegando che la Montedison, la Pirelli e la Falck si erano accordate per «la diretta partecipazione alla guida dell’associazione dove, negli ultimi sei anni, erano stat[e] latitanti» con il preciso intento di recuperare il prestigio perduto. La “grande coalizione” – che ricordava quella voluta nel 1974 dall’allora Presidente di Confindustria, Gianni Agnelli, con la nomina di un comitato di presidenza formato da alcuni tra i maggiori rappresentanti dell’industria privata italiana quali, per esempio, Eugenio Cefis e Leopoldo Pirelli – avrebbe coadiuvato Redaelli nella presidenza che, a differenza di quella precedente, non voleva e non poteva essere “a tempo pieno” ma doveva operare attraverso deleghe effettive ai suoi Vicepresidenti; in altre parole “una gestione a più voci”. La centralità dell’impresa e il processo alla spesa pubblica saranno due tra i leitmotiv di quegli anni. Nell’aprile del 1980, Redaelli, alle prese con le gravi difficoltà attraversate dal suo gruppo industriale, lasciò con un anno di anticipo33.
Sul periodo, risultano interessanti i diversi articoli apparsi nel «Corriere della Sera», a cominciare da quello intitolato Il fantasma dell’Assolombarda, uscito in terza pagina il 5 febbraio 1976. Si vedano anche: Un nuovo presidente per gli industriali lombardi, 23 marzo 1971, p. 6; Precisazioni Assolombarda sulla presidenza, 15 gennaio 1975, p. 6; Patto di ferro all’Assolombarda fra 3 gruppi industriali milanesi, 13 aprile 1977, p. 21; Redaelli si insedia all’Assolombarda alla guida di uno staff tutto nuovo, 19 maggio 1977, p. 21; Redaelli ha deciso di lasciare la presidenza dell’Assolombarda, 16 aprile 1980, p. 16.
La «traversata nel deserto» tra innovazione tecnologica e strategie di comunicazione
Come si è visto in precedenza, già a partire dagli anni Sessanta, molte aziende avevano iniziato a investire allo scopo, in estrema sintesi, di sostituire con le macchine una parte del lavoro operaio. Questa riorganizzazione produttiva, appunto, passava anche attraverso l’ammodernamento degli impianti, spesso obsoleti. Le difficoltà dei primi anni Settanta, che vedevano i prezzi delle materie prime alle stelle, l’inflazione a doppia cifra e mercati sempre più grandi e complessi, avevano “costretto” le imprese a ripensare profondamente l’intera produzione. Era iniziata, così, la «lunga traversata nel deserto» – come ha scritto Patrizio Bianchi nel suo La rincorsa frenata – che avrebbe portato a un mutamento del mercato, in cui ben presto «tutti saranno contro tutti». Sul finire del decennio, appariva chiaro che non sarebbe stato sufficiente investire soltanto in nuovi macchinari, ma che altri fattori sarebbero stati sempre più decisivi: l’innovazione tecnologica, infatti, diventava sempre più importante, come del resto la comunicazione tra imprese e mercato.

Gianni Agnelli presenta la Fiat Regata al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, 1983. Archivio ANSA.
Il 17 maggio 1980, veniva eletto il nuovo Presidente di Assolombarda. Era il sessantaquattrenne piemontese Antonio Coppi che, entrato nella Falck nel 1944, ne era poi diventato Vicepresidente. Nel suo discorso introduttivo esponeva i punti di forza del suo programma: la riscoperta dei valori del lavoro, il sostegno al disegno europeo e quello alla cultura industriale. Riprendeva anche lo slogan usato dal nuovo Presidente di Confindustria Vittorio Merloni: «Far bene la nostra parte». Nel suo intervento non poteva mancare un accenno alle relazioni industriali. Pochi mesi prima, il suo predecessore aveva condannato la degenerazione del sindacalismo e anche per Coppi occorreva ristabilire un confronto di medio termine e avviare una riflessione comune su temi differenti. Le imprese dovevano essere libere di creare nuova ricchezza, la funzione decisionale dell’imprenditore era indiscutibile e «chiedere di più senza produrre di più significava depauperare il Paese». La celebre “marcia dei quarantamila” quadri Fiat, il 14 ottobre di quello stesso anno, a Torino, con cui i cosiddetti “colletti bianchi” manifestavano a favore dell’azienda e contro il sindacato, rappresentava il punto di svolta nelle relazioni industriali. Da quel momento in avanti, infatti, gli operai avrebbero cominciato progressivamente a perdere il loro peso e il loro ruolo di motore delle trasformazioni sociali.
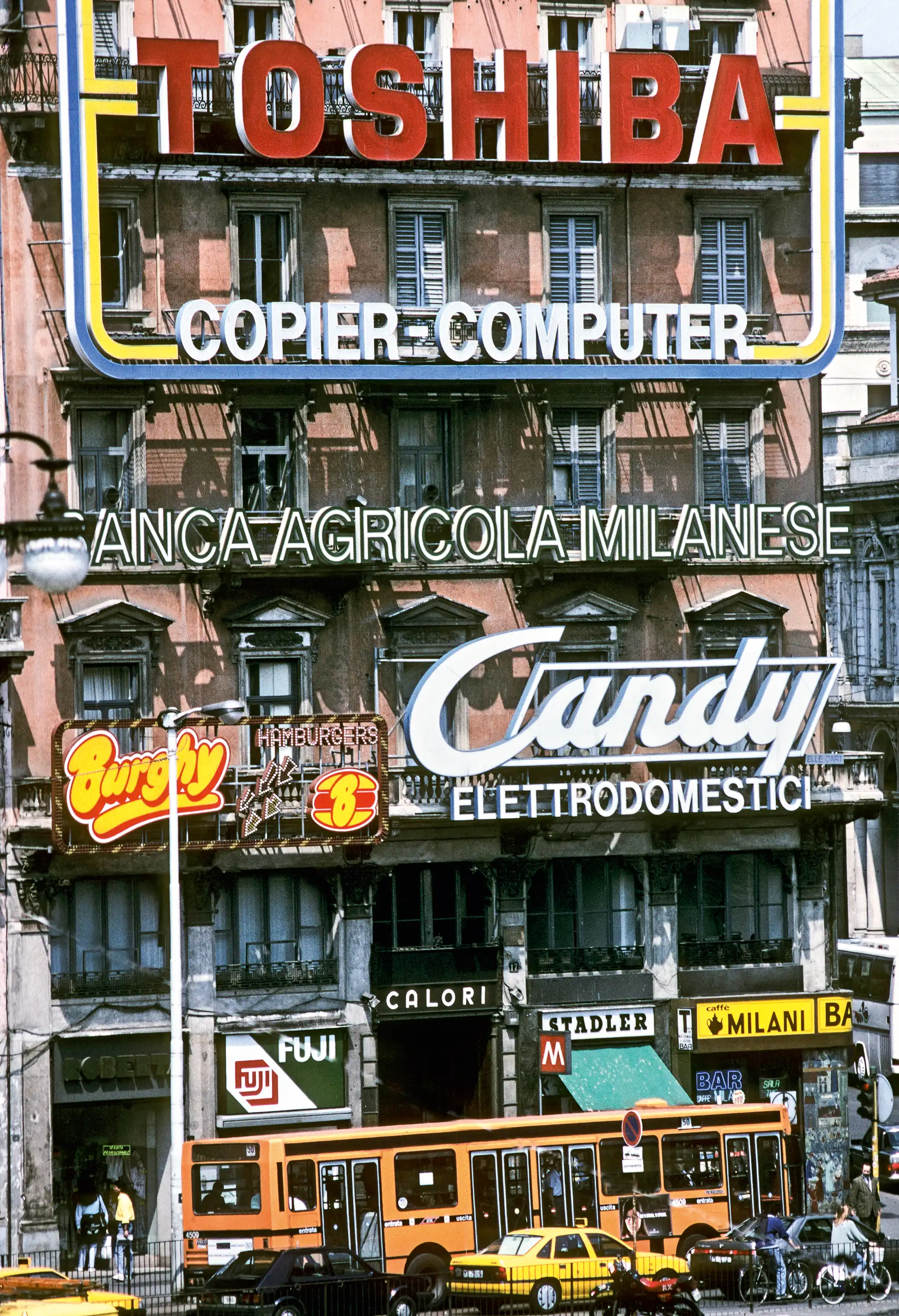
Insegne in piazza del Duomo, Milano, 1985 circa. Fotografia di Uliano Lucas, Archivio Uliano Lucas.
In questi primi anni Ottanta, circolava una nuova parola d’ordine: flessibilità. Se nelle principali nazioni industrializzate si assisteva a una destrutturazione della grande impresa verticalmente integrata, in Italia, dove, tranne le eccezioni del settore auto e della chimica, il modello fordista non aveva trovato grande applicazione, si andrà – come scrive Bianchi – «verso una frammentazione, anzi una deflagrazione delle attività produttive in imprese di piccole dimensioni riunite in gruppi a controllo familiare». Si iniziava a parlare dei successi della “Terza Italia”, quella dei tanti distretti industriali, delle migliaia di piccole e medie imprese, che nascono in diverse parti del Paese34.
Cfr. P. Bianchi, La rincorsa frenata..., cit., pp. 153 ss.

Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi in visita alla SMAU, Milano, 1984. Fondazione Corriere della Sera, Archivio storico.
La nuova cultura industriale ama l’high tech e rilancia il valore dei mercati globali
«Milano del lavoro, tanto, troppo ma prezioso come l’oro» è uno degli slogan contenuti nello spot pubblicitario di un noto amaro milanese che diventerà, in breve tempo, l’emblema di un’epoca, grazie soprattutto al suo celebre claim finale: «questa Milano da bere». Era il 1985 e da un paio d’anni l’economia mondiale si era lasciata alle spalle un periodo di grave recessione e aveva ricominciato a guardare nuovamente con ottimismo al futuro. L’Italia non era da meno e si assisteva – come ha evidenziato Calabrò nel suo saggio Le radici forti di una storia economica nel cuore dell’Europa – «al trionfo dell’impresa privata, con i giornali internazionali che dedicano copertine ai cavalieri del made in Italy come Gianni Agnelli, Carlo De Benedetti, Raul Gardini e Silvio Berlusconi e con l’affermazione di nuovi, eccellenti imprenditori nella dinamica vasta provincia italiana». Si respira un clima diverso e, di questo, aveva parlato anche il Presidente Coppi in una relazione del periodo. Il Paese era politicamente più maturo e stabile dopo anni di “governi balneari” a vita breve, e l’ambiente sociale era finalmente tornato a essere più aperto e favorevole agli stessi imprenditori. Una maggiore stabilità politica, relazioni industriali meno ideologiche e più pragmatiche – ad eccezione di un sindacato in crisi d’identità e meno rappresentativo – e una cultura industriale finalmente a livello dei maggiori Paesi industrializzati facevano da corollario a quella che rimaneva la vera bussola: l’Europa. Stop a ogni provincialismo, sosteneva a più riprese Coppi, perché il vero passaggio obbligato era “di stare al passo” delle altre nazioni del continente pena la perdita di posizioni di mercato e di competitività.

Silvio Berlusconi annuncia la nascita di Canale 5, 1980. Archivio ANSA.
Le parole del Presidente di Assolombarda si sarebbero soffermate, in più occasioni, anche sulla profonda trasformazione che stava vivendo l’industria milanese. Il 2 febbraio del 1984, per fare un esempio, il «Corriere della Sera» pubblicava un’inchiesta dal titolo: Milano, qui si rifà l’industria o si muore. Il ticchettio dei telex e i singulti del calcolatore, scriveva il quotidiano, avevano sostituito il rumore dei magli, Sesto San Giovanni non era più quella di un tempo e il nuovo corso aveva un quasi unico protagonista nel terziario avanzato. Interpellato su quello che, ai più, sembrava l’inizio del declino quantomeno industriale del capoluogo, Coppi rispondeva con numeri e cifre. Milano era una città ancora molto vitale, tanto da produrre il 51% del valore aggiunto dell’intera Lombardia e il 13% di quello nazionale. Quello che stava avvenendo – ribadiva – era una vera e propria “rivoluzione silenziosa”, necessaria per competere nei mercati globali e che aveva nell’innovazione, nella flessibilità e nel decentramento i suoi elementi di propulsione. Era sbagliato indicare nel rapido sviluppo del terziario, “classico” e avanzato, il motivo dell’arretramento dell’industria. I confini tra i due settori erano destinati a diventare sempre più labili fino a scomparire, e questo – sempre a giudizio del Presidente – per due ragioni: in primis perché i due comparti erano sempre più collegati, e poi perchéall’interno delle imprese la quota dei servizi era in rapido aumento. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi di Assolombarda, infatti, già il 55% degli addetti svolgeva compiti non collegati con il processo fisico di produzione. L’avanzata del terziario aveva una ricaduta pratica anche all’interno dell’Associazione con l’istituzione, nel giugno del 1985, del raggruppamento “Terziario avanzato” e, soprattutto, alla fine dell’anno seguente, con l’apertura alle aziende di servizi che potevano entrare a far parte dell’organizzazione di via Pantano. Parallelamente, la revisione di alcune sezioni dello Statuto portava al riconoscimento istituzionale dell’Organizzazione zonale e delle associazioni collegate e al cambio di denominazione dei sindacati di categoria, trasformati in Gruppi merceologici35.
Cfr. A. Calabrò, Le radici forti..., cit., pp. 35 ss. Si vedano anche le relazioni del Presidente all’Assemblea dei primi anni Ottanta (Archivi Assolombarda) e, sul tema della deindustrializzazione milanese, tre contributi apparsi nel «Corriere della Sera»: Coppi: restiamo la capitale dell’impresa italiana. I posti persi? È la prova che ristrutturiamo, 2 febbraio 1984, p. 13; Milano, l’industria non abita più qui, 5 maggio 1985, p. 8; Un “pezzo” di città dove c’era una fabbrica, 12 aprile 1987, p. 32.
La piccola industria costruisce un ruolo di peso e prestigio ai vertici dell’Associazione
In tema di slogan, sempre durante gli anni Ottanta, trovava largo successo e condivisione un vero e proprio mantra: «Piccolo è bello». Si rifaceva al libro Small Is Beautiful, pubblicato nel 1973 dall’economista tedesco Ernst Friedrich Schumacher, in cui, tra le tante cose, veniva messo in discussione il paradigma occidentale imperniato sulla grande impresa. Il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese (PMI), all’interno del sistema economico italiano, trovava conferma anche in un importante passaggio strutturale in Assolombarda, dove costituivano ancora il 90% delle associate con il 45% degli addetti. Nel dicembre del 1986, con una modifica del testo statutario, veniva infatti approvato il cambio di denominazione da Gruppo di lavoro della Piccola Industria, in Gruppo Piccola Industria. Non era soltanto una questione di nome, perché la decisione aveva importanti conseguenze sul peso che le industrie minori avrebbero avuto all’interno dell’Associazione: il consigliere incaricato per i problemi della piccola industria, diventava ora il Presidente del Gruppo Piccola Industria, ma soprattutto veniva approvato l’automatismo della sua nomina a Vicepresidente di diritto di Assolombarda.

Autogru C.F., 1981. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
La rappresentanza della piccola impresa aveva preso forma, qualche anno prima, con la riforma statutaria del marzo 1971, che aveva previsto la creazione del Gruppo di lavoro della Piccola Industria. Il compito specifico era stato più politico che operativo e aveva compreso l’individuazione delle istanze e delle esigenze delle piccole e medie imprese con lo scopo di rappresentarle negli organi direttivi. Sempre in quell’anno, era stato definito in 250 dipendenti (500 per le imprese metalmeccaniche) il criterio per le aziende che volevano far parte del Gruppo di lavoro. Successivamente, assecondando la profonda trasformazione del tessuto industriale milanese, il limite per le imprese metalmeccaniche venne ridotto a 350 addetti e, nel 1995, fu eliminata la distinzione settoriale, portando il limite a 250 per tutte le industrie, fino a giungere agli attuali 100.
Tornando agli anni Settanta, tra le maggiori iniziative del Gruppo di lavoro della Piccola Industria vi fu la formulazione del Piano “gestione consapevole”, che voleva stimolare una crescita qualitativa dell’imprenditore attraverso una gestione “più scientifica” e consapevole della propria azienda, specie in un momento così complesso come quello seguito allo shock petrolifero. L’accesso al credito, come visto, rappresentava uno dei maggiori problemi per la PMI e il Piano intendeva aiutare l’imprenditore nel dialogo con gli istituti di credito, che tendevano a trascurare questo genere di imprese. In pratica, venivano organizzati corsi di formazione non solo per gli stessi imprenditori ma anche per i contabili aziendali e i funzionari di banche. L’attività del Gruppo comprendeva inoltre la pubblicazione di manuali procedurali, l’organizzazione di convegni e la realizzazione di diverse ricerche sul tema energetico, sul capitale a rischio e, nel 1978, sull’impatto della Quarta direttiva CEE. Nei primi anni Ottanta, l’attività del Gruppo continuò ad avere una connotazione politica e non operativa e si concretizzò nell’espressione di pareri su questioni generali negli ambiti istituzionali in cui era presente36.
Sull’attività del gruppo della Piccola Industria, si vedano le relazioni sull’attività dell’Associazione e le relazioni dei Presidenti a partire dai primi anni Settanta (Archivi Assolombarda).
«L’Industria Lombarda» cambia pelle: una comunicazione più attenta ai dati e ai fatti
Tra gli accadimenti del periodo, merita menzione la fine delle pubblicazioni di «L’Industria Lombarda», che per oltre sessant’anni era stato l’organo ufficiale prima della Federazione Industriale Lombarda e poi, dal 1947, della ricostituita Associazione. Tra il 1966 e il 1967, il giornale aveva assunto una veste più moderna. Oltre alla pubblicazione dell’inserto «Informazioni per le aziende», le colonne ospitavano articoli e interviste di importanti esponenti del mondo imprenditoriale, sindacale e politico e alcune fra le più note firme del giornalismo economico italiano, in veste di collaboratori. «L’Industria Lombarda» – con questa nuova impostazione – intendeva essere anche uno strumento di dibattito, di contraddittorio con gli altri giornali, con l’opinione pubblica, con la classe politica locale e, infine, sede per un dialogo costante fra gli stessi imprenditori su questioni di interesse immediato. Per questo venivano realizzate le prime inchieste ad hoc sull’economia lombarda e introdotte rubriche di particolare interesse come Settegiorni e La stampa in Italia e nel mondo, insieme a notizie sull’attività degli enti locali. A metà degli anni Settanta, il periodico diventava prima quindicinale, per poi essere trasformato, all’inizio del 1979, in un mensile. I due passaggi si accompagnavano a una modifica sostanziale dei contenuti, più adatti al nuovo taglio e più orientati verso il giornalismo d’inchiesta, ovvero sulle principali questioni economiche, sulla trasformazione della società e sui problemi dell’impresa e del mondo del lavoro. Periodicamente venivano pubblicati alcuni “numeri speciali” di particolare successo, come quello dedicato al doppio impegno elettorale, politico ed europeo, nel giugno del 1979.
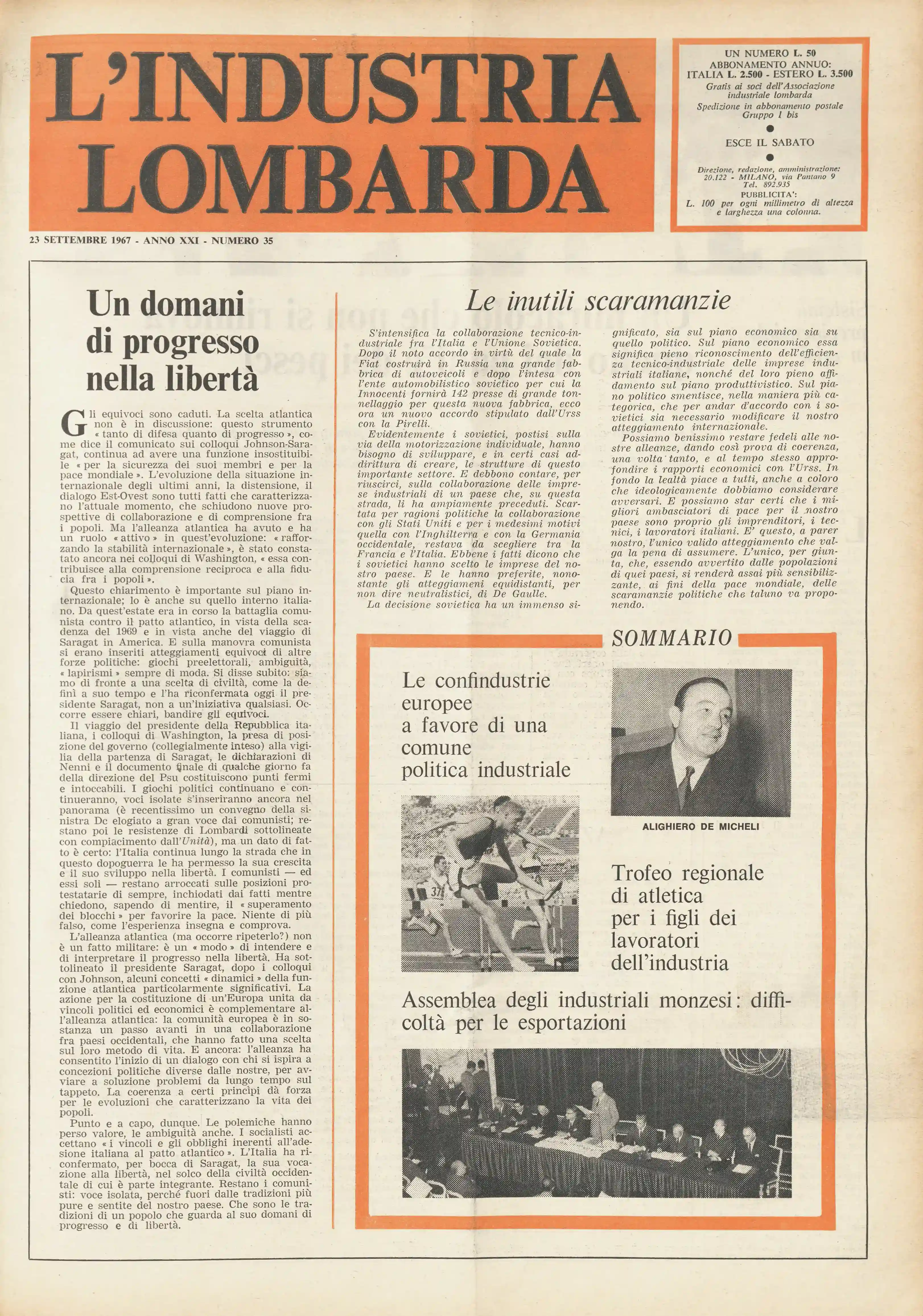
Un nuovo passaggio attendeva «L’Industria Lombarda». Nel 1983, infatti, si passò a una sola uscita annuale, dedicata ad argomenti di particolare interesse e con una tiratura di 18 mila copie distribuite a tutte le aziende associate e agli ambienti politici, economici e sociali milanesi e nazionali. Nel 1985, il numero fu dedicato al tema Milano: ieri, oggi, domani, seguito da un’uscita sulla globalizzazione nel 1986 e, l’anno seguente, da Milano 2000, che raccoglieva i contributi presentati in un recente convegno svoltosi al Castello Sforzesco. A partire dal 1988, veniva siglato un accordo con la società editoriale Mondo Economico, tramite il quale Assolombarda affidava per tre anni alla società la produzione e la distribuzione di «L’Industria Lombarda», che diventava semestrale e in abbonamento.
Il rilancio di Assolombarda con nuove relazioni industriali e un’organizzazione “piatta”
Nel giugno del 1985 si era conclusa la presidenza Coppi. Al suo posto, la commissione dei “tre saggi”, formata da Alighiero De Micheli, Emanuele Dubini e Giuseppe Pellicanò, aveva indicato il nuovo nome: Ottorino Beltrami. Uomo di grande esperienza, Beltrami era stato ufficiale di Marina pluridecorato e comandante di sommergibili, per poi iniziare una lunga carriera tra pubblico e privato che l’aveva portato a essere, tra i tanti incarichi, amministratore delegato di Olivetti e successivamente Presidente della SIP. In campo associativo, era stato a lungo Presidente di ANIE, la federazione che riuniva le aziende dei settori elettrotecnico ed elettronico. In un nuovo clima culturale contraddistinto, come affermava il nuovo Presidente nel luglio del 1986, da «una diffusa voglia di capitalismo e di fare impresa», si doveva puntare a rinnovare sia il modello di relazioni industriali – attraverso l’introduzione di «una vasta pluralità di soluzioni contrattuali» – sia la legislazione del lavoro, pesantemente arretrata rispetto alle esigenze dell’industria. I principali nodi irrisolti rimanevano le riforme della cassa integrazione, delle pensioni e, come detto, del mercato del lavoro.
Sul finire degli anni Ottanta, si arrivò a una nuova riforma confederale che avrebbe proposto – come ha scritto Valerio Castronovo nel suo Cento anni di imprese. Storia di Confindustria (1910-2010) – alcune interessanti novità, tra cui «lo snellimento della struttura centrale, il rafforzamento delle federazioni regionali e l’adozione di un Codice Etico, ossia una serie di principi che dovevano essere rispettati dagli imprenditori che intendevano assumere cariche in Confindustria»37. Nel luglio del 1989, veniva istituita una commissione presieduta da Emilio Mazzoleni, che avrebbe concluso i lavori nel giugno di due anni più tardi.
V. Castronovo, Cento anni di imprese..., cit., pp. 601 ss.

Collaudo fibre ottiche alla Italtel, 1989. Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.
Sulla scorta dei risultati raggiunti in sede confederale, veniva avviato a Milano un nuovo profondo processo di revisione dell’organizzazione operativa. L’obiettivo era quello di superare alcune criticità legate, soprattutto – come riporta la relazione presentata all’Assemblea dell’8 giugno 1992 – «allo schema rigido e ingessante della struttura basata su quattro Linee, la difficoltà al lavoro di équipe e per progetti, le esigenze di favorire la crescita della professionalità e della motivazione delle risorse umane». Struttura “piatta” e progetti rappresentarono i cardini del rinnovamento. Veniva definito un nuovo organigramma che s’ispirava al modello dell’azienda corta e prevedeva due soli livelli manageriali: Direzione generale e responsabili di area. La riorganizzazione, seguita dal Direttore Generale Daniel Kraus, era fortemente necessaria per garantire la competitività dell’Associazione anche dal punto di vista del capitale umano, rispetto al qualela figura del Direttore Generale è sempre stata centrale.
L’altra grande novità era rappresentata dall’introduzione del lavoro a progetti. Questi ultimi avevano, nella maggior parte dei casi, una natura interdisciplinare e avrebbero coinvolto persone appartenenti ad aree diverse. Altra caratteristica era che ogni progetto aveva un termine e che, in ogni caso, l’attività progettuale si doveva integrare con quella corrente, svolta nell’ambito delle nuove aree tematiche. La diffusione di una cultura di project management era il preludio alla creazione di una lunga serie di progetti che coinvolgevano l’intera attività di Assolombarda. Come sottolineava la relazione del 1991, si voleva fare di Assolombarda «un crogiolo di idee non soltanto per Milano ma per l’intero Paese». I numerosi progetti approvati dalla giunta tra il 1991 e il 1992 riguardarono, come detto, ambiti assai diversi tra loro. Ci si muoveva, per fare solo qualche esempio, dalle «nuove relazioni industriali», alla «cultura industriale e valori d’impresa», passando anche per il progetto interno “Qualità totale in Assolombarda”, che aveva lo scopo di introdurre un processo di analisi e monitoraggio della qualità del lavoro e dei servizi, e che si sarebbe concluso, nel maggio del 1997, con la certificazione di qualità Cisq Cert38.
Si vedano le relazioni sull’attività dell’Associazione e quelle dei Presidenti (Archivi Assolombarda). Si vedano anche gli articoli pubblicati nel «Corriere della Sera», in particolare: Sarà Beltrami il presidente degli industriali milanesi, 29 giugno 1985, p. 11; Assolombarda, Beltrami verso la riconferma, 13 aprile 1989, p. 13; La bella addormentata, 7 marzo 1990, p. 1 («Corriere Economia»).
Milano ritrova slancio come capitale economica e finanziaria al di là dell’euroscetticismo
Molte cose erano accadute. Tra queste, nel febbraio del 1992, la firma del Trattato di Maastricht, che rappresentava una nuova e importante tappa di quel processo di integrazione europeo che aveva preso il via nei lontani anni Cinquanta. In quasi quarant’anni, la posizione di Assolombarda non era mai cambiata: l’Europa unita era il traguardo. Tanto più che Milano, e questo veniva ricordato spesso nelle relazioni dei vari Presidenti, aveva «le proprie radici in Europa». Certo, in alcune fasi, la costruzione del mercato europeo era stata vista «con freddezza se non con ostilità», nel timore che l’economia milanese non fosse competitiva rispetto a quella di altre aree del continente. Il periodo compreso tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, caratterizzato da diverse crisi strutturali e da una certa sfiducia nel destino dell’economia internazionale, aveva visto prevalere una quota di “euroscetticismo” o, addirittura, una “eurosclerosi”, ma, sul finire del decennio Ottanta, tutto sembrava passato. La Comunità europea era arrivata a sorprendere con un progetto di integrazione economica che avrebbe fatto dell’Europa il primo mercato del mondo occidentale in grado di affrontare la pressione americana e giapponese. A tenere banco non era soltanto la questione europea, ma quanto stava accadendo in quello che per tutti era stato il blocco comunista. La caduta del Muro di Berlino nel novembre del 1989 e l’implosione del gigante sovietico chiudevano di fatto l’epoca dell’equilibrio bipolare e favorivano l’intensificarsi del processo di globalizzazione. Questo termine era stato coniato nel 1962 dal settimanale inglese «The Economist» ma, ancora all’inizio degli anni Novanta, non erano molti a utilizzarlo; eppure, di lì a poco, quella parola fu sulla bocca di tutti.

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, 2005.
In un mondo che stava cambiando tanto e velocemente, rimanevano poche certezze e tra queste c’era il ruolo storico di Milano. Capitale morale ed economica, unica città italiana davvero internazionale, il capoluogo era ancora pronto a guidare questa nuova stagione. Un primato che, peraltro, veniva confermato da alcuni indicatori economici. Su base nazionale, infatti, a Milano si concentrava l’8% dell’occupazione, il 10% del valore della produzione di servizi e il 12% dell’intera produzione industriale. La città continuava a essere un grande polo industriale ed era stata proprio questa sua forza ad avere permesso lo sviluppo di un tessuto più diversificato, nel quale la dimensione e la qualità dei servizi avevano raggiunto livelli europei. Non era stato facile ma, come ricordava il Presidente Beltrami, gli industriali stavano affrontando una contesa che andava a toccare il vero spirito imprenditoriale: «La sfida della modernizzazione, in fondo, è tutta qui» – aveva sottolineato durante l’Assemblea del 1988 – «nella capacità di riaffermare la nostra fiducia nel sistema capitalistico accettandone il carattere più fastidioso e irritante, cioè l’esigenza di non appagarci mai delle nostre radicate convinzioni, di ripensare continuamente a nuove relazioni sociali, a nuovi rapporti internazionali, a nuove sfide internazionali. È il fascino e la fatica della società aperta».
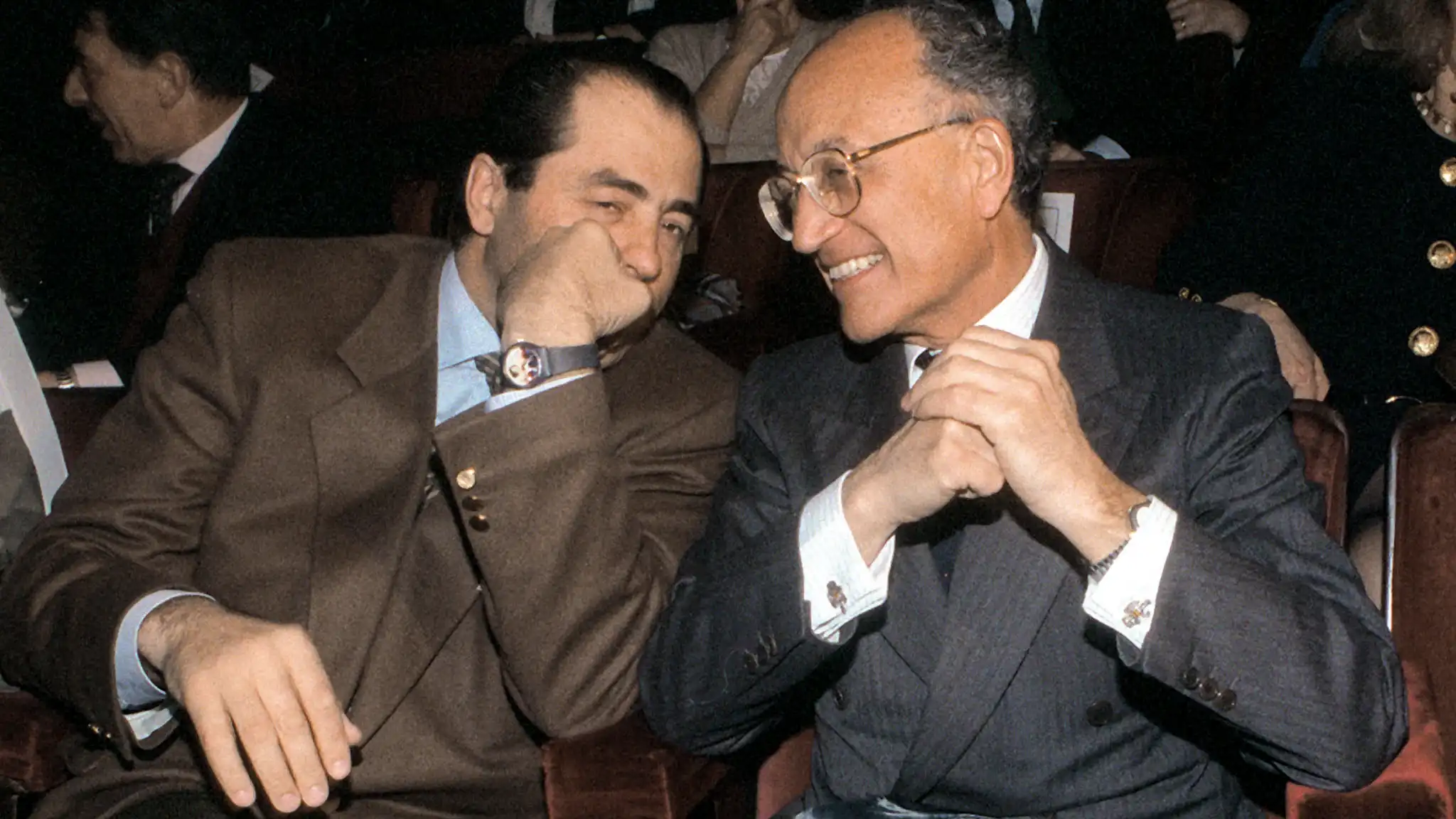
Francesco Saverio Borrelli e Antonio Di Pietro, magistrati del pool Mani pulite, Milano, 1992. Archivio ANSA.
Non era stato facile ma, come ricordava il Presidente Beltrami, gli industriali stavano affrontando una contesa che andava a toccare il vero spirito imprenditoriale: «La sfida della modernizzazione, in fondo, è tutta qui» – aveva sottolineato durante l’Assemblea del 1988 – «nella capacità di riaffermare la nostra fiducia nel sistema capitalistico accettandone il carattere più fastidioso e irritante, cioè l’esigenza di non appagarci mai delle nostre radicate convinzioni, di ripensare continuamente a nuove relazioni sociali, a nuovi rapporti internazionali, a nuove sfide internazionali. È il fascino e la fatica della società aperta».

Manifestazione a favore dell’inchiesta “Tangentopoli” Mani pulite, Milano, 30 novembre 1994. Fondazione Corriere della Sera, Archivio storico.
Nel cuore delle tempeste: le tensioni valutarie e gli scandali di Mani pulite
Il Trattato di Maastricht entrava in vigore nel novembre del 1993. Non solo creava le premesse per la moneta unica europea, ma istituiva anche la Banca Centrale Europea (BCE) e il Sistema europeo di banche centrali, fissando tutta una serie di parametri comuni da rispettare in tema di deficit, debito pubblico, inflazione e tassi d’interesse a lungo termine. L’introduzione delle nuove norme europee sull’apertura dei mercati e sulla libera concorrenza ebbero importanti conseguenze anche sull’assetto dell’economia italiana. Si apriva, infatti, la stagione delle privatizzazioni – prima le banche, le assicurazioni e poi l’industria e il terziario – che modificarono radicalmente l’economia italiana, i suoi assetti di potere, le sue capacità di crescita e di espansione.
Dal maggio del 1991, Assolombarda aveva un nuovo Presidente: Ennio Presutti, allora a capo della IBM-Semea. Se il suo predecessore Beltrami aveva ridato smalto e peso politico all’Associazione, forte di 4.700 imprese associate, con circa 270 mila dipendenti, il compito del nuovo Presidente sarebbe stato quello di svilupparne le varie attività. Sull’Europa, la posizione di Presutti non si discostava dalla tradizione. Maastricht «ci ha imposto nuovi vincoli, ma ci ha messo di fronte alla gravità dei nostri problemi», ricordava nel corso dell’Assemblea. Il riferimento andava all’enorme deficit, al debito pubblico e all’apparato statale poco dinamico rispetto alle esigenze di sviluppo: tutte questioni che frenavano la performance del Paese. Non a caso, dagli anni Ottanta in avanti, la crescita italiana era stata costantemente più lenta della media mondiale e sotto la media dei Paesi avanzati. Il risanamento del deficit diventava allora un punto obbligato, quella «medicina amara» – come la definiva Presutti – che l’Europa ci chiedeva di prendere.
La grave situazione della finanza pubblica non era di certo l’unico problema dell’Italia dei primi anni Novanta. Nel settembre del 1992, infatti, una tempesta valutaria si abbatteva sul nostro Paese. Lira e sterlina, le monete deboli che aderivano allo SME – il Sistema monetario europeo, creato nel 1979 dalla Comunità Economica Europea con l’obiettivo di stabilizzare i rapporti di cambio fra le rispettive monete –, erano costrette ad uscirne. Per correre ai ripari, prendeva corpo una maxi manovra finanziaria da 90 mila miliardi di lire fra tasse e tagli alla spesa pubblica, primo passo di un percorso di risanamento dei conti pubblici durato diverso tempo. Alla battaglia per ridurre il dissesto finanziario, si accompagnava l’avvio di un secondo processo che – come ha scritto Antonio Calabrò – «modificava radicalmente l’economia italiana, i suoi assetti di potere, le sue capacità di crescita e di espansione: le privatizzazioni». Necessarie per rispettare le regole delle norme europee sull’apertura dei mercati e sulla concorrenza, contribuivano a liberare risorse, al riequilibrio dei conti pubblici e si traducevano in una straordinaria crescita dei mercati finanziari. Il processo di privatizzazione iniziava nel 1990 con le banche, per poi coinvolgere il settore assicurativo e quello industriale.
In questo periodo già denso di avvenimenti, il 17 febbraio 1992 con l’arresto di Mario Chiesa scoppiava lo scandalo di “Tangentopoli”, il nome giornalistico attribuito al sistema di corruzione fondato sugli intrecci illeciti tra affari e politici e sul crescente peso delle tangenti in appalti e forniture pubbliche. Un groviglio che avrebbe finito per travolgere un’intera classe politica e posto fine alla cosiddetta “Prima Repubblica”. Nel maggio seguente, commentando la situazione, il Presidente Presutti affermava, riferendosi agli effetti deleteri dell’abbraccio affaripolitica: «adesso il sistema è giunto al capolinea e da questo treno bisogna scendere».
Sul finire dell’anno, l’inchiesta di “Mani pulite” – altro nome utilizzato dai media, preso in prestito dal film Le mani sulla città del 1963 – toccava da vicino l’Associazione di via Pantano e alcuni dei suoi vertici. La risposta dell’Associazione era netta – «all’Assolombarda non si fanno illeciti» – e, in breve, la questione dei presunti fondi neri trovava la spiegazione. In sostanza, come affermato da alcuni esponenti politici, si era trattato di contributi volontari utilizzati per finanziare le ultime campagne elettorali, ma che non erano riconducibili a una violazione della legge sul finanziamento dei partiti39.
Sul periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e sulla vicenda di “mani pulite”, si vedano i diversi articoli apparsi nel «Corriere della Sera»: La bella addormentata, 7 marzo 1990, p. 1 («Corriere Economia»); Assolombarda, vince Presutti, 5 maggio 1991, p. 16; Capolinea, ora si cambia treno, 6 maggio 1992, p. 4; Imprenditori nei guai, 7 novembre 1992, p. 21; Assolombarda, il giallo dei fondi neri, 14 gennaio 1993, p. 8; La difesa di Presutti: all’Assolombarda non si fanno illeciti, 15 gennaio 1993, p. 7; Assolombarda, Pri e Pli nei guai, 23 marzo 1993, p. 1; Si muove il vertice Assolombarda, Kraus ha già pronte le dimissioni, 2 aprile 1993, p. 44; Lo giuro: gli industriali non daranno mai più una lira ai politici, 16 giugno 1993, p. 1 («Corriere Economia»); Fondi neri Assolombarda, il Pm “In 32 a giudizio”, 20 luglio 1995, p. 11; Claudio Schirinzi, Due pesi e due misure, 28 aprile 1999. Si vedano anche le relazioni sulle attività dell’Associazione per il periodo 1987-1992.
L’impresa attenta al sociale: nasce Sodalitas per sostenere il terzo settore
A metà degli anni Novanta, grazie comunque alla ripresa sostenuta dell’economia, si era tornati a respirare un certo ottimismo nel futuro. Per Assolombarda, Milano doveva diventare il “laboratorio del nuovo”, rimettendo l’etica al primo posto e puntando, al pari degli altri attori del sistema economico, sul concetto di responsabilità dell’impresa. Il tema era assai attuale anche in sede europea, dove il Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, aveva sottolineato in più occasioni che l’impresa avrebbe dovuto osservare alcune regole nelle relazioni con i suoi partner e con la comunità in cui operava.

Sala controllo della Borsa di Milano, 2000. Fotografia di Giampietro Agostini. Archivio storico fotografico AEM, Fondazione AEM.
Alla fine di settembre del 1995, Assolombarda annunciò alla stampa la creazione di Sodalitas. L’associazione, nata grazie all’impegno di imprese e manager volontari, intendeva supportare la crescita del “non-profit”, il cosiddetto “terzo settore”, che, a metà degli anni Novanta, iniziava ad avere dimensioni notevoli, con oltre 400 mila addetti e un fatturato nell’ordine dei 29 miliardi di lire. Tramite Assolombarda, gli imprenditori milanesi intendevano contribuire – così come veniva riportato dai principali media – «a trovare soluzioni adeguate ai bisogni e alle emergenze sociali di oggi». Il valore sociale creato da Sodalitas consisteva innanzitutto nel mettere a disposizione della comunità un patrimonio di competenze espresse dal mondo imprenditoriale, contribuendo alla crescita professionale e gestionale delle organizzazioni senza fini di lucro. In dettaglio, prendendo a titolo di esempio l’anno 2000, le giornate di volontariato manageriale – ex manager e dirigenti d’azienda che rappresentano i soci individuali – sfioravano le 3.000, permettendo di avviare 91 nuovi progetti di consulenza con 50 organizzazioni non-profit ambrosiane, portando così il totale degli interventi a 477 dalla data di costituzione. Dopo soli cinque anni di attività, le imprese associate a Sodalitas erano passate da 14 a 25 per poi superare la trentina nel 2003. Intanto, nel 1998, l’associazione, insieme ad altri soggetti del terzo settore, pubblicava i 27 articoli che componevano la Carta della donazione, il primo codice etico italiano per l’autoregolamentazione della raccolta fondi non-profit. Nel 2001, nasceva il premio Sodalitas Social Award, destinato a quelle imprese che si erano distinte per l’impegno nel sociale. Nello stesso periodo, Sodalitas concentrava parte del suo impegno nel sostegno allo sviluppo di una cultura d’impresa più consapevole del proprio ruolo di attore sociale, oltre che economico, nonché a favorire partnership tra settore privato, non-profit e pubblico. Creare nuovo capitale sociale, basato sulla fiducia, rappresentava la chiave per dare concreta realizzazione al concetto di “cittadinanza d’impresa”. Nei fatti, occorreva fornire assistenza progettuale alle imprese che intendevano realizzare interventi a favore della coesione sociale, come per esempio donazioni, affidamento di commesse di lavoro o anche contributi di beni e servizi. Del resto, un’indagine evidenziava che l’82% degli italiani chiedeva alle aziende di partecipare alla soluzione dei problemi della società anche attraverso le prime operazioni di marketing sociale. L’anno precedente, nel 2000, Assolombarda aveva presentato – prima associazione a livello europeo – il suo Bilancio sociale: esempio concreto di “cittadinanza sociale” e strumento per interagire in maniera chiara e aperta con i diversi interlocutori40.
Nel frattempo, nel giugno del 1997, era scaduto il mandato di Presutti ed era stato eletto il milanese Benito Benedini, Presidente della Federchimica e della Total Inchiostri. Nel suo primo discorso, presentando il programma, si diceva sostenitore di un associazionismo «dal basso» e del «gioco di squadra», fatto di concretezza per rispondere alle esigenze delle imprese. Queste ultime, alle soglie del Duemila, dovevano confrontarsi con una realtà mondiale assai competitiva, basata su tre fattori chiave – flessibilità, formazione e innovazione, e strutture – per fare di Milano un’area-sistema capace di connettere i tanti elementi di eccellenza che la caratterizzavano.
Si vedano gli articoli apparsi nel «Corriere della Sera»: Come salvare le vecchie cattedrali dell’industria, 22 marzo 1984, p. 27; Manager impegnati nelle emergenze sociali, 21 settembre 1995, p. 48; Fare utili e aiutare una causa sociale, 18 novembre 1998, p. 26. Cfr. anche Assolombarda, Bilancio sociale 2000 (Archivi Assolombarda) oltre alle relazioni dei Presidenti per il periodo tra la metà degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo (Archivi Assolombarda).
Museimpresa e la cultura: i valori e le scelte per l’identità e la competitività
Cresceva anche l’impegno nel settore della cultura d’impresa. Nell’estate del 1999, giungeva a conclusione il processo di trasformazione del Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” da ente di diritto pubblico a fondazione di partecipazione. Veniva anche dato l’avvio al processo di capitalizzazione, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, della comunità imprenditoriale e del mondo accademico. Per Assolombarda rappresentava un passaggio determinante dell’operazione di rilancio di quella che, giustamente, veniva considerata una delle maggiori “fabbriche di cultura scientifica” a livello nazionale. Per l’organizzazione di via Pantano si trattava di un progetto molto sentito, a cui si era dato avvio nel 1996 con il “Manifesto dell’imprenditoria milanese”. Di fondo, c’era nei vertici associativi la convinzione che, sostenendo una istituzione per la diffusione della cultura tecnologica e scientifica del Paese, potesse svilupparsi un sistema proficuo, sia per il contesto produttivo, sia per il museo stesso41.
Cfr. Milano rilancia come fondazione il Museo nazionale della scienza, in «Corriere della Sera», 25 gennaio 1998, p. 22.

Fondazione Pirelli, sala dedicata alla comunicazione visiva di Pirelli, 2025. Fondazione Pirelli.
Nella lunga storia dell’associazione industriale milanese, non erano certo mancati il sostegno a numerose iniziative culturali e più strettamente legate al mondo industriale e dell’impresa. Con gli anni Ottanta, a fronte di una deindustrializzazione sempre più evidente, si era iniziato a dibattere di riconversione e di storia d’impresa. Nel marzo del 1984, l’allora Presidente Antonio Coppi era intervenuto sulla necessità di recuperare i vecchi opifici e di trasformarli in «musei viventi del processo di industrializzazione», e non aveva mancato di sottolineare il grande valore storico degli archivi industriali. Qualche anno più tardi, come riportava la relazione per il 1991, il «crollo delle ideologie» obbligava a una riflessione sul portato della civiltà industriale e sul ruolo del capitalismo, con particolare riferimento alla realtà italiana. Assolombarda avviava allora il “Progetto cultura industriale”, che si sarebbe articolato su quattro linee direttrici principali: lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifico-tecnologica, la promozione della cultura d’impresa, la promozione dell’imprenditorialità culturale attraverso l’innovazione normativa e l’incentivazione fiscale e, infine, l’evoluzione del rapporto tra pubblico e privato in ambito culturale.

Museo Kartell, Noviglio (MI), 2015.
Tra le diverse iniziative promosse negli anni successivi, sicuramente di spessore rilevante, spicca il grande impegno speso, insieme a Confindustria, a favore della nascita, nel 2001, di Museimpresa – l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa –, una rete unica a livello europeo, che attualmente riunisce più di 150 musei e archivi aziendali di grandi, medie e piccole imprese italiane. L’attività primaria di Museimpresa è quella di valorizzare e promuovere i musei e gli archivi d’impresa quali espressione esemplare della cultura progettuale e produttiva del sistema imprenditoriale italiano, ma l’associazione ha anche il compito di veicolare la maggior parte degli interventi di Assolombarda nel settore della cultura d’impresa. Nel 2002, sempre insieme a Confindustria, veniva promossa la prima edizione della “Settimana della Cultura d’Impresa”, la rassegna di eventi culturali (spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, dibattiti, workshop, visite guidate a musei aziendali ecc.) voluta per approfondire i temi relativi alla cultura d’impresa e destinata a un durevole successo. Nello stesso anno, Piccola Industria di Assolombarda organizzava, all’interno del Museo della Scienza e della Tecnica, la mostra L’ingegno del fare, visitata da oltre 10 mila persone e che sarà portata anche a Tokio. Nel 2004, era la volta dell’esposizione intitolata Il legame virtuoso. Gio Ponti, i committenti, i fornitori, che nell’estate dello stesso anno veniva riproposta a Chicago.
È tempo di globalizzazione grazie al boom dei commerci, ma con l’ombra dell’11 settembre
L’inizio del nuovo millennio restituiva un’Assolombarda in salute. Era lo stesso Presidente Benedini a sottolinearlo nel giugno 2001: «Il mondo esterno ci ha riconosciuto, in questi anni, un credito e un’autorevolezza crescenti». Il numero delle imprese associate era tornato a crescere e l’Associazione era pronta alle nuove sfide che la globalizzazione proponeva. L’Europa vedeva la nascita dell’euro, che rappresentava un ulteriore balzo in avanti nel processo di integrazione. Sempre nel 2001, con gli accordi di Doha – sottoscritti anche dalla Cina – si entrava a pieno titolo nell’era segnata dall’autorevole influenza della World Trade Organization (WTO), e venivano stabilite le nuove regole negli scambi mondiali. Il mondo aveva intanto assistito all’attacco alle Torri Gemelle di New York, l’11 settembre dello stesso anno, che segnava la nuova frontiera del conflitto internazionale.Quanto all’economia italiana, le principali novità erano rappresentate dall’esplosione dell’IRI in una varietà di gruppi industriali e bancari, da un andamento lento delle privatizzazioni, dall’affermazione di nuovi imprenditori attivi soprattutto nei distretti industriali e dalla riorganizzazione dei vecchi gruppi familiari.

Macerie del World Trade Center a New York dopo l’attentato alle Torri Gemelle, 11 settembre 2001. Archivio ANSA.
Il ruolo della piccola e media impresa rimaneva centrale all’interno del sistema economico. Nelle relazioni del periodo, iniziavano a farsi più frequenti gli accenni a Internet e alla Net Economy che era ormai sulla rampa di lancio. Non a caso, l’Assemblea del 2000 iniziava con immagini e con voci fuori campo, mentre gli associati potevano seguire i lavori dal loro ufficio, in diretta sulla rete. Presentando la prima edizione del Bilancio sociale nel 2000, la nota introduttiva faceva riferimento all’associazionismo di ultima generazione, chiamato a rispondere ai nuovi bisogni delle imprese in un contesto caratterizzato dalla società della conoscenza, da orizzonti «che dal territorio si proiettano nella globalizzazione» e, infine, dalle profonde trasformazioni del ruolo dello Stato e delle istituzioni. Lobby, servizi e tutela negoziale restavano al centro dell’azione associativa, ma dovevano essere sviluppati attraverso nuovi modelli.
Nel giugno del 2001, il milanese Michele Perini subentrava a Benedini alla guida di Assolombarda. Presidente della Sagsa, azienda attiva nel settore arredamento, Perini aveva una lunga esperienza in campo associativo, risalente ai primi anni Settanta, quando era entrato a far parte del Gruppo della Piccola Industria. Nei suoi interventi pubblici, il nuovo Presidente avrebbe fatto spesso ricorso al dialetto meneghino come, per esempio, nel giugno 2002, quando annunciava il “Modello Milano” con «se ghé de fa, fem». Si riferiva alla firma del Piano d’azione locale per l’occupazione, il quale era stato preceduto da un Patto del lavoro che coinvolgeva Comune di Milano, imprenditori e tutte le sigle sindacali, con l’obiettivo di aumentare il numero degli occupati, sfruttando la flessibilità e facendo emergere il lavoro sommerso.

L’Albero della Vita, simbolo del Padiglione Italia, Expo 2015, Milano. Archivio Storico Bracco.
Altro tema molto discusso nel periodo era quello dell’evoluzione dell’Unione Europea. A dieci anni dalla firma del Trattato di Maastricht, come sottolineava Perini, «L’Europa non è ancora l’Europa dei cittadini. Ricorda più l’Europa di Metternich che quella sognata. È vecchia, malata di troppi protagonismi e di troppa burocrazia». Se l’ideale europeo sembrava aver perso lo slancio dei fondatori, c’era da affrontare un nuovo e importante passaggio che avrebbe portato, nel 2004, alla più grande fase di allargamento nella storia dell’UE con l’adesione di Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Estonia e Lituania. L’ingresso delle nazioni dell’Est-Europa aveva un potenziale di enorme portata, che rischiava però – come riferiva ancora il Presidente durante l’Assemblea del 2004 – di essere vanificato dalla “palude” burocratica, dai veti dei governi nazionali e da una certa incapacità politica. Per affrontare la sfida con gli altri competitor mondiali, occorreva più coraggio di rischiare, una maggiore flessibilità e la ferrea volontà di fare impresa. Erano andati in questa direzione, nel marzo dello stesso anno, i lavori del convegno L’impegno delle industrie italiane contro la cultura della crisi, organizzato da Confindustria – il primo dopo vent’anni a Milano – che aveva insistito proprio sul ruolo propositivo degli industriali in questa nuova fase di transizione42.
Cfr. Assolombarda, Bilancio sociale 2001 e Bilancio sociale 2002 (Archivi Assolombarda). Cfr. anche E Milano diventa il modello del “dialogo pragmatico”, in «Corriere della Sera», 4 giugno 2002, p. 11.
Assolombarda si riorganizza per portare le imprese sui nuovi mercati del mondo
«È senz’altro più importante sforzarsi di capire cosa succede in Paesi come Cina e India piuttosto che concedersi il lusso di barche e vacanze». Nel suo saluto all’Assemblea, il Presidente uscente Perini tornava ancora una volta sul tema dell’internazionalizzazione. Un argomento di grande attualità, ancor più alla luce della crescita delle economie americana e asiatica, cui faceva da contraltare un’Europa che sembrava «essersi addormentata su un benessere che non può più permettersi». Anche in Italia le cose non sembravano andare per il meglio, con un sistema industriale che «viveva di dimensioni e iniziative ancora troppo modeste». A partire dal 2005, Assolombarda si sarebbe impegnata costantemente per favorire una maggiore internazionalizzazione delle imprese; si trattava di uno sforzo importante, paragonabile a quello che, tra la fine degli anni Cinquanta e il decennio seguente, aveva impegnato a fondo l’Associazione sul tema della nascita e dello sviluppo del Mercato europeo comune. La strategia decisa seguiva alcune direttrici che passavano attraverso lo sviluppo del business, interventi di formazione, consulenza e divulgazione, missioni all’estero e la creazione di Country Desk.
Insieme a questo, il lavoro di Assolombarda si concentrava anche sulla valorizzazione della proprietà intellettuale e del made in Italy, sul supporto alla competitività e, infine, sulla ricerca dell’eccellenza in materia di qualità. Nel 2007, per fare un esempio, venivano organizzati 796 incontri business to business con operatori di diversi Paesi europei e asiatici, insieme a iniziative specifiche per il mercato cinese. Dal 2004, infatti, era stato aperto a Shanghai il primo Country Desk, che supportava le richieste delle imprese associate e pubblicava indagini settoriali. In breve tempo, Assolombarda dava il via ad altri sportelli in Australia, Canada, Giappone, Russia e Kazakistan, organizzando presso la sede milanese incontri con potenziali partner e visite di delegazioni commerciali. Offrivano inoltre alle imprese il supporto necessario per operare sui rispettivi mercati, fornendo tutta una serie di informazioni sulle manifestazioni fieristiche, sulla legislazione, su marchi e brevetti e su fisco e dogane.

Banco di guida del treno ad idrogeno Coradia Stream HTM assemblato presso lo stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni (MI), 2024.
Nel corso del 2007, Assolombarda ufficializzava il suo supporto alla candidatura di Milano a ospitare l’Expo 2015 e si intensificavano le relazioni con le rappresentanze consolari, con la Camera di commercio di Milano, con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione (ICE), con la Regione Lombardia e con l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Dopo il 2010, sarebbero cresciute anche le iniziative di respiro internazionale concentrate sulla “green economy”, in collaborazione con il Green Economy Network che, dalla metà del 2011, avrebbe riunito all’interno dell’Associazione le aziende delle principali filiere verdi.
Tornando indietro di qualche anno, nel giugno del 2005, era stata eletta a guida dell’Associazione Diana Bracco, prima Presidente donna nella storia di Assolombarda («Finalment ghemm una Sciura President!», aveva commentato Perini che, come detto, amava usare il dialetto milanese nei suoi interventi). Alla guida del gruppo farmaceutico di famiglia fondato dal nonno ed ex Presidente di Federchimica, anche Bracco aveva alle spalle una lunga esperienza nel mondo associativo, che l’aveva portata, agli inizi del Duemila, a essere nominata Consigliere incaricato di Confindustria per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Durante la sua presidenza, Assolombarda avrebbe rafforzato il processo di crescita iniziato ormai da qualche tempo. «Testa d’ariete ma anche schiaccia-sassi», così veniva definita in un articolo apparso sul «Corriere della Sera» del febbraio 2007; l’Associazione era passata, in un decennio, dalle 4.800 alle quasi 6 mila imprese associate, comprese giganti come ENI, ENEL e Alitalia, mentre il 65% delle aziende iscritte avevano meno di 25 dipendenti. Se nel 1997 il terziario pesava per il 29%, dieci anni dopo rappresentava il 44,5% delle associate. L’Associazione milanese continuava ad avere una grande importanza anche a livello confederale: con 121 voti assembleari, infatti, costituiva la prima forza, seguita a distanza da Torino e Roma43.
Si vedano le relazioni dei Presidenti per il periodo (Archivi Assolombarda), nonché i seguenti articoli pubblicati nel «Corriere della Sera»: Diana Bracco e Perini, due poltrone per due, 18 aprile 2005, p. 2 («Corriere Economia»); Assolombarda si affida a Diana Bracco, 6 maggio 2005, p. 25; Assolombarda, là dove osano i falchi, 5 febbraio 2007, p. 5 («Corriere Economia»).

Controlli di precisione avanzata presso la Fluid-o-Tech, Corsico (MI), 2022.
Crolla l’economia di carta, riparte l’economia reale E Milano vive l’euforia Expo
Un’associazione forte, insomma, che si doveva confrontare con una nuova crisi a livello internazionale. La globalizzazione dell’economia, insieme a una finanza senza regole, aveva finito per produrre un sistema opaco. Alla crisi del mercato immobiliare, tra il 2005 e il 2006, erano seguiti i primi default finanziari e, nel 2007, la grande crisi del sistema bancario americano, fino al crollo clamoroso di Lehman Brothers, il 15 settembre del 2008. Il tracollo dell’“economia di carta” avrebbe trasmesso il contagio a molte altre parti del mondo, sancendo di fatto – come ha scritto Patrizio Bianchi – la fine del sogno del libero mercato come regolatore automatico dell’economia e dello sviluppo sociale, sottolineando anche le difficoltà delle istituzioni sovranazionali che scaricavano su Stati e governi nazionali i vari problemi.

Installazione della mostra The Beauty of Imaging alla Triennale di Milano, 2017. Archivio Storico Bracco.
La crisi veniva superata tra il 2009 e l’anno seguente, con un forte intervento statale e un’ondata di pubblicizzazioni di asset privati che superavano i 1.800 miliardi di dollari. In pratica, in un solo anno, su scala globale, si era pubblicizzato quanto si era privatizzato in un trentennio.
Anche Assolombarda faceva la sua parte sotto le direttive del nuovo Presidente Alberto Meomartini, a capo della Snam Rete Gas, eletto nel 2009. Si puntava a potenziare, insieme ad alcune banche, i servizi finanziari personalizzati offerti alle imprese associate. Veniva anche rilanciata la collaborazione con Borsa Italiana, inaugurando un servizio di consulenza – l’Exchange Information Point – per quelle imprese interessate alla quotazione, e si avviavano alcune collaborazioni, la prima delle quali con Confindustria per la creazione del Fondo italiano d’investimento e la seconda con Futurimpresa SGR della Camera di commercio di Milano, allo scopo di fornire un apporto significativo di private equity alle aziende di dimensioni minori. Tra le iniziative del periodo, la nascita di ECOLE – Enti confindustriali lombardi per l’education, una società consortile dedicata all’orientamento e alla formazione che univa, attraverso le rispettive società di servizi, sette organizzazioni del sistema confindustriale: AIOP Lombardia, Associazione industriali di Cremona, Assolombarda, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, UCIMU – Sistemi per produrre.

Edifici di Porta Nuova visti dalla Terrazza del Duomo, Milano, 2024. Archivio ANSA.
Con il 2011, Assolombarda accelerò quel processo di cambiamento iniziato da qualche tempo. Venivano affrontati alcuni passaggi cruciali, si dava corpo a cambiamenti organizzativi sostanziali, si sviluppavano nuovi approcci e, infine, si consolidavano modalità di lavoro innovative. Questo percorso di trasformazione era diretto a modificare in profondità il modo di agire e interagire con le imprese associate, con gli stakeholder esterni e con il territorio. Occorreva superare il modello associativo tradizionale, considerato non più funzionale rispetto alle esigenze del cliente-impresa, e, al contempo, promuovendo il rinnovamento, l’Associazione esprimeva pienamente la volontà di tener fede alla propria missione e di diventare generatore e moltiplicatore di opportunità per le associate. Il punto di partenza era la nuova visione dell’impresa come motore di creazione di valori economici e sociali, e questo specie in un contesto economico poco favorevole. Il concetto diventava ora che “ogni impresa è unica”, e la valorizzazione della sua specificità imponeva un approccio multidisciplinare, il solo che consentiva di trasformare i bisogni in opportunità e di reagire con efficacia all’evoluzione del contesto esterno e alle sue sollecitazioni.
La visione integrata dell’impresa trovava rispondenza nella nuova modalità di lavoro scelta da Assolombarda, ossia quella di fare rete a diversi livelli: dalle imprese al Sistema Confindustria, passando per il territorio e il Paese. «L’Associazione che fa rete promuovendo le reti» era uno slogan che riassumeva il nuovo indirizzo deciso ormai da qualche tempo. Gli esempi non mancavano a partire dal 2010, con il lancio del progetto “Punto Alleanze”, il servizio che promuoveva forme di collaborazione tra aziende con l’obiettivo di favorirne la crescita44.
Si vedano le relazioni del Presidente all’Assemblea per il periodo 2005-2011 (Archivi Assolombarda). Si vedano anche i due articoli del «Corriere della Sera» («Corriere Milano»): Assolombarda, la svolta di Meomartini, 14 maggio 2009, p. 5, e Assolombarda: nuove idee per il rilancio, 14 giugno 2011, p. 6. Cfr. P. Bianchi, La rincorsa frenata..., cit., pp. 251 ss.
Assolombarda cresce con i nuovi territori guardando ai mercati globali
L’11 giugno 2012, nel salutare l’Assemblea generale, Giorgio Squinzi, neopresidente di Confindustria e membro di Assolombarda da lungo tempo, sintetizzava così la situazione italiana: «Vorremmo un Paese normale per aziende speciali». Toccava al nuovo Presidente dell’Associazione, Gianfelice Rocca, in carica dal giugno dell’anno seguente, dopo aver ricoperto la carica di Vicepresidente di Confindustria, presentare un progetto triennale per rilanciare Milano e la Lombardia. Rocca, a capo del gruppo Techint, colosso multinazionale del settore siderurgico, partiva da una chiara evidenza: agli inizi del 2000, nella classifica che riepilogava la capacità di attrarre multinazionali, Milano era davanti a Monaco di Baviera; nel 2013 le posizioni si erano invertite. La città bavarese, insieme a Barcellona e a Lione, rappresentavano un modello di strategia metropolitana che avrebbe dovuto ispirare il capoluogo lombardo. Alla fine del 2013, veniva presentato il Piano “Far volare Milano”, articolato in 50 punti, accompagnato dallo slogan «Ripartire con la città metropolitana». L’idea di fondo era quella di rimettere al centro l’impresa. Ancora Rocca, di fronte all’Assemblea del giugno 2014, ribadiva che «senza le imprese, senza gli animal spirits degli imprenditori, non si va da nessuna parte», e per questo una ventina di progetti furono pensati per dare più forza alle imprese in tema di innovazione di prodotto e di organizzazione.

Impianti produttivi digitalizzati Industry 4.0 dal 2018, Rold, Nerviano (MI), 2024.
Altri progetti, a cui collaborava anche Confcommercio, riguardavano, tra i tanti, il potenziamento delle università e il sostegno alla nascita delle 390 startup individuate nell’area milanese che avrebbero potuto associarsi a costo zero. Al progetto generale, in cabina di regia, collaboravano sia il Comune di Milano sia la Camera di commercio, che si trovavano a operarein un contesto – come ricordava lo stesso Presidente Rocca – contraddistinto «da una burocrazia incredibile e da una tassazione elevatissima», fattori che contribuivano a «schiacciare le imprese».
Il progetto “Far volare Milano” sarebbe corso parallelo alla cosiddetta “Riforma Pesenti”, che avrebbe portato a un nuovo Statuto di Confindustria, approvato nel giugno dello stesso anno. La terza riforma dal dopoguerra riconsegnava una struttura più snella ed efficace e meno costosa. Tra le modifiche principali vi erano la riduzione a 160 membri – circa il 30% in meno – che componevano il Consiglio generale, a soppressione del Consiglio direttivo e la diminuzione di sovrapposizioni funzionali e strutturali, oltre a prevedere degli accorpamenti tra le associazioni territoriali e di categoria.
Gli effetti della riforma si sarebbero visti a partire dall’ottobre 2015, quando divenne operativa la fusione tra Assolombarda e Confindustria Monza e Brianza. La nuova Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza era di fatto la più grande organizzazione imprenditoriale, con circa 6 mila imprese e oltre 300 mila dipendenti.
L’Associazione rappresentava un’innovazione istituzionale di grande portata, dato che i territori di Milano, Lodi e Monza Brianza, insieme, producevano oltre la metà della ricchezza lombarda, ovvero il 12% del PIL italiano.

Inaugurazione dell’Auditorium Giorgio Squinzi, Milano, 2 ottobre 2020. Archivi Assolombarda.
L’aggregazione – come riportava la relazione sociale – si configurava nella direzione della «semplificazione, migliore gestione dei costi e della complessità, integrazione di esperienze e competenze, maggiore significatività in termini di base associativa rappresentata». Di fatto, la fusione certificava il legame tra due territori chiave dell’economia nazionale: quello brianteo, caratterizzato dal manifatturiero dinamico e internazionalizzato delle PMI, e quello milanese, sede di 3.100 multinazionali estere (il 33% del totale italiano) e centro di eccellenza del terziario avanzato, della ricerca e della formazione universitaria. La fusione aveva importanti conseguenze anche per Assoservizi S.p.A., che si rinnovava e modificava la propria denominazione in Assolombarda Servizi S.p.A., a rimarcare la profonda integrazione con l’Associazione di cui continuava a costituire il “braccio operativo”. Nello stesso anno il Presidente Gianfelice Rocca e il Direttore Generale Michele Verna riorganizzano, attraverso un nuovo regolamento, il sistema dei Gruppi merceologici, che passeranno da 18 a 11, introducendo l’elemento delle Filiere. Si trattava di un sistema matriciale introdotto per rispondere alle esigenze delle imprese di ritrovarsi con altre aziende associate con cui condividevano il medesimo mercato di sbocco45.
Cfr. le relazioni del Presidente per gli anni 2012-2018 (Archivi Assolombarda) e alcuni contributi apparsi nel «Corriere della Sera», tra i quali: Assolombarda, Gianfelice Rocca verso la presidenza, 19 aprile 2013, p. 31; Assolombarda, parte l’era Rocca, 8 maggio 2013, p. 33; Milano, Monza e Brianza. La nuova Assolombarda vale il 12% del PIL italiano, 20 ottobre 2015, p. 35; Assolombarda sceglie Bonomi, per nove voti, 13 aprile 2017, p. 37.
La Quarta rivoluzione industriale vede le imprese in prima linea su Europa e globalizzazione
Il processo riorganizzativo, peraltro, proseguiva anche sotto la presidenza di Carlo Bonomi, eletto nella primavera del 2017. Nel maggio dell’anno seguente, infatti, veniva decisa la fusione di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con Assolodi, organizzazione creata nel 1945 come Gruppo degli Industriali Lodigiani. Successivamente, sul finire del 2019, veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione di Confindustria Pavia, nata nel 2001 dalla fusione tra l’Unione degli industriali di Pavia e quelle di Vigevano e Voghera. Entrambe le fusioni hanno seguito un complesso e delicato processo di rappresentanza, reso possibile anche grazie alla nuova nomina come Direttore Generale di Alessandro Scarabelli. Le nuove aggregazioni territoriali avvenivano in un particolare contesto economico caratterizzato da una fase di stagnazione se non di recessione. Tra le questioni più urgenti, vi era la necessità di recuperare competitività nei confronti dei maggiori competitor internazionali. Inevitabile puntare sulla Quarta rivoluzione industriale, sul concetto di Industria 4.0, e per far questo la missione prioritaria per Assolombarda era quella di “spingere il piede sull’acceleratore” e di sostenere le imprese associate in questo percorso di trasformazione. Tra le diverse iniziative, la pubblicazione di una serie di libri dedicati ai temi del momento. Il primo contributo, intitolato Futuro del lavoro, analizzava i cambiamenti in corso – uno su tutti, l’introduzione dello smart-working – per poi suggerire quali adeguamenti portare all’assetto normativo del lavoro. La collana si sarebbe presto arricchita di nuovi libri che trattavano argomenti d’attualità, come, per esempio, il fisco, il “valore dell’Europa”, la questione energetica e la “green revolution”. Nell’estate del 2018, Assolombarda annunciava il suo sostegno alla candidatura di Milano, insieme a Cortina, per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il 3 ottobre 2019, l’Assemblea Generale si svolgeva al Teatro alla Scala, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. In quella sede, Assolombarda per bocca del suo Presidente sottolineava la necessità di realizzare una vera “filiera lavoro” incentrata anche sulla tecnologia e sulla sostenibilità sociale e ambientale.
Nei primi mesi del 2020, Carlo Bonomi veniva chiamato a Roma per diventare il nuovo Presidente di Confindustria, a succedergli è Alessandro Spada, già suo vicario. Il neoeletto Presidente si trova così ad affrontare il periodo della pandemia da Covid-19 che ha costretto il sistema imprenditoriale a ripensare non solo le proprie aziende, ma proprio il modo di fare impresa. La soluzione alla sfida senza precedenti di Assolombarda, oltre a introdurre servizi di supporto alle imprese associate, è creare una nuova visione, una globalizzazione più sostenibile e bilanciata, che diversifichi le filiere e riduca le dipendenze strategiche da pochi mercati. Una volta superati i momenti più bui grazie alla resilienza del sistema imprenditoriale – dopo la pandemia e la crisi energetica con il motto «se le imprese chiudono l’Italia muore» – il territorio di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia riparte registrando primati d’eccellenza, in particolare rispetto alle esportazioni, superando storiche regioni produttive come il Baden-Württemberg e la Baviera. Da questo momento in poi il Presidente Spada, fortemente europeista, può concentrarsi sulle battaglie legate alla necessità di avere in Italia e in Europa una vera politica industriale per permettere all’industria lombarda di “continuare a correre”. Nella primavera del 2023 iniziano i lavori di rinnovo del Palazzo Assolombarda che porterà lo storico edificio firmato da Gio Ponti a essere sempre più aperto alla cittadinanza. Inoltre, in un contesto economico e sociale in cui, soprattutto la città di Milano, registra significative criticità legate al caro vita, all’emergenza abitativa e al tema dell’inverno demografico, sarà lui a spingere l’Associazione a dotarsi del primo asilo nido del sistema confindustriale.

